Epigoni di Proust nel teatro
Beckett, Aspettando Godot
di Claudia Cautillo / 13 ottobre 2022
Proust è uno scrittore talmente unico, e il suo apporto alla letteratura del Ventesimo secolo così prorompente e decisivo, che nella maggioranza dei casi il tentativo di rintracciarne epigoni appare forzato. Tuttavia, proprio là dove meno ce lo si aspetterebbe, ecco che si rivelano al meglio le coordinate della sua eredità, come osserva Margherita S. Frankel nel saggio Beckett e Proust: il trionfo della parola (SE, 2004): «Si è molto parlato di una derivazione joyciana per l’opera di Beckett, ma l’affinità con Proust appare molto più sorprendente, anche se è allo stesso tempo più sottile e latente». Difatti, per quanto a prima vista il maestoso dispiegarsi delle complesse metafore proustiane sembri non avere nulla in comune con lo stile scarno del Premio Nobel irlandese, quest’ultimo «si presenta a noi quasi come una [sua] continuazione, come un Proust che sarebbe vissuto trent’anni più tardi, in un mondo apocalittico che non ha più niente in comune con il mondo che precedette la Prima guerra mondiale».
Beckett, suo fervente ammiratore – tanto da arrivare a paragonarlo a Dostoevskij – nel 1931 a soli venticinque anni pubblicò Proust (Sugarco, 1994), un originale testo di critica letteraria che, come il poemetto Oroscopata dell’anno precedente (Utet, 1973), può soprattutto leggersi quale sorta di canovaccio poetico e filosofico della sua intera opera futura. Caratterizzati dalla prosa contemporaneamente erudita e impertinente, se non al limite del demenziale, tipica di questa prima fase della sua attività letteraria, entrambi presentano già i principali temi proustiani dell’abitudine, della memoria e del tempo. Oroscopata, in particolare, che vinse il primo premio del concorso per inediti della casa editrice Hours Press, organizzato dal romanziere Aldington e dalla poetessa Cunard, esigeva come regola il non dover superare i cento versi e l’avere come tema, per l’appunto, proprio il tempo. Beckett accettò la sfida scrivendo velocissimamente, nel giro di una sola nottata, un componimento volutamente ambiguo – infarcito tanto di citazioni nascoste e arcani accademismi quanto di uno sbeffeggiante turpiloquio – nel quale, seppure la critica ha giustamente riconosciuto l’influenza della scrittura sperimentale e profondamente innovativa di Joyce, sono nondimeno presenti notevoli attinenze con i concetti dell’anti-accademismo, del contro intellettualismo e della critica al naturalismo che costituiscono le fondamenta stesse della Recherche.
Infatti, lontano dall’essere «un’arguta e superficiale esibizione di cultura esoterica», come lo definirà la saggista americana Deirdre Bair in Samuel Beckett. Una biografia (Garzanti, 1990), che nel 1981 le valse il National Book Award, Oroscopata è piuttosto una prova audace e dissacrante che prende spunto da un aneddoto contenuto in Vita di Cartesio del teologo seicentesco Adrien Baillet (Adelphi, 1996), che il giovane Beckett stava leggendo in quel periodo. Scoprendo infatti che Cartesio fosse restio a dichiarare la propria data di nascita, temendo che qualche astrologo ne riuscisse a predire quella di morte, Beckett vi trova lo smitizzante aggancio con l’argomento del concorso poetico sullo scorrere del tempo, cui darà seguito con l’acuta trovata dell’uovo. Il poemetto si apre con Cartesio che dà un uovo al suo servitore Gillot, affinché glielo cucini. Però è troppo fresco, così lo scienziato si raccomanda a Gillot affinché aspetti che sia abbastanza guasto e vecchio prima di prepararglielo. Scorrono versi in cui Cartesio domanda a che punto è l’uovo, alternati ad altri in cui si lascia andare a criptiche ma dottissime dissertazioni. Sul finire dell’elaborato poetico, finalmente l’uovo raggiunge il giusto grado di deterioramento affinché possa essere cotto e mangiato.
Ma al di là della concordanza dei contenuti, e sebbene in Oroscopata le caratteristiche sopra le righe dello stile e della lingua siano piuttosto distanti da quelle di Proust, per contro non va trascurata la sottile vena di umorismo e ironia che sottende a molte pagine della Recherche, aspetto spesso sottovalutato se non addirittura ignorato dalla critica. Peraltro, anziché scemare nei lavori successivi, la sua ascendenza si fa perfino più chiara in quelli della maturità, raggiungendo il suo apice in Aspettando Godot, la cui prima rappresentazione avvenne a Parigi nel 1953. Scritto in francese come la maggior parte delle proprie opere – il titolo originale è infatti En attendant Godot – in questo che è senza dubbio il suo capolavoro, nonché una pietra miliare del teatro del Novecento, non poche sono le analogie con gli aspetti più salienti della Recherche. Nella stessa vicenda dei due vagabondi Valdimiro ed Estragone, seduti da soli sotto un albero spoglio in una deserta strada di campagna, ad aspettare un certo Godot che ha dato loro appuntamento ma non arriva, Beckett riprende e sottolinea lo sguardo lucidamente impietoso che Proust riserva ai rapporti umani, dall’amore all’amicizia, come quando ne Il tempo ritrovato arriva a far esplicitamente pronunciare al Narratore: «l’artista che rinunci a un’ora di lavoro per un’ora di chiacchiere con un amico sa di sacrificare una realtà per qualcosa che non esiste (gli amici essendo tali solo in quella dolce follia che ci prende nel corso della vita, alla quale ci prestiamo, ma che in fondo alla nostra coscienza reputiamo essere l’errore di un pazzo il quale credesse che i mobili vivano e parlasse con loro)».
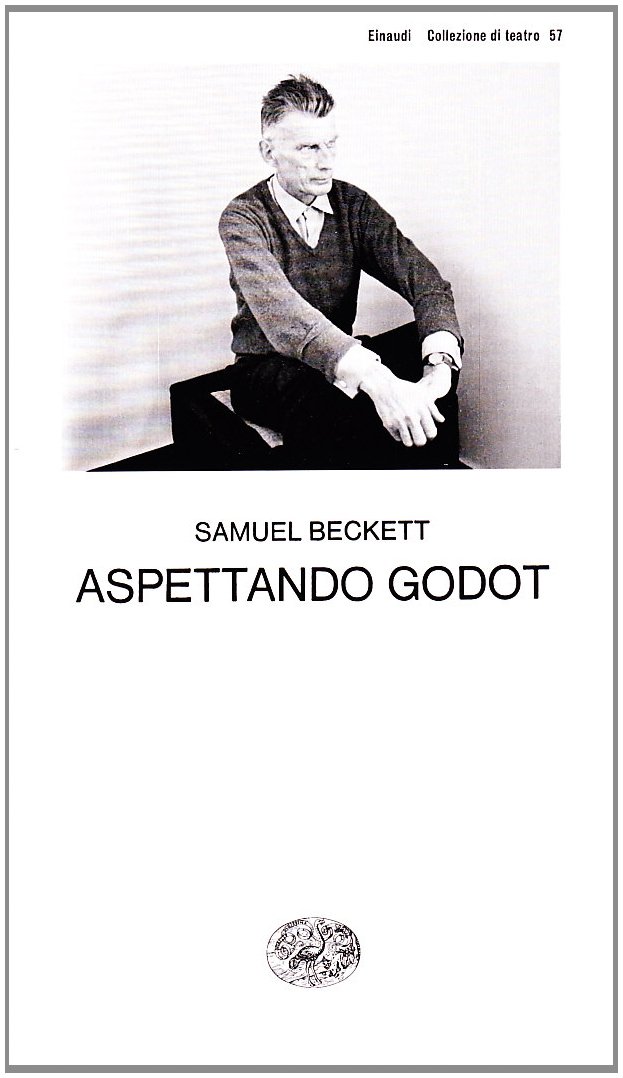
Crudezza proustiana, ci dice Sergio Moravia nella prefazione all’edizione Sugarco (1978) del citato saggio su Proust, nata dall’esigenza del drammaturgo irlandese di contrastare certa critica che stava prendendo piede in quegli anni, superficialmente volta a edulcorare le reminiscenze infantili del Narratore e il suo appassionato amore per la mamma e la nonna, così come ristretta nell’ottica di una consolatoria lettura da lieto fine del complesso impianto filosofico riguardo la vita, la letteratura e l’arte. La grandezza di Aspettando Godot, per Moravia, consiste dunque nell’aver riconosciuto, compreso e valorizzato quel sentimento di vacuità di ogni affetto umano già espresso nella Recherche, rinnovandolo nel pessimismo e nella solitudine di una tragicommedia costruita intorno alla condizione dell’attesa. Stato esistenziale, avverso a ogni moralismo, che trova aspetti di contiguità anche con la capacità istintiva e innata propria a ogni essere vivente, vale a dire quell’abilità di nascondersi, di preservare il proprio isolamento, che i filosofi materialisti del Settecento chiamavano gravitation sur soi – e così di frequente tacciata di asocialità, egoismo, alienazione – di cui ci parla Proust a proposito del piacere di leggere (Il piacere della lettura, Feltrinelli, 2016), dal quale gli altri tendono continuamente a sottrarci per richiamarci a loro.
Se infatti, per Proust, quella gravitazione su se stessi equivocata e minacciata è un istinto fondamentale e un diritto, la cui rivendicazione è la condizione della propria felicità, Vladimiro ed Estragone non possono o non vogliono uscire dalle circostanze del proprio ombelicale estraniamento, persuasi come sono che l’essere fuori da tutto, cristallizzati in un eterno presente che tornerà a scorrere solo quando arriverà Godot – per quanto non sappiano neanche esattamente chi sia o che aspetto abbia, né conoscano con certezza luogo e orario dell’appuntamento che hanno con lui – rappresenti per loro circostanza irrinunciabile e unica possibile via di salvezza. Tempo immobile, dunque, nel quale rifugiarsi rifiutando ogni opportunità di azione o cambiamento, tanto da far credere che il vero protagonista della storia sia in realtà assente. Come nella Recherche, dove il personaggio principale non è esattamente il Narratore quanto piuttosto il Tempo, all’interno del cui flusso lui e le altre figure si parcellizzano, dissolvono e ricompattano in continuazione nell’insieme cangiante di un molteplice Io, qui Valdimiro ed Estragone sono due memorie volontarie che dimenticano tutto, impenetrabili, incomprensibili e inafferrabili alla pari degli altri tre attori della pièce – Pozzo, il proprietario terriero che tiene al guinzaglio il suo servitore Lucky e l’anonimo giovane messaggero di Godot – come loro presenze fluttuanti disperse in un mondo senza ieri né domani.
Nell’astrattezza del Godot, o più esattamente nella sua totale apertura di significato, attraversata dalla reiterazione a più riprese della stessa frase: «quel che si deve fare è passare il tempo», tanto quanto nell’identico ripetersi delle medesime scene e dialoghi sia nel primo che nel secondo atto, tranne che per un paio di cambiamenti senza nessuna incidenza – Pozzo nel frattempo è diventato cieco e sull’albero è spuntata qualche fogliolina –, unitamente all’abolizione sia dell’azione che della trama, può leggersi in trasparenza il debito nei confronti della mutevole indefinitezza dell’universo proustiano, con la sua impalpabile successione di eventi al di là di ogni trattazione logico-consequenziale, senza vera e propria concatenazione né scioglimento, agenti nel segno dell’unico nesso di una labile traccia di stati d’animo, sentimenti ed emozioni prigionieri del tempo.
E, così come l’immenso edificio della Recherche è soprattutto il racconto di una vocazione alla scoperta di sé, l’instancabile costruzione da parte del Narratore, a ritroso, del significato della propria esistenza, Vladimiro ed Estragone ne rovesciano e ricreano la domanda, nell’attesa che nella loro dimensione senza memoria e priva di passato si manifesti un fondamento di senso che la giustifichi. Ricerca di un’identità cui Beckett, come noto, si è sempre rifiutato di fornire spiegazioni, arrivando a pronunciare la celebre frase: «se avessi saputo chi è Godot l’avrei scritto nel copione», ma che tuttavia continua a rivelarsi incessantemente, animata come l’ansia d’indagine che muove il Narratore, punto d’incrocio tra noto e ignoto, tra ciò che è e ciò che da noi viene percepito, esplorato e analizzato.


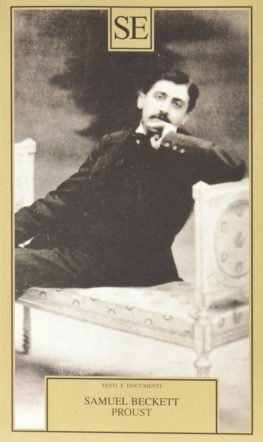



Comments