“Gli sterminati campi della normalità” di Nick Burd
di Cristiana Saporito / 23 giugno 2012
Dade non si vede. Non si vede bene, non si vede abbastanza. Lo specchio è buio, sempre appannato. Starnutisce la sua immagine come una forma di allergia. Sputa briciole di petto, capelli a singhiozzo, camicie sbiadite che sublimano sulle sue spalle. E che gli altri invece intercettano benissimo.
Perché se lui fa fatica a conoscersi o a identificarsi, la gente ci riesce benissimo. È un “frocio” è questo è chiaro a tutti, è la superficie più riflettente del reame.
Ed è altrettanto chiaro che sia lui il protagonista assoluto del primo romanzo di Nick Burd Gli sterminati campi della normalità (Playground). Sguazziamo a Cedarville, una tranquilla cittadina dell’Iowa dove è bello comprare tappeti per officiare funerali alla polvere. E poi lasciarla soffocare piano, sotto i piedi e la ciniglia.
Dade respira ogni giorno il festival della buona creanza, la ridente provincia che ride soltanto per rinfrescare l’intonaco. Si scontra col naufragio dei suoi genitori, una famiglia alla deriva in cui le zattere si sfiorano illudendosi di aver toccato terra. Il padre s’iscrive a un corso di poesia per trovare se stesso. E nella strenua ricerca della propria identità deve accontentarsi di aver urtato un’altra donna e di reputarla più interessante di sua moglie. La madre ha ceduto all’idea di trasferirsi, ha ceduto la sua campagna nel Midwest, i silenzi delle foglie che inghiottivano il suo cuore. Si è rassegnata alla piscina, alle villette appiattite dalla stessa vernice, alla vita omologata. E poi ha saltato il fosso. Ha assunto farmaci per sentirsi meno triste e poi felice e poi soltanto per rimanere a galla. E in tutto questo marasma dipinto d’abitudine, Dade comunque è chiamato a vivere. Deve farlo lo stesso. Per il suo corpo, per il suo orologio che ha ancora tanti giri di lancette, per tutto quello che scalpita al di là del portone. Il suo ultimo anno di liceo, l’università che occhieggia sulla soglia, con tutti i mondi da assaggiare dentro un bicchiere o in qualche abbraccio da cortile.
Intanto c’è Pablo, il suo compagno di scuola attraente e popolare. Il «sexicano», che vorrebbe corteggiare l’opinione migliore, giocare a football e piacere al suo pubblico. Ma non sa farlo per sempre. Non gli basta sfoggiare la sua ragazza ammirata, graziosa come una menzogna. Perché spesso ha bisogno del suo “amichetto” più fragile e schernito. Ha bisogno di schiacciarlo contro un cuscino e di sentirsi maschio, anche con lui. Salvo poi salutarlo a stento davanti al suo gruppo e rinnegare quegli attimi, come se a catturarli fosse stata un’altra persona, come se si fossero sciolti dentro un’altra stanza, mentre lui era in cucina a strizzare una birra.
Dade non fa che inalare ipocrisia. Come etere, più ottenebrante dell’erba fumata di continuo. Nei genitori che non si accorgono di lui e di ciò che vuole. E che si raccontano la stessa favola monca. Nel suo amante che respinge l’idea di appartenere a una schiera additata. Nel vicinato che sotterra tragedie tra le tovaglie di qualche banchetto e che preferisce sempre quelle degli altri, per sentirsi al sicuro. Nell’America benpensante, ovattata e pulita, lavata con tante preghiere, che anela sempre qualche nemico, qualche diverso più debole su cui puntare il mirino. Per declamare a se stessa il copione del paese vincente, del cittadino migliore, meravigliosamente “normale”, totalmente rispondente ai canoni della pubblicità. O almeno a quella da prima serata. In questo Nick Burd non fallisce la missione. È la quotidianità quella che gli interessa fotografare. E azzecca tutti i click. In modo deciso e calibrato. Prendendo perfettamente le misure del disagio.
È un atto d’accusa il suo? È uno scatto, la docu-vita di un ragazzo qualunque che affronta più spine. Che s’imbatte nell’apparente perfidia di altri insicuri. Non occorre scagliare troppe condanne. Quelle emergono da sole, siamo noi stessi a infliggerle alla nostra strada. Con le scelte deviate, quelle rassegnate, quelle che accettano il corso delle cose. E poi lo sentono franare addosso al proprio sangue. Dade non viene accuratamente descritto. C’è qualcosa in lui che resta indefinito, come la sua propriocezione. Qualcosa che lo rende più sfuocato, a una certa distanza. Lo stesso qualcosa che, scrutato attentamente, tendendogli la mano, lo rende chiunque. Nostro figlio, il nostro amico, una parte di noi.
(Nick Burd, Gli sterminati campi della normalità, trad. di Andrea Misuri, Playground, 2011, pp. 250, euro 13)


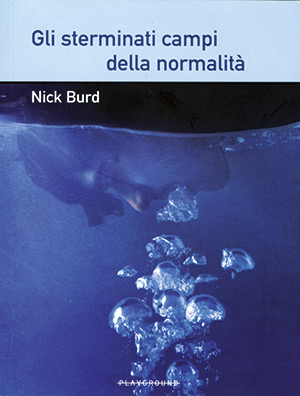



Comments