“L’unico scrittore buono è quello morto” di Marco Rossari
di Cristiana Saporito / 26 gennaio 2012
C’era una volta un paese lontano, tra gli infissi dell’ultimo cielo. E lì viveva un omino, schiacciato dal peso di troppe parole, che per non soffocare doveva per forza appoggiarle su un foglio. Farle sgorgare per liberarsene un po’. Potrebbe essere un ottimo inizio, forse. Ma non è quello di questo libro.
L’ispettore si chinò sul cadavere. Lo vide straziato, come se ancora soffrisse, come se stesse tremando dell’ultima frase, dipinta sui muri, increspata nei biglietti che non spedì mai. Anche questo potrebbe convincere, sempre forse. E comunque non è il nostro caso.
E allora qual è il vero avvio? Come comincia la nostra storia?
Non è così facile rispondere. Perché nell’ultimo testo in uscita a gennaio di Marco Rossari L’unico scrittore buono è quello morto (Edizioni e/o, 2012), la trama è molteplice, rincorsa dai suoi doppi, stremata dai riflessi delle sue immagini, un minotauro di specchi come quello di Dürrenmatt.
L’autore ci prospetta mille scenari, versioni stridenti di un’unica voce: quella di chi scrive. Traccia per noi foreste di ipotesi paradossali, strampalate e cocenti.
Come sarebbe, ci/si domanda, se un ostinato produttore di righe e capitoli si vedesse respingere ogni romanzo, inviasse manoscritti a qualsiasi editore, brindando con sua moglie a una nuova stagione, per poi accorgersi che di fresco c’è solo una ruga e un corridoio d’attesa senza finestre?
E cosa accadrebbe se il frustrato in questione fosse James Joyce? Se il padre del flusso di coscienza fosse soltanto il figlio d’infinite sfortune, da trascinare con sé nella cieca corrente di pensieri già spenti?
Se fosse uno di noi, uno che prova e fallisce, che rimescola i suoi inchiostri e non fa mai centro?
Si tratta solo di mero talento o anche le epoche fabbricano i loro possibili eroi?
E poi piovono altri esempi. C’è un tale W.S. accusato di plagio, perché ciascuna delle sue opere richiama o risucchia qualcosa di precedente. Ed è reale, probabilmente, perché calpestiamo lo stesso terreno, perché gli umori dei giorni sono tramati dagli stessi conflitti, perché le vicende d’amore e di guerra finiscono col somigliarsi, anche oltre i secoli. Ma il merito e la virtù di chi le racconta è renderle uniche, non sole ma differenti, avvistabili a distanze millenarie. Battezzarle di bellezza, codificarle sotto altra lingua, pur se già accadute altre innumerevoli volte. «Metterci la poesia» , come aggiungerà William per discolparsi.
Perché il suo Romeo non è uguale a nessuno, ed è dentro ogni cuore sbucciato, in ogni sentimento che incontri un ostacolo, diverso ed eterno, come i versi che vincono il tempo.
C’è chi si perde nel mito di Kafka, dove ogni cosa assume il suo nome, dove città, fiumi e bordelli respirano l’identico suono di lui che ci visse e che fuggì. Una Praga bollata come “kafkania”, perché lo scrittore ridisegna le strade, tratteggia nel sogno le mappe di chi le attraversa, una topografia di stelle sempre aperte per chi guarda in alto. E poi sempre più in basso.
Grondano altre esistenze, vite più anonime e per questo assolute di scrittori che regrediscono, che dopo aver sfornato decine di successi disimparano se stessi, corrono a marcia indietro nell’emissione del linguaggio, decostruiscono periodi, arretrano a tal punto da farfugliare monosillabi, da arroccarsi nell’abbraccio della lallazione. Così tanto da non essere più degli scrittori, ma da poterlo diventare. Anche più di prima.
Ci sono quelli ormai circonfusi di un’aura di trionfo, quelli di moda, inseguiti da applausi voraci, qualsiasi cosa facciano, qualsiasi starnuto riescano a firmare, quelli che cercano il dissenso per sentirsi ancora vivi, per capire che il pubblico li ascolta davvero. E che s’imbattono sempre nella stessa reazione entusiasta, sordomuta e incrostata nel già letto e saputo.
Rossari esplora il parco polimorfo delle creature letterarie, le interminate varianti di artisti e il loro rapporto con la creazione, la gelosia verso il proprio frutto o l’ossessivo bisogno che venga assaggiato.
Accende il suo focus su quello che vuole sparire, eclissarsi dai propri lemmi come da un ruolo che affigge su carta, che impicca ai doveri dell’identità. Perché chi scrive esce allo scoperto, si marchia a fuoco e si fa riconoscere, anche se le sue battute sono in bocca a qualcun altro. Perché anche Tolstoj non può scampare a quello che affermano i suoi personaggi, come gli ricorda un intervistatore alla radio, in una delle puntate surreali di questa passeggiata.
Un affresco esilarante, una radiografia eccellente dello scheletro d’autore, con le sue ossa ritorte, le sue artrosi emotive, la paure osteoporotiche di essere ignorato o troppo compreso.
Un libro che chi legge userà da manuale per capire chi scrive. E che chi scrive non può non avere. Non fosse altro che per sentirsi nella sua stanza, circondato da un popolo di folli colleghi.
(Marco Rossari, L’unico scrittore buono è quello morto, Edizioni e/o, 2012, pp. 224, euro 16,50)


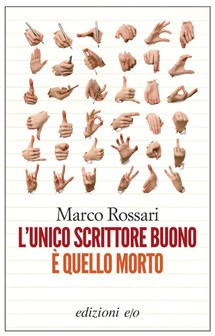



Comments