Libri
Uno sguardo su Daphne du Maurier: sulle tracce di Rebecca
Alla scoperta di un immaginario nei racconti giovanili
di Daria De Pascale / 31 ottobre
Da qualche mese sono alla scoperta di Daphne du Maurier, autrice del primo Novecento nota in Italia soprattutto per aver scritto un romanzo, Rebecca (1938), e un racconto, Gli uccelli (1952), da cui Alfred Hitchcock ha tratto dei film di successo.
Stregata dalla sua voce inquieta, dalle sue due anime in perenne contrasto – una più lieve e gentile, l’altra più forte e viscerale – osservo il modo in cui il suo vasto immaginario ha preso forma un libro alla volta, in cui ogni elemento ha trovato il proprio posto nel tempo, dopo essere magari per anni sprofondato nell’oblio. Per via di cose, è da Rebecca che trovo giusto cominciare, con l’idea di seguire più avanti altre strade e vedere dove portano.
Nel 2011 è uscita in Inghilterra The Doll. Short Stories, una raccolta delle sue early stories inizialmente apparse su riviste inglesi tra gli anni Venti e Trenta, poi ripubblicate in un volume unico negli anni Cinquanta, finito fuori commercio e ritrovato solo dopo lunghe ricerche da un’antiquaria della Cornovaglia. Alcuni più riusciti, altri meno, com’è spesso per i racconti giovanili, essi mostrano comunque tutti l’angoscia di una ragazza appena ventenne, che riversa nella scrittura le immagini morbose, cariche di orrore, che affollano la sua mente.
Ne emergono temi universali, raccontati da una voce ancora a tratti acerba ma già potente: la perdita di innocenza raccontata in “East Wind”, in cui su un’isola quasi edenica, che non conosce passione e violenza, arriva una nave di marinai a portare il peccato, «una sorta di follia che sembrava ricadere sugli abitanti di St. Hilda’s»; e altri, più personali, che matureranno nel tempo, come la sensazione dell’impossibilità di un amore vero rappresentata nell’amaro racconto in forma epistolare “And His Letters Grew Colder”, che più che cinismo rivela una disillusione già profonda verso le relazioni umane.
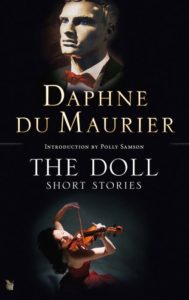
Più di tutto però appaiono per la prima volta figure, già chiare e ben distinte, che faranno la grandezza di alcune delle sue opere successive. È il caso del Reverendo James Holloway, l’affascinante religioso privo di moralità di “And now to God the Father”, probabile antecedente di Francis Davey, il parroco albino del romanzo del 1936 Jamaica Inn.
Ma soprattutto dell’oggetto dell’amore ossessivo del protagonista di “The Doll”, il racconto forse più conturbante della raccolta, una giovane donna sfuggente chiamata Rebecca. Già bella in quel suo modo disturbante, Rebecca – con gli stessi capelli neri e selvaggi, gli stessi occhi grandi e la pelle chiara – esisteva nell’immaginario di Du Maurier da molto tempo, prima di trovare il proprio posto nel romanzo che ne prende il nome. E anche questa Rebecca per così dire originaria ha un magnetismo, una forza di attrazione tale da rimanere nella memoria di per sé, lei con la sua assurda, in qualche modo innocente eppure orrenda perversione.
In Rebecca Notebooks, una serie di note sul romanzo scritte a quasi quarant’anni di distanza dalla sua prima pubblicazione, Daphne du Maurier si stupisce del successo di Rebecca rispetto ai suoi altri romanzi: «Quando il libro è finito lo metto da una parte, si può dire, una volta per tutte. Con Rebecca è stato più difficile, perché continuo a ricevere lettere da tutto il mondo da persone che mi chiedono su cosa ho basato la storia, e i personaggi».
Con un certo candore svela anche il modo in cui il romanzo è nato, mentre viveva ad Alessandria d’Egitto insieme al marito, nei tardi anni Trenta, e come i vari elementi si sono combinati fino a quando Rebecca non ha preso forma in ogni suo dettaglio: «Una bella casa… Una prima moglie… Gelosia… Un relitto, forse in mare, vicino alla casa».
Sarà forse per il modo in cui ha aperto la sua anima in quel libro, al punto da vederlo come una parte di sé, ma in quelle note du Maurier non sembra avere coscienza di come in Rebecca ci sia qualcosa di pregnante, un nucleo profondo di sentimenti oscuri a cui ci si avvicina una pagina alla volta e da cui si è via via sempre più attratti.
Anche questo romanzo ha in effetti qualcosa di morboso. C’è una ragazza senza nome, con davanti un futuro incerto, che si trova a sposare uno degli uomini più ambiti della società inglese, Maxim de Winter, la cui prima moglie, Rebecca, è morta l’anno prima in mare. La ragazza diventa la nuova Mrs de Winter, ma l’ombra di Rebecca la segue dal primo momento e si trasforma in un’ossessione quando si trasferisce a Manderley, la grandiosa residenza della famiglia de Winter.
La cura, la precisione con cui l’autrice riesce a portare sulla pagina il disagio della ragazza, la sua impossibilità di entrare a far parte del mondo del marito; la delicatezza con cui coglie il mutare invisibile degli stati d’animo non solo della protagonista ma anche delle persone che le ruotano intorno – del marito e della sua famiglia, ma forse anche di più della servitù di Manderley, a cui la ragazza è più vicina a livello sociale e da cui proprio per questo si sente inesorabilmente giudicata – rappresentano la vera grandezza dell’autrice.
Che ha una capacità più che rara: coniugare la ricerca più profonda dell’animo umano con la costruzione di una narrazione lieve e avvincente, di quelle che fanno provare il desiderio di “sapere come finisce” spesso svilito dalla letteratura alta – e che lei è in grado di spingere fino al confine estremo del romanzo, con intuito e comprensione del senso tutto umano per la narrazione.

Rebecca è trascinante. Daphne du Maurier è una maestra del non detto, sopra cui riesce a costruire un incubo umanissimo, fatto di molte sofferenze incrociate, che fino all’ultima pagina è difficile da dipanare. Chi lo sa se una chiave del grande successo del romanzo (tra i dieci libri più venduti negli Stati Uniti negli anni 1938 e 1939) non stia proprio nel modo in cui la vicenda dei de Winter sia specchio di molte altre sopraffazioni, e racconti in filigrana le storie di molte altre donne schiacciate da presenze ingombranti, da aspettative troppo elevate, da vite che non si aspettavano di vivere e che le frantumano.
Le tracce che il romanzo lascia una volta finito hanno proprio a che fare con quell’oppressione, con i suoi elementi più angosciosi: l’ombra invadente di Rebecca de Winter, la sua bellezza, la perfezione inarrivabile di quella «figura alta e snella, dal viso bellissimo, una che possedeva il dono di attirarsi le simpatie di tutti. E alla quale era facile voler bene».
E poi Manderley, la casa in Cornovaglia la cui presenza aleggia in tutto il romanzo, quasi non fosse un luogo ma un’entità, con le sue enormi stanze tutte arredate dal gusto elegantissimo di Rebecca, l’ala ovest a cui non è opportuno per la protagonista accedere, e soprattutto gli alberi, i fiori, i sentieri nascosti nell’immenso parco che portano fino al mare – così come la cosiddetta Happy Valley, un pezzo di bosco incantato, bello come sono solo i boschi dei sogni.
Anch’esso ha un antecedente in un racconto incantevole di The Doll, chiamato per l’appunto “Happy Valley”. In esso la protagonista è inseguita da una sensazione costante di déjà-vu, e i sogni del suo dormiveglia – e più tardi anche la realtà, su cui lei non riesce però a fare totale affidamento – sono pervasi di immagini di un bosco che lei non vorrebbe mai lasciare, al contempo splendido e inquietante in un modo sottile: «Lì ci sarebbe stato il muschio, le foglie fresche degli alberi, e il mormorio cadenzato di un torrente che le arrivava alle orecchie. Avrebbe trovato un posto tranquillo in cui non la avrebbero derisa, si sarebbe rannicchiata e nascosta lì».
In “Happy Valley” lo scenario di Rebecca è già pronto, in attesa di prendere vita: una ragazza sola, un po’ svagata, che incontra un uomo che la vezzeggia e la deride bonariamente per il suo sognare a occhi aperti – il suo inspiegabile vivere sempre qualcosa di vagamente familiare, come già vissuto; una grande casa, e un parco in cui la protagonista può nascondersi e riposarsi dal tormento di persone che non riescono a comprenderla – persino quelle amate, come la zia con cui la ragazza vive all’inizio del racconto, contraltare perfetto della zia Patience con cui un altro personaggio di Daphne du Maurier, Mary Yellan, si trova ad avere a che fare in Jamaica Inn.
È tutto già lì, nella mente e nelle prime prove dell’autrice, anche se ci metterà anni a trovare la strada giusta. Avvicinarsi alle opere di Daphne du Maurier sentendo le ombre di personaggi già conosciuti, riuscendo a cogliere l’ampiezza del mondo che ha nel tempo costruito, ha un fascino raro, e forse ancora poco esplorato.



 www.flaneri.com
www.flaneri.com