Libri
Gli animali narratori
«Nella vostra lingua di gitane, una lingua che più non si sa»
di Priscilla Santoro / 18 settembre
Scrive Lev Tolstoj nel proprio Diario: «Se tutta la complessa vita di molti passa inconsciamente, allora è come se non ci fosse mai stata» (Garzanti, 1924, p. 90).
Nel saggio del 1917 L’arte come procedimento (che oggi si legge in italiano in I formalisti russi. Teoria della letteratura e metodo critico, a cura di T. Todorov, Einaudi, 1968, pp. 65-94), Viktor Šklovskij adopera questo breve passo per significare l’«automatismo» della percezione che «si mangia gli oggetti, il vestito, il mobile, la moglie e la paura della guerra» (p. 82), quel meccanismo, cioè, per cui gli oggetti finiscono via via con l’essere recepiti dall’osservatore come usuali: «L’oggetto si trova dinanzi a noi, noi lo sappiamo, ma non lo vediamo» (p. 83). È con lo «straniamento», inteso come pratica artistico-letteraria capace di sottrarre la materia narrata alla convenzionalità della prospettiva canonica, afferma Šklovskij, che essi vengono invece presentati sotto una nuova luce, rivelando lati inediti.
A tale scopo (vale a dire intensificare e, contemporaneamente, rinnovare l’impressione ricavata dal lettore) rispondono specifiche modalità linguistico-descrittive, formali e strutturali, nel cui novero si conta anche l’adozione di una prospettiva che s’identifica con quella di un personaggio altrimenti secondario, tradizionalmente subordinato ai grandi protagonisti della storia per ragioni economiche, per ceto sociale, per età, per genere o persino per specie animale.
Narratore «straniato»: il cavallo tolstojano
Šklovskij medesimo propone il caso del racconto tolstojano Cholstomér (Storia di un cavallo, 1876), dove al narratore eterodiegetico della parte introduttiva e di quella conclusiva si sostituisce, nei capitoli centrali, la voce autodiegetica del purosangue pezzato protagonista, cosicché «le cose vengono straniate non dalla nostra, ma dalla percezione che ne ha il cavallo» (p. 83). Questi, chiamato Mužik I ma soprannominato Cholstomér (Passolungo) per la rapidità nella corsa, incomincia a raccontare ai giovani cavalli dell’allevamento dov’egli è adoperato quale bestia da soma tutte le proprie peripezie, ripercorrendo e contemporaneamente commentando quegli avvenimenti che nel corso della vita gli hanno svelato la vera natura degli uomini, i quali «si fan guidare nella vita non dai fatti, ma dalle parole» (p. 84).
Esempio assai significativo di tale procedimento narrativo è offerto dalla descrizione «straniata» che l’animale (talmente estraneo al consorzio degli uomini da credere che sarebbe stato curato dalla scabbia da quello stesso scuoiatore presso il quale viene invece condotto per essere soppresso) restituisce circa l’istituto umano della proprietà (L. Tolstoj, I cosacchi e altri racconti, Garzanti, 2019, pp. 317-360: 338):
«Per me la cosa si faceva assolutamente oscura a riguardo del significato delle parole: il suo puledro, il proprio puledro, dalle quali vedevo che la gente presupponeva un legame tra me e il capostalliere. In che consistesse questo legame, non potei allora in nessun modo capire. Solo molto tempo dopo, quando mi separarono dagli altri cavalli, capii cosa significava. Ma allora non potevo assolutamente capire cosa significava che chiamassero me proprietà di una persona. Le parole: “il mio cavallo” riferite a me, cavallo vivo, mi sembravano altrettanto strane quanto le parole “la mia terra”, “la mia aria”, “la mia acqua”. […] Il significato è questo: gli uomini […] amano non tanto la possibilità di fare o non fare qualcosa, quanto la possibilità di utilizzare per diversi oggetti certe parole tra loro convenute. Queste parole, ritenute tra di loro molto importanti, sono le parole mio, mia, che essi usano per le cose, le creature e le materie più disparate, anche per la terra, gli uomini e i cavalli. […] In definitiva, ampliato il numero delle mie osservazioni, mi convinsi che, non soltanto in riferimento a noi cavalli, il concetto di mio non ha nessun altro fondamento se non il basso e animalesco uso umano, da loro chiamato senso o diritto di proprietà».
Da questo passo si deduce che l’adozione di un’ottica «straniata» non comporta affatto un abbassamento tematico-tonale della materia trattata né tantomeno relega l’azione narrativa a quella deformitas di motivi tipica di talune forme letterarie ‒ analizzate nel terzo capitolo de Le forme brevi della narrativa (Carocci, 2020); al contrario, un narratore «straniato», collocando ciò che viene di solito percepito come usuale in una serie semantica diversa da quella che gli è abitudinariamente assegnata, scandaglia una tematica della quale intende svelare le implicazioni oppure isolare particolari componenti, così da individuare le criticità di un discorso, non di rado, complesso.
La profezia post-apocalittica degli animali volponiani
Nella letteratura novecentesca sono numerosi i romanzi che rimodulano la società umana sulla base della voce diretta o indiretta, singola o corale, degli animali ‒ si pensi anche solo alla paradigmatica Fattoria degli animali orwelliana.
Particolarmente interessante il caso de Il pianeta irritabile (Einaudi, 1978) di Paolo Volponi, autore convinto che la letteratura «non deve rappresentare la realtà, ma deve romperla» e che «starebbe proprio ai lettori […] non respingere il libro che non appaia subito accomodante» (Romanzi e prose, a cura di E. Zinato, Einaudi, 2002, p. 1170).
In questo romanzo dal finale incompiuto, «a metà strada tra il genere di fantascienza e quello della favola allegorica» (Andrea Inglese, «Cahiers d’études italiennes», 7), l’intreccio si edifica sul viaggio intrapreso nell’anno 2293, in occasione dell’ultima catastrofe planetaria della terra, da un esiguo quanto eterogeneo gruppo di esseri viventi sopravvissuti. In primis, il babbuino Epistola che, temuto per aggressività ma rispettato per carisma, guida i compagni verso un nuovo utopico regno, vietato all’essere umano: «È meglio se spopolata la terra dove andiamo? – domandò [il nano Mamerte]. Così dice Epistola, ‒ rispose Roboamo, ‒ e a noi sembra giusto» (Il pianeta irritabile, Einaudi, 2014, p. 30). Roboamo è il dottissimo elefante con il dono della parola, capace di citare a memoria la commedia dantesca. C’è poi Plan Calcule, l’oca dalle sviluppate abilità logico-matematiche; infine, il nano sfigurato Mamerte, il quale in virtù della propria conformazione fisica era stato costretto, dalla società capitalistica stigmatizzata nell’immagine del circo da dove provengono tutti e quattro i personaggi (una «microsocietà gerarchica e crudele», scrive Inglese), a vivere come uno schiavo.
In questo caso la voce narrante non coincide con quella di uno degli animali sulla scena (tanto più che oca e babbuino non possiedono facoltà di parola, benché la sappiano comprendere). Questi personaggi zoomorfi tuttavia rappresentano ciascuno un aspetto del mondo naturale o umano su cui Volponi intende calamitare l’attenzione, come suggerito già dai loro nomi: l’istinto animale che, per sopravvivere, nega l’uomo è rappresentato da Epistola, la cui morte alla fine del romanzo si rende simbolicamente necessaria, affinché gli altri possano raggiungere il nuovo regno dove animali e uomini finalmente convivranno; Roboamo è la memoria collettiva di una cultura antica che cerca di auto-salvaguardarsi e di sfuggire alla commercializzazione imperante nella società di massa; Plan Calcule, infine, evoca la reminiscenza della téchne sulla quale si basava il mondo pre-apocalittico.
Questa impostazione dei personaggi di babbuino, elefante e oca contribuisce fortemente alla duplice invettiva di cui il romanzo si fa vettore: in primo luogo, la critica al nucleare, sul quale Volponi si esprime in termini estremi (Volponi e la scrittura materialistica, a cura di F. Bettini, Lithos, 1995, p. 52): «Ero convinto che, se le bombe atomiche le avevano costruite, prima o poi le avrebbero pure tirate, e che la guerra nucleare avrebbe distrutto l’umanità. Era il mio pensiero fisso, ossessivo».
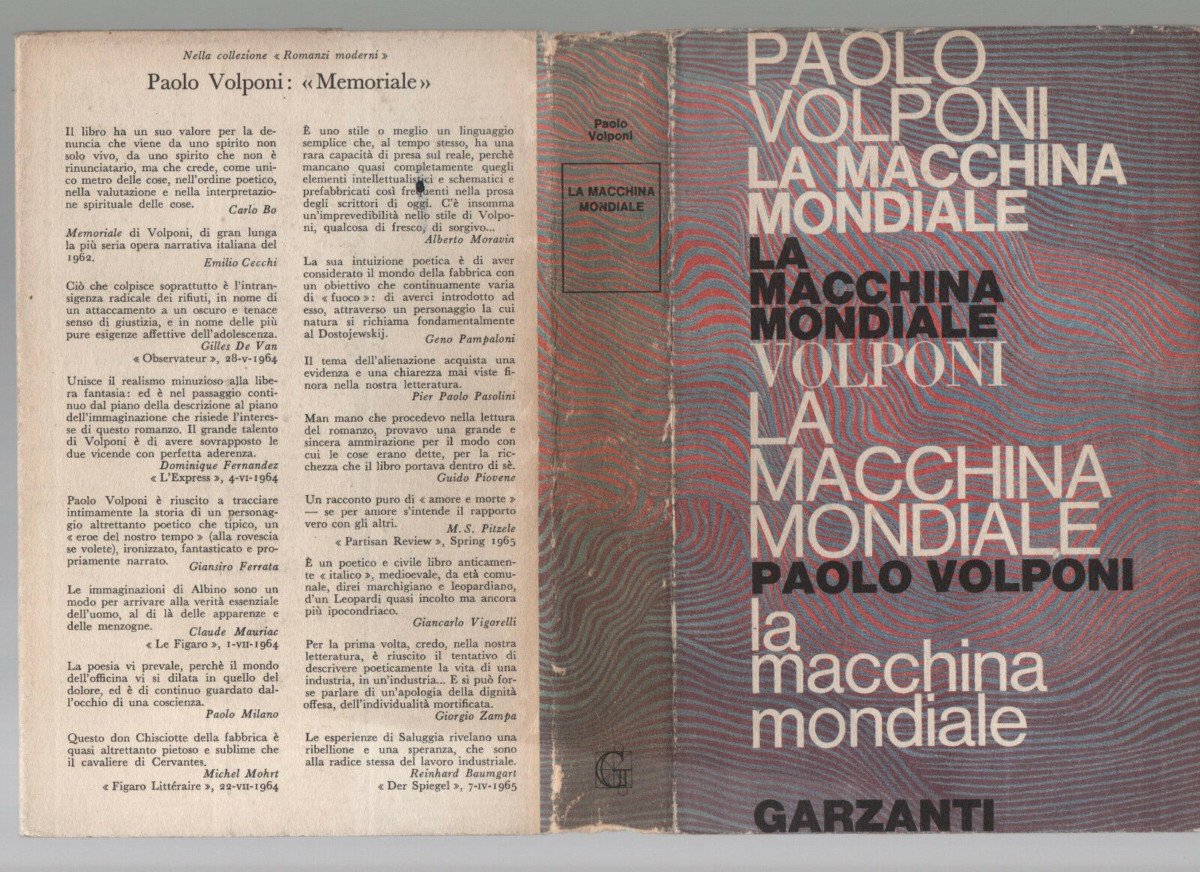
In seconda istanza, la condanna, presente anche nella scrittura saggistica, al «potere economico» che tenta di «sovrapporre i propri termini a quelli storici […] e tornare ad essere tutto, principio e fine» (Scritti dal margine, Lupetti-Manni, 1995, p. 58).
Inoltre, è proprio nel processo di “animalizzazione” dell’uomo che Volponi individua la strategia indispensabile per costruire una società nuova. Quando i tre superstiti dallo scontro con il governatore significativamente chiamato Moneta soddisfano la fame mangiando il foglio di riso che, fino ad allora gelosamente custodito da Mamerte, contiene la poesia della suora di Kanton, sulla ragione umana prevale quella animale: è l’istintiva e primordiale risposta ai bisogni naturali che traduce il «valore simbolico» del foglio conservato nel «valore d’uso» del foglio consumato, come notato ancora una volta da Inglese.
L’originaria animalità ritrovata dall’uomo costituisce dopotutto un tema ricorrente nella produzione volponiana, come mostrano il vincitore del premio Strega La macchina mondiale (Garzanti, 1965) e Corporale (Einaudi, 1974), dove però al flusso narrativo non concorre alcuna presenza zoomorfa.
È insomma anche grazie all’adozione di una simile prospettiva che Il pianeta irritabile si oppone a quella che Italo Calvino definisce, considerandola cifra distintiva degli anni Settanta, la «assuefazione all’ambiente», contro la quale egli anzi confida nella «risposta di una letteratura che non sia mimetica», ma che sia, si potrebbe per l’appunto dire, straniante (Saggi, a cura di M. Barenghi, Mondadori, vol. II, 1995, p. 2934).
***
[Nel testo, il dipinto ispirato a Chostolmér, Il cavallo narratore (1901) di Giovanni Marchini (particolare) e la fotoriproduzione di P. Volponi, La macchina mondiale (Garzanti, 1965)]



 www.flaneri.com
www.flaneri.com