Libri
Proust e il rapporto tra soggetto e oggetto
Platonismo e intenzionalità
di Claudia Cautillo / 15 dicembre
Nessun autore, prima di Proust, aveva celebrato così intensamente il primato assoluto dell’Io. In tutta la sua produzione, inclusa quella giovanile – dalla raccolta di novelle I piaceri e i giorni (1896) al romanzo incompiuto Jean Santeuil, composto tra il 1895 e il 1900 e rimasto inedito fino al 1952 – la realtà si trasferisce e rivive nello spazio interiore, non rifugio o comoda evasione ma unico luogo abitabile dove si colgono le risonanze e i veri significati delle cose, stabilendo le impalpabili equivalenze tra percezione soggettiva e dato oggettivo. Ma ciò che ne fa uno scrittore unico, definendo le coordinate della propria grandezza e sconcertante modernità, è l’aver compreso e superato quel diffuso orientamento del pensiero, tra fine Ottocento e primo Novecento, che respingendo la precedente cultura positivista basata sull’obiettività del reale ripiegava nell’interiorità e nell’irrazionale.
Proust difatti accoglie e va oltre quest’intuizione, disegnando un’idea del mondo totalmente nuova in cui l’Io non è in contrapposizione con l’esterno, piuttosto a esso interrelato in una sorta di rapporto osmotico. Non dunque divisione netta e invalicabile separazione ma reciproco, incessante fluire dall’una nell’altro e viceversa. Come nota Carlo Alberto Redi in Proust zoologo (Carocci, 2022), Proust ha intuito prima di Heidegger la natura periferica – ovvero votata all’esterno – dell’identità, dando luogo a una soggettività mobile e cangiante, sia pure latente e sconosciuta, «un puzzle le cui tessere devono essere rintracciate nell’altro», in ciò che è al di fuori di sé.
Tra i primi critici proustiani, ne Il romanzo del Novecento (Garzanti, 1971), a proposito di Proust fermo con attenzione appassionata sul cespuglio di rose del Bengala, Giacomo Debenedetti esplora non già la concentrazione nella ricerca della loro essenza bensì il suo rovesciamento, vale a dire l’atteggiamento di chi si espone a farsi cercare dalla sostanza profonda di quei fiori. Perché, se l’«intenzionalità» di Husserl afferma che non è possibile dissolvere gli oggetti nella coscienza, cioè che tra noi e l’oggetto che vediamo c’è una distanza, conoscerlo corrisponde a «esplodere verso» per correre di là da sé, nella direzione di ciò che non è l’Io, laggiù accanto alle cose e tuttavia fuori. Ma la folgorante novità di Proust chino sul cespuglio di rose, per Debenedetti, suppone un’intenzionalità non sua ma degli oggetti. Sono loro infatti che devono «esplodere verso» di noi, parlarci e quasi riconoscerci, prendere coscienza di noi che li guardiamo, che vorremmo esplorarli, misteriosi araldi che ci recano l’annuncio di una dimensione inesplorata che esiste dietro i segni di quella visibile, e con la quale siamo in fluida relazione.
È per questo che a differenza del romanzo ottocentesco, in cui l’universo delle idee costituiva l’impalcatura necessaria a farvi muovere i personaggi, seguendo cioè il distacco tra soggettivo e oggettivo, la teoria alla base dell’opera proustiana non è una quinta teatrale ma una sorta di protagonista essa stessa: microcosmo dei personaggi e macrocosmo dei concetti sono inscindibili, a pari merito, nella voce del Narratore e nella polverizzazione della trama. In sostanza, l’impianto de La Recherche è simile a una cattedrale, ovvero uno spazio di connessione tra piani temporali e trame testuali che si diramano vertiginosamente, collegando il prima e il dopo dell’opera, nel confronto con il Tempo. Anche figura cardine e tema ricorrente – le varie chiese immaginarie composte da elementi presi a prestito da edifici reali, o San Marco a Venezia, la cui pavimentazione irregolare permetterà al Narratore di ritrovare il tempo perduto – il topos della cattedrale, ci ricorda Jean-Yves-Tadié in Proust e la società (Carocci, 2022) le cui sezioni Proust aveva ipotizzato, come confidò a un amico, di chiamare “portico” e “vetrata dell’abside”, è direttamente menzionato dal suo autore ne Il tempo ritrovato, quando leggiamo: «avrei costruito il mio libro, non oso dire ambiziosamente come una cattedrale».
Cattedrale dunque come immagine in cui non v’è scissione tra dentro e fuori, paragonabile a uno stato del divenire incarnato dai personaggi, un esempio fra tutti Albertine e le sue metamorfosi: uccello, pianta, paesaggio. «Essere di fuga» per eccellenza, è un po’ Odette, un po’ Andrée, un po’ Marcel. È tutte queste cose insieme e contemporaneamente, senza che si possa mai dire che cosa veramente sia. Ecco il sorpasso della prospettiva del romanzo tradizionale, rispetto al quale La Recherche, «espressione sublime della necessità di Proust di comunicare il disagio della propria condizione», del proprio stare nel mondo – in der Welt Stein – come ci dice Carlo Alberto Redi, non dà per scontata la netta divisione tra soggettività e oggettività bensì la indaga, «SOS che viene da lontano», nel tentativo «di rispondere al “principio di insufficienza”» di Georges Bataille, quello che impone a noi stessi di non schivare gli interrogativi alla base della vita umana.
Di fronte a una realtà incoerente, contraddittoria, in una parola imperscrutabile, condizione dissociata alla quale non sfugge nemmeno l’interiorità dello stesso Marcel, di cui non conosciamo «quali siano i suoi veri sentimenti, i suoi pensieri, i suoi intenti. Sappiamo che essi non corrispondono alle sue parole, ma fino alla fine non siamo in grado di ricostruirli» (Stefano Brugnuolo, Dalla parte di Proust, Carocci 2022), l’eccezionalità de La Recherche consiste nel tentativo di spiegare e conciliare sempre, a dispetto di tutto, il perché di noi nel mondo. Ma la sua missione di rendere intellegibile l’inintelligibile, quello «strumento ottico in grado di far vedere sé stessi. Deformante come un caleidoscopio, riflettente come una lente, rifrangente come la lanterna magica», quale descritto da Roberta Capotorti in Leggere Proust (Carocci, 2022), per sua stessa natura pone il proprio sguardo soggettivo, in rapporto all’oggettività del reale, ora travisandola ora idealizzandola, ovvero mancandola sempre.
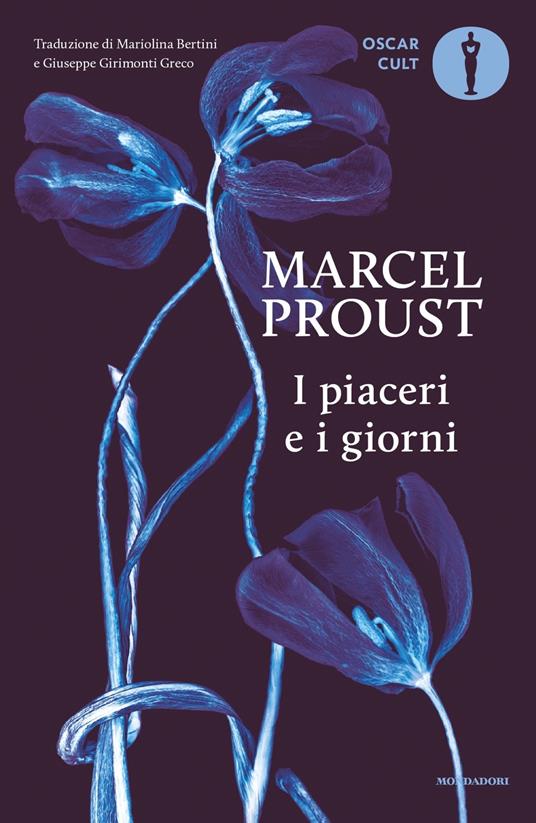
È questa la tristezza metafisica cui allude Ernst Robert Curtius in Marcel Proust (Il Mulino, 1985) poiché, se unicamente la spiritualizzazione della realtà attraverso l’arte può dare senso alla vita, liberando l’essere che è in noi per sottrarlo al regno del contingente e del casuale, tuttavia Proust ci dice che l’amore è una malattia, l’amicizia un’illusione. Certamente le resurrezioni del nostro Io interiore ci salvano restituendoci il contatto con una realtà superiore, ed è questo il compito affidato alla letteratura. Ciononostante il platonismo di Proust, ossia la nostalgia che aspira a ritrovare il fondamento eterno delle cose, tema ostinato de La Recherche, cozza di continuo contro gli abbagli di un legame col mondo deludente, fuorviante o impossibile.
Tale stato d’animo, presente nell’opera proustiana a partire già da I piaceri e i giorni, ripubblicato recentemente da Mondadori (2022) con traduzione di Mariolina Bertini e Giuseppe Girimonti Greco, è il «lieve suono argentino impercettibile e profondo come il battito di un cuore» – che subito riporta al tintinnio della campanella del giardino di Combray de Il Tempo ritrovato – che si trova in Morte di Baldassare Silvande, la seconda novella che compone il volume. Quel flebile suono di campane, «voce presente eppure molto antica», che da un lontano villaggio arriva al protagonista nei suoi ultimi istanti, porta in sé un’importante rivelazione. Come più tardi sarà per il Narratore, che da remote profondità sentirà affiorare «quella dimensione enorme che non sapeva di possedere», in Baldassare risorge il suo Io più autentico e dimenticato, mentre svaniscono le vane ambizioni e i sogni mai concretizzati.
Tuttavia, con i suoi tradimenti e le sue ambiguità, la vita ci delude e disorienta. Gilberte è ora affettuosa ora indifferente, Madame Verdurin al contempo generosa quanto opportunista e malevola, Morel un gigolò egoista e vigliacco, prima disertore infine eroe sul campo di battaglia, la domestica Françoise capace di grande amore e dedizione come di gratuite piccinerie e crudeltà, Bergotte di alto profilo morale ma anche piccolo arrivista, e così via per Albertine, Charlus, Swann e ogni altro personaggio che popola La Recherche. I nostri tentativi di entrare in contatto con quanto è esterno da noi, decifrando ciò che vediamo, non arrivano a risvegliare il fondo nascosto e inesprimibile della vita, impotenti a sapercela spiegare.
Nella dedica Al mio amico Willie Heath, che apre I piaceri, Proust parla dell’esistenza che, «nella sua durezza, ci incalza troppo da vicino» e «ci fa male all’anima, continuamente». Quand’era bambino, l’autore credeva che a nessun personaggio della Bibbia quanto Noè fosse spettato un destino infelice, per via del diluvio che lo costrinse a rimanere chiuso nell’arca per quaranta giorni. Soltanto in seguito capì «che Noè non riuscì mai a vedere il mondo così bene come lo vide dall’arca, benché l’arca fosse chiusa e sulla terra regnasse l’oscurità» perché – come ci dice Lorenzo Renzi ripercorrendo la geniale lettura di Erich Auerbach in Mimesis (Gli elfi e il Cancelliere. In Germania con Proust, Il Mulino, 2015), in Proust la concezione moderna dello spazio-tempo dell’Io si collega a quella neoplatonica per la quale l’immagine dell’oggetto, trovandosi già nell’anima dell’artista, gli rende possibile distaccarvisi in veste di osservatore.
Proust ragazzo aveva quindi precocemente intuito che quello di Noè, già contenendo in sé l’immagine del mondo dietro il buio del diluvio, è l’unico sguardo che permette di abolire la distanza tra soggetto e oggetto, leggendo senza fraintendimenti la realtà nella sua verità. Il solo che può disvelarci l’essenza che giace al fondo di noi stessi e delle cose, dissolvendo le delusioni della vita, la sua malinconia, la sua amarezza, nella continua ricerca del contatto altro che le apra a noi, quell’«intenzionalità» che le faccia «esplodere verso» per svelarci infine il loro segreto.



 www.flaneri.com
www.flaneri.com