Quando il cattivo viene a mancare
Su “Un altro tamburo” di William Melvin Kelley
di Cristiana Saporito / 23 marzo 2020
Una volta lessi un libro intitolato Tra me e il mondo, di Ta-Nehisi Coates, e di tutto quello che ho impattato dentro quel libro, questo passaggio ancora non mi abbandona. Esiste un Paese in cui un padre è costretto a indicare a suo figlio il modo opportuno di agire quando alla guida è fermato da una volante. Come inclinare il busto esibendo sempre le mani e preannunciando cautamente ogni suo gesto, quali formule selezionare per rivolgersi all’autorità, come scendere correttamente dall’auto senza lasciar trapelare qualche avanzo di disappunto.
Tutto un algoritmo di azioni consigliabili tramandate come un cimelio, perché quello che un padre sa quando suo figlio in quel Paese osa circolare come tanti altri figli è che nel suo caso, e in quello di chi come lui ha la pelle di suo figlio, la vita vale meno. Vale un tocco inconsulto, una smorfia non autorizzata, una risposta starnutita in fretta e quel figlio, che è suo ma che sembra giudicato meno figlio di molti ragazzi altrettanto figli, potrebbe non tornare a casa.
Perché è negro. Con una gutturalissima g impunturata nel petto. E questo è sufficiente per essere pattugliato anche negli occhi, reputato un pericolo da chi ti mette in pericolo per amministrare l’ordine e calpestato come si fa con gli scarti d’asfalto. Questo Paese lo conosciamo bene, almeno indirettamente, per come da secoli ha provato a raccontarsi proponendo convinto l’agiografia di se stesso sotto forma di telefilm e operazioni belliche (da dover distinguere con attenzione) e per come fortunatamente altre voci hanno saputo riequilibrare il carico, bilanciando la polveriera sempre incinta di stereotipi da eterni yankee.
Frammenti di cinema e di letteratura di importanza vitale, per narrare una degenerazione che travalica di molto il termine razzismo. Anche se ci sembra che pronunciarlo possa bastare. Il corpo di un Sistema perfettamente truccato, ma in putrefazione accelerata.
Accostarsi a Toni Morrison, a Richard Wright o a Percival Everett squassa ferite che non sappiamo di avere o che preserviamo sottovuoto per sguainarle nelle giuste occasioni, in cui sentire quel dolore che non ha scelto noi. Abbordare Alice Walker, Colson Whitehead o Angie Thomas ci permette di sbranare cinquant’anni in poche pagine, approdare a oggi e comprendere quanto ancora un nero possa essere negro e quanto poco ci sia di incisivamente nuovo sul fronte del rapporto col diverso, declinato qui in senso cromatico.
E ovviamente non solo in quel Paese. Per questo forse Un altro tamburo (NN Editore, 2019, traduzione di Martina Testa), scritto da William Melvin Kelley e pubblicato nel 1962, plana tra queste scarne certezze come l’abbraccio che le cementa. Romanzo complesso, plurivoco e comunque diretto nella sua delicata architettura, decide di afferrarci schierando in campo un’ipotesi attraente, almeno per parecchi.
In una cittadina immaginaria di uno Stato immaginario del Sud di questo Paese democratico e vincente, un giorno, sulla spinta di un singolo atto di coraggio di un certo Tucker Caliban, per anni alle dipendenze di una sana famiglia bianca, ecco appunto quel giorno, in una processione non pianificata, tutta la popolazione del suo stesso colore comincia ad accodarsi, segue una scia immateriale, come fosse una ferrovia sotterranea.
Semplicemente quella gente se ne va, raccatta bambini come bagagli e si incammina verso un altrove spesso imprecisato. Perché andare è più essenziale di sapere esattamente dove giungere. Marciano sentendo un altro tamburo, un ritmo che non si può spiegare, come quello a cui allude Thoreau nel suo Walden.
Ma chi è Tucker Caliban, l’iniziatore involontario di questo osceno innesco? La sua storia si avvia tante nascite prima, rampolla dalle vene di una leggenda che i vecchi di New Marsails ancora dispensano come sciroppo per la gola ai ragazzi dell’emporio. Il primo della stirpe fu l’Africano: uomo titanico prima comprato e poi catturato e ucciso da Dewitt Willson, che però non ne fu mai padrone. Indomito nella sua forza, capace di sradicare catene e cristiani con la leggerezza di chi si sbottona, protagonista di un inseguimento epico, con la sua vastità e un neonato incavato nel braccio.
Fu proprio Willson a chiamarlo Caliban, quella minuzia già orfana, in omaggio a Shakespeare e alla sua Tempesta. E così fiorisce la genealogia di Tucker. Con un sangue turbolento da ritrovarsi dentro. Piccolo, ostinato, ruvido e brillante. Sposa una donna bellissima, che lo asseconda perché innamorata. Riesce ad acquistare la fattoria che vuole nel punto in cui la vuole, si sgancia da un destino di asservimento lungo molte vite e molte perdite e poi un giorno, quel giorno scoperchiante come una detonazione, decide di appiccare fuoco a quella terra conquistata «come se stesse solo piantando dei semi».
Perché è talmente sua che può anche bruciarla. Significa questo possedere qualcosa, permettersi anche di decretarne la fine? Significa questo liberare il futuro? Ma Kelley non ci interroga solo su di lui, segue il suo percorso in parallelo a quello della famiglia Willson, tra le generazioni di servi e proprietari che si sono avvicendate. Da un lato i bianchi e dall’altro i neri? Ovviamente no, perché spartire una casa e viversi attorno traccia legami. Succede, succede nonostante tutto e incasellarsi non impedisce mai di annusarsi e voler valicare quel limite.
David Willson conosce Bennett Bradshaw, attivista affascinante, determinato ma troppo scuro per essere un ideale compagno di college secondo i suoi genitori, eppure quest’amicizia lo scaverà per sempre. Dympha, figlia adolescente di David, incontra Bethrah che si propone come donna di servizio e ne resta incantata. Perché è colta, bella, sensibile, molto più di quanto il suo ruolo di ragazza nera le chiederebbe di essere.
Ognuno di loro, ogni punta di vista privilegiato è stregato da un “eppure”. E l’autore è bravissimo ad ispezionarlo. Quasi tutti i paragrafi sono intitolati con i nomi dei personaggi bianchi e in ciascuno ci si addentra per carpire come osservano l’altro, come provano a circumnavigare quell’universo che pensano minore, come vorrebbero sconfiggerlo restandovi impigliati, o come spiazzano se stessi facendo un passo avanti.
Come ci conferma la sua nota biografica, Kelley conosceva bianchi ricchi (prevalentemente ebrei) e bianchi poveri (operai italiani), e riesce a restituire anche linguisticamente la diversità di ciascuno, la condizione marginale o centripeta, ma soprattutto delinea l’incontro con l’altro come un perenne rischio. I negri restano odiati. Perché ci sono, perché se ne vanno. Perché lasciano un vuoto che la paura farcisce di altro rancore. Perché sono necessari alla sopravvivenza della quiete. Perché sapere chi additare rassicura tutti i giorni mentre li avvelena. E quando il nemico scompare non rimane che impazzire.
Inutile aggiungere che i quasi sessant’anni di Un altro tamburo potrebbero essere anche pochi mesi, potrebbero essere le settimane che verranno e che leggere autori come James Baldwin, Paul Beatty o William Melvin Kelley ci tiene ancorati alle urgenze irrisolte. Agli sbarchi imprevisti. E alle nostre derive.
(William Melvin Kelley, Un altro tamburo, NNEditore, 2019, trad. di Martina Testa, 256 pp., euro 19, articolo di Cristiana Saporito)


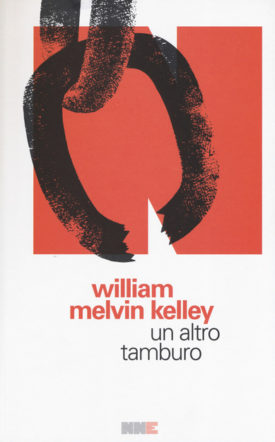



Comments