“L’ultimo ballo di Charlot”: un’intervista sottosopra
di Massimo Paradiso e Fabio Stassi / 8 dicembre 2012
Capita spesso ai lettori di interrogarsi sui retroscena che portano alla pubblicazione di un libro, sugli aneddoti che nasconde, sul percorso personale dell’autore. Meno spesso, forse, pensiamo che possa accadere il contrario, e invece… Eccoci di fronte a un’intervista al contrario: per una volta, è lo scrittore a riempire di domande il suo interlocutore, in fondo, chi può raccontare un libro meglio del lettore stesso? Fabio Stassi, autore di L’ultimo ballo di Charlot (Sellerio, 2012), intervista Massimo Paradiso, il suo personal editor e lettore ideale.
F: Ciao Massimo.
M: Ciao Fabio.
F: Eccoci qui, nella stessa paninoteca dove ti raccontai, tre o quattro anni fa, la prima idea di questa storia e ti feci leggere le prime pagine.
M: Già.
F: Tu ti appassionasti subito, ti sembrarono buone, le mettesti immediatamente a fuoco e mi suggeristi subito alcune modifiche essenziali. Da allora sei stato il mio primo lettore, in quest’avventura: be’, volevo dirti che è bello avere un amico come editor.
M: È stato divertente anche per me.
F: Ho sempre pensato che i libri hanno a che fare con l’amicizia. Non mi ricordo tutti i libri che ho letto, ma di tutti mi ricordo chi me li ha indicati, chi me ne ha parlato, chi me li ha fatti incontrare. C’è una storia, e un legame per ciascuno. È questo supplemento di vita privata che si mischia con loro a renderli così significativi per ciascuno di noi.
M: Ne sono convinto anch’io.
F: Puoi figurarti, quindi, quanto sia importante, per me, quest’intreccio affettivo per le storie che scrivo, quanto mi aiuti parlarne e fare leggere le prime versioni solo a pochi occhi fidati, che mi conoscono e mi capiscono, e sanno forse anche meglio di me quello che vorrei riuscire a esprimere. Mi sento molto fortunato ad avere tre o quattro amici con cui discuto da anni su tutto. È per questo vorrei rovesciare quest’intervista.
M: In che modo?
F: Vorrei essere io a farti qualche domanda. Ho sempre sognato di intervistare un mio lettore. Alcuni sono troppo lontani, altri non li sento da un po’, e quelli che restano non li conosco. Ma qui davanti ho te, che questo libro lo hai visto nascere, e hai contribuito a cambiarlo con i tuoi consigli.
M: È un po’ strana, come intervista.
F: Anche il personaggio di Charlot lo era, un tipo tutto sottosopra, con le scarpe troppo grandi e i pantaloni troppo corti.
M: Ho capito, vuoi parlare della mancanza di proporzione, di quella particolare sospensione del sistema metrico lineare che hai adottato in questa narrazione.
F: Mi sembra un buon inizio, anche se non ho ben capito cosa vuoi dire.
M: Partiamo dalla citazione che apre il libro. È molto bella, e ha un senso che illumina tutto quello che viene dopo. Chaplin diceva di sé di essere un dorso, una schiena.
F: Chaplin era mancino, suonava il violino al contrario, in lui e nel suo personaggio tutto era storto.
M: Storto è l’aggettivo giusto. Uno dei temi di questa storia è la stortura. A un certo punto, un critico cinematografico accusa Chaplin di avere messo in scena nel film Il Circo la meschina imperfezione del mondo. Ti sei accorto che tutto il tuo libro, in fondo, è attraversato da personaggi fuori misura, nani, acrobate zoppe, donne cieche, tipografi monchi…? anche nelle tue storie precedenti ci sono figure simili: calciatori con una gamba più corta, musicista senza dita, cantanti mute…
F: Me ne sto rendendo conto solo adesso.
M: Il tuo è un circo di creature segnate dalla mancanza.
F: È una bella definizione, ti ringrazio. Mi piacerebbe fosse davvero così: un po’ volevo scrivere sulla mancanza, ma senza dirlo.
M: È per questo che il centro, il diamante della tua storia, è proprio il circo. Il circo, visivamente, è mancanza e deformità, un posto per essere per chi possiede qualche curioso talento, ma che non trova un patto con il mondo, che con il mondo si sente spaventosamente inconciliabile. Il circo è anche disagio, sconcerto, turbamento. Partendo dal circo, tu hai potuto dilatare i confini della verosimiglianza. Quando uno entra là dentro, sotto quel tendone (tu citi quello dei fratelli Bastiani, di stelle fosforescenti, che hai incontrato in un libro di Sebald), puoi credere a tutto quello che ti si racconta. Accetti il fatto che quella pista di terriccio e di segatura sia abitata da donne cannone o da scheletri umani o da uomini con la faccia di un leone. A questo punto, se mi dici che il cinema è stato inventato per amore da un arlecchino nero che puliva la sabbia degli animali, io ti ascolto. Perché quello che mi stai raccontando è una storia di restituzione. Di quella restituzione dello stupore e della comprensione che ci rende il circo. Dopotutto, se ci sono persone segnate dalla mancanza, vuol dire che a loro qualcosa bisogna pur restituire.
F: È un’interpretazione molto nobile, e mi piace, naturalmente, ma sai bene che all’inizio credevo di essere alle prese solo con una favola strampalata per ragazzi… ad ogni modo, è bello vedere quante cose un lettore può ritrovare in quello che si scrive. A Torino, l’altra mattina, un signore gentile e intelligente mi ha detto che questa è una favola attraversata dal dolore e che la sua aspirazione è l’integrazione dell’ombra.
M: Una favola per adulti, sono d’accordo, quante volte ho dovuto ripetertelo? Charlot è l’ombra, il vagabondo che cammina sul lato sbagliato del marciapiede, la parte mancina delle cose. È un povero di spirito. Ma è l’unico personaggio che poteva portare a termine la missione che gli avevi affidato: consegnare una scatola magica alla donna a cui era destinata, salvare una goccia della sua bellezza dopo l’incidente che l’aveva tolta dal giro e offeso irrimediabilmente le sue gambe, rubare alla morte e al tempo una manciata di fotogrammi, scalfire la pelle e la pellicola del ricordo.
F: Perché dici che poteva riuscirci soltanto Charlot? Il primo protagonista che ho avuto in mente era un altro regista, Frank Capra, te l’ho raccontato. Capra era a me più vicino, perché siciliano, di Palermo. Mi sembrava adatto a raccontare una storia di fortuna, destino e migrazione, che si incrociasse anche con le storie della mia famiglia.
M: Non poteva funzionare. Charlot ha la forza di un archetipo universale. È un bambino pieno di vergogna, che assiste all’umiliazione pubblica di sua madre e all’oltraggio segreto della sua malattia mentale e da quando sua madre impazzisce è un orfano. È letterario perché somiglia a Davide Copperfield e agli altri personaggi di Dickens. Gli orfani sono gli eroi delle favole. E se tu volevi scrivere una favola sul cinema, come hai fatto, potevi imbastirla soltanto con lui. C’è sempre un solo personaggio giusto per ogni storia. In più, l’umanità di Charlot è terribilmente contemporanea, scandalosa e sovversiva.
F: A proposito della vergogna…
M: Un sentimento violento e sleale, come la nostalgia.
F: Un sentimento che mette in moto le vicende umane. La vergogna si coniuga con lo specchio e con molte altre cose. Ma volevo dirti che in un altro incontro, a Siracusa, un ebreo ortodosso con i cernecchi, il cappello, il cappotto scuro, mi ha detto che nell’ebraismo la vergogna riguarda l’omicidio e il sangue. E che anche quando si arrossisce, si sparge del sangue.
M: È un’immagine molto forte. Ma, a parte lo specchio, la vergogna riguarda pure la scrittura. Scrivere non è forse un modo per attraversarla?
F: Anche recitare.
M: Charlot è un personaggio di una disperata timidezza.
F: Perché parli sempre di Charlot, e non di Chaplin?
M: Tu li hai sovrapposti. Non ti stancare mai di sottolineare che non hai scritto una biografia, ma un romanzo, perché potrebbero fraintenderti in molti. Non ti conoscono, non sanno quello che c’è dietro. Il tuo è un romanzo che ha il vecchio e il giovane Charlot come protagonista. Tu giochi con le maschere, prima che con le persone vere. Fai dire a un’infermiera che Charlot unisce il clown bianco e l’augusto in una sola figura. La cornice biografica è solo un ingranaggio, serve a tenere tutto in piedi. Un trucco, come nei circhi. Ma la storia che corre alla ricerca di una verità intima, interna e coerente, è tutta di fantasia. In fondo, me lo hai detto tu che hai studiato storia, da ragazzo, ma per tradirla.
F: La storia era la mia passione.
M: Ma la verità storica non ti interessa più. È un’altra verità che insegui. Questa ricerca è data anche dal ritmo delle tue storie, dal movimento picaresco, dalla metafora assoluta del viaggio. Ogni restituzione, del resto, ha bisogno di un viaggio.
F: Dimmi la verità, credi che non avrei dovuto mescolare finzione e verità al punto da confonderle entrambi?
M: Tutt’altro. Il romanzo lo fa da sempre, è la sua incoscienza, e la sua forza. Una scommessa. Bisogna avere molta fiducia nella parola, certo, nella scrittura.
F: Mi dici, se vuoi, qual è la scena che ti è rimasta più in testa?
M: Più che una scena, è un gesto. Mi ha colpito quello che fa la tua vecchia armena quando accompagna Chaplin in un cimitero e posa un bastone per terra, vicino a una lapide. Tra tutte le restituzioni che racconti, questa è quella che, nella sua illusione, mi sembra la più riuscita. Come se davvero dopo la morte ci fosse ancora da camminare. E quell’armena si preoccupasse di come avrebbe potuto farlo la sua amica, con la sua gamba zoppa. È davvero un gesto di grande pietà, da parte sua.
F: Una domanda per una risposta franca: credi che la mia scrittura sia inamidata o perbenista?
M: Una domanda difficile, e non posso marginalizzare un po’ di sana cattiveria. Inamidata non direi, piuttosto morbida. Sì, la tua è una scrittura morbida, molto ricercata nel suono, negli accostamenti tra le parole. Nei primissimi testi c’era appena dell’amido, ma erano i giorni in cui cesellavi il tuo stile, era più una fase evolutiva di ricerca piuttosto che una fase statica di autocompiacenza linguistica. Sul perbenismo, sono completamente in disaccordo. Tu sai quanto il mio occhio per la letteratura ami scenari foschi e viva di ombre e distopie, quindi il puzzo di perbenismo lo sento da chilometri. No, non c’è perbenismo, il tuo pugno scrive quello che la tua mente pensa e i tuoi pensieri risentono della tua umanità, ma rientra tutto nella tua scrittura morbida e certosina, raffinata. Il problema che ti ho sempre sottolineato è che il velluto nero di contrasto alla perla si vede poco: la perla è sovraesposta, manca l’effetto contrasto e taluni possono credere che sia una lingua semplice, ma solo perché hai alzato l’asticella. Ma leggendo i nuovissimi lavori, ancora inediti, hai iniziato a calibrare meglio raffinatezza e un giusto sporcare. I lettori apprezzeranno.
F: Oddio, mi hai mandato ko.
M: Sei tu il fan di Balbetta Groogan.
F: C’è altro che ti è piaciuto?
M: La scelta della lettera come mezzo narrativo. È una lettera di Chaplin anziano al figlio troppo giovane, e credo che sia un mezzo antico e al tempo stesso, nel nostro tempo elettronico, modernissimo. È una tecnica di grande forza narrativa, fa esplodere l’identificazione del lettore, perché chi legge diventa senza diaframmi il destinatario. Poi è bello che sia proprio una lettera il motore per una storia on the road. E mi piace la linea d’ombra su cui fai muovere Charlot.
F: In che senso?
M: In questo libro Charlot non appartiene mai alla luce e mai all’ombra, si muove su un confine o fa parte di entrambe. C’è questa costruzione polare dell’identità del protagonista che è molto realistica, perché l’identità, che si costruisce nei primi anni di vita, è un processo di opposte polarità. L’ho trovato molto giusto: il sorriso e il ridicolo sono luce e ombra insieme, come lo sono la timidezza e il porsi davanti alla cinepresa, l’enorme successo e questa irrequietezza che dopo i mille mestieri si riversa all’interno e sul piano sentimentale dell’abbandono: unica restituzione mancata nel tuo Charlot. E anche questo è assai realistico. Altra linea d’ombra è l’uso della vera biografia con quella inventata, intesa come linea dell’ambiguità: l’abuso della realtà per creare finzioni. Ma forse questa cosa piace a me, sempre per la mia predilezione per ciò che è scuro e opaco.
F: Non pensi che tutto questo sia troppo sentimentale, ingenuo o infantile?
M: Penso che tu avessi una voglia infantile di rivedere Charlot in movimento. Ma che non ci sia niente di ingenuo in questi temi: la sfida con la morte, la mancanza, la restituzione, l’ombra, la migrazione, la fortuna, il destino, e questo andare a vedere se uno ha qualche talento, da qualche parte, ed eventualmente metterlo alla prova… Bolaño diceva che il suo terreno era il patetico. E Chaplin sosteneva che non bisogna avere paura di essere ridicoli.
F: Ma aggiungeva che si fa ridere solo se ridicoli lo si è davvero.
Continuerei ad ascoltarti a lungo. Quasi mi ci fai credere, a tutto quello che dici.
M: Lo hai scritto tu.
F: Ora forse appartiene più a te e agli altri lettori che a me. Ti ringrazio davvero, amico mio.
M: Grazie a te. Siamo pazzi.
F: Grazie per la tua follia.


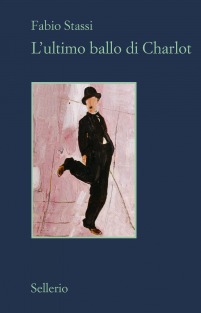



Comments