“Pietroburgo”
di Andrej Belyj
di Michele Lupo / 28 ottobre 2014
Leggere Pietroburgo di Andrej Belyj (Adelphi, 2014) è come entrare in un mondo singolare, beffardo, vacillante e rovinoso, sempre prossimo a collassare nella liquida e macilenta sostanza su cui si erige una geometria a dispetto delle maestose ambizioni poco cartesiana – e abitato da un’umanità volta per volta umbratile o febbrile ma sempre, a dir poco, fantasiosa. Basta leggere quant’è detto del primo capitolo, «nel quale si narra di un insigne personaggio, dei suoi giochi mentali e della precarietà dell’essere».
Ableuchov è un senatore che dovrebbe emblematizzare il dominio oscuro quanto irragionevole della burocrazia zarista, che «ha elevato a principio la freddezza» – il che spiega perché nella sua casa i subordinati vivano in un clima di marcata soggezione, figlio a parte. Ma non è che gli altri personaggi siano più solidi di lui.
Intanto c’è Pietroburgo. Sontuosa e mefitica insieme. Ne sapevano qualcosa già Gogol, Dostoevskij, per tacere degli altri: ce lo ricorda nella splendida introduzione al romanzo di Belyj quel grande scrittore che fu Angelo Maria Ripellino (sua anche la traduzione che Adelphi riesuma per l’occasione dalla vecchia edizione Einaudi). Al netto di alcuni stilemi diremmo avanguardistici (la stessa Adelphi presenta il libro come «il capolavoro romanzesco del simbolismo russo») che al lettore d’oggi possono parere stranianti e lato sensu esoterici, la compagine della città (le cui strade in autunno continuano «a scorrerti nelle vene come una febbre») vale da sé la forza sensoriale (non solo visiva o persino visionaria) del libro.
I suoi personaggi gli appartengono. Dal senatore in avanti sembrano macinati da una instabilità psichica che sembra provenire anch’essa dalla materia lutulenta della Pietroburgo più nascosta. L’uomo di stato che si reca al suo Dipartimento si perde nell’infinità delle nebbie di una città sfagliata nella fitta umidità, tra la brina che «irrora le strade e le prospettive»: lo sguardo che vi proietta non può che essere allucinato. Se di un politico siamo abituati a leggere le nefandezze, l’ipocrisia, la stupidità, i crimini pubblici e privati, il senatore qui in questione è un uomo che vive di acuti strappi neuronali, di visioni che intercettano lo spazio sbilenco e fantasmagorico delle prospettive sfalsate dalla fuliggine pietroburghese – e ne esce disfatto. S’imbatte in esemplari sparsi di una Russia non meno sghemba di quanto sia lui, una distesa periclitante di figure che sgusciano e scompaiono come ombre in una città oltre la quale – nonostante tutto – pare giacere il nulla. E non sa, l’omino, che qualcosa di ancor più terribile si sta abbattendo su di lui. Il centro narrativo del romanzo sta infatti nella macchinazione di un parricidio – tema “europeo” quant’altri mai. Che Belyj, rivoluzionario ma eterodosso, teosofo e bevitore non occasionale (e tante altre cose), sentiva particolarmente. E che vira nel romanzo in una direzione tragicomica anche a dispetto della cupezza – del kafkiano «odore di fumo» – implicita nel piombo di una rivoluzione (imminente: il romanzo è ambientato nel 1905…). La manovra si risolve in un gioco vertiginoso di ombre, fantasmi, deliri: maschere dietro le quali avrebbe ancora detto Kafka si celano altre maschere. Ribelli e burocrati da ancien régime roteano tutti nello stesso vortice fosforescente – mettendo in scena il lato farsesco del Novecento. A suo modo, un classico.
(Andrej Belyj, Pietroburgo, Adelphi, a cura di Angelo Maria Ripellino, Adelphi, 2014, pp. 384, euro 22)


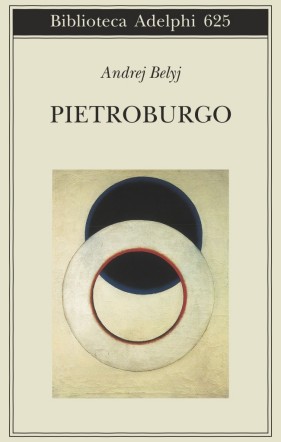



Comments