“Dubliners” e il futuro
“Gente di Dublino” di James Joyce
di Claudia Cautillo / 25 maggio 2018
Rileggere nel terzo millennio Gente di Dublino di James Joyce? Assolutamente sì. Perché è a distanza di un secolo che possiamo spiegarci le tante difficoltà di pubblicazione, e i non pochi contrasti con gli editori, che hanno impegnato Joyce per anni prima che nel 1914, alla vigilia della grande guerra, questo testo fondamentale della letteratura moderna venisse finalmente stampato.
In netto anticipo sui tempi, è ora che ci appare straordinaria l’intuizione di questi quindici racconti di evocare in maniera completamente nuova, attraverso una raffinata sintesi tra i due differenti poli del naturalismo alla Flaubert o alla Zola e del simbolismo hauptmanniano, il tramonto della civiltà occidentale e del suo sistema di valori. Oggi che l’Islam radicale ci spinge a riflettere sulla nostra cultura, ponendoci interrogativi forse troppo a lungo rimossi, la complessa struttura di codici che ne sottende la narrazione, dall’Ovest inteso come emblema di fallimento e di morte, non meno che dall’uso semantico dei colori – il verde che non è più simbolo dell’Irlanda, della speranza e della rigenerazione ma che si fa colore della marcescenza e della putredine, segni decifratori di una società chiusa in un paralizzante moto centripeto e avversa a tutto ciò che è estraneo e diverso, ci svela tutta la sua sconcertante lungimiranza e attualità.
Dublino è così l’allegoria di un mondo alla deriva, sospeso tra frustrazione e accidia, malinconia e nevrosi, e la sua tinta è il marrone della terra cimiteriale e dei mattoni degli squallidi edifici periferici. Intrappolati nel tema tipicamente joyciano del rimorso per le occasioni perdute, sui personaggi «aleggia uno speciale odore di putrefazione», come lo stesso autore tentava di spiegare al riottoso editore Grant Richards nel 1905.
Scrive ancora Joyce nel maggio dell’anno seguente: «Ho cercato di presentarla [Dublino] al pubblico indifferente sotto quattro dei suoi aspetti: infanzia, adolescenza, maturità e vita pubblica. I racconti sono posti in questo ordine». Difatti questo straordinario ritratto di città è al contempo organismo vivente, evocatore di un percorso esistenziale dalla culla alla tomba in cui i singoli personaggi di volta in volta al centro della vicenda, imprigionati in una dimensione sia reale che metafisica, costituiscono in realtà la facciata dell’unico vero protagonista che si innalza su tutti: la morte. Tanto che – capolavoro nel capolavoro – l’ultima novella, dall’innovativa dimensione intermedia tra romanzo breve e racconto, ha per titolo I morti, punto culminante della parabola narrativa occidentale alla stregua di Morte a Venezia di Thomas Mann o di Cuore di tenebra di Joseph Conrad.
È qui infatti che si condensa la genialità narrativa di Joyce, capace di armonizzare in una parodia funeral o, come lui stesso annotava, funferal, la tradizione naturalista e realista del tratto umorale e fisiognomico, del bozzetto vivace, del graffio satirico e della connotazione tipologica, ad una lettura ironicamente allegorica e archetipica della condizione umana, attraverso un’originale condensazione freudiana e carnevalesca che apre il varco all’alterità, all’inconscio, al tempo assoluto della morte. Se già negli altri racconti la soglia che separa i vivi dai morti tende a dissolversi sfumando in zone d’ombra, e al lettore attento non sfugge la presenza conativa di segni memoriali atavici testimoni impassibili degli eventi, quali ad esempio uno specchio brunito, un vecchio quadro, un ritratto ingiallito, in quest’ultimo il trionfo della morte sulla vita ha il tocco lieve della distesa uguale e immemore della neve, quel mondo “altro” dove i paradossi si annullano.
Padrone della tecnica narrativa dell’epifania, cioè dello svelarsi di un significato riposto al di là delle apparenze, come la natura divina nel bambino appena nato che i Magi lessero in Gesù, nel finale di I morti, Joyce ci svela l’epifania del personaggio principale, Gabriel, attraverso una serie di passaggi significativi: «un leggero picchiare sui vetri lo fece voltare verso la finestra. Aveva ripreso a nevicare. Osservò assonnato i fiocchi, argentei e scuri, cadere obliquamente contro il lampione. Era tempo per lui di mettersi in viaggio verso occidente». Ecco il momento della consapevolezza, della rinuncia, dello stato d’abbandono rassegnato in cui la neve che cade induce Gabriel, dall’evocativo nome dell’arcangelo della morte, annullando il confine tra i morti e i vivi e consentendogli di prendere coscienza dell’ineludibile al quale lui stesso e tutto il suo mondo sono destinati: l’occidente, cioè il punto in cui il sole conclude il suo arco, dunque la fine, la morte. «Sì, i giornali avevano ragione, nevicava in tutta l’Irlanda. La neve cadeva su ogni punto dell’oscura pianura centrale, sulle colline senza alberi […] Si ammucchiava fitta sulle croci contorte e sulle lapidi, sulle punte del cancelletto, sui roveti spogli. La sua anima svanì lentamente nel sonno, mentre ascoltava la neve cadere lieve su tutto l’universo, come la discesa della loro ultima fine, su tutti i vivi e su tutti i morti».
A cento anni di distanza, la straordinaria contemporaneità di Gente di Dublino rivela l’epifania di se stessa, e la sua neve che cade continua a interrogarci su di noi, sulla direzione verso la quale la nostra civiltà occidentale si sta volgendo, e verso il nostro futuro.


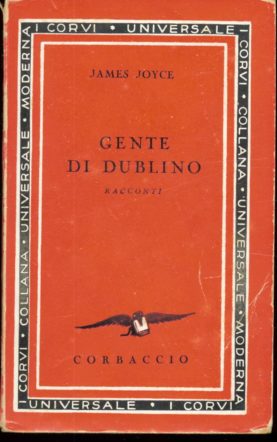



Comments