I vermi trasparenti di “Baco”
Intervista a Giacomo Sartori
di Daria De Pascale / 20 gennaio 2020
Baco (Exòrma, 2019), il nuovo romanzo di Giacomo Sartori, è uno di quei romanzi che lasciano un’impronta lunga nella memoria, che si sedimentano e aprono a nuove prospettive, a nuovi modi di guardare il mondo.
In breve, è la storia di un bambino di dieci anni, sordo profondo e iperattivo, che detta alla sua logopedista una serie di lettere alla madre, in coma dopo un incidente stradale. Proprio l’incidente dà avvio alla narrazione, quando il ragazzo si trova a vivere con un padre troppo giovane per occuparsi della famiglia, un nonno specialista di bruchi, che porta con sé ideali novecenteschi, e un fratello geniale, soprannominato QI185, che crea un sistema di intelligenza artificiale destinato ad avere un impatto enorme sulle loro vite.
Si tratta di un romanzo ricchissimo di stimoli e spunti di riflessione, che affronta questioni fondamentali del mondo contemporaneo attraverso una voce inusuale e leggera solo in apparenza.
Ho cercato di portarle a galla facendo qualche domanda all’autore: agronomo trentino che vive a Parigi, non nuovo a narrazioni complesse e ricche di livelli e sfaccettature.
Vorrei cominciare parlando del protagonista di Baco. Il tuo narratore ha il tono imperfetto e a tratti petulante di un ragazzino con un controllo solo parziale del linguaggio, che crea espressioni inusuali e usa «paragoni squinternati e ineleganti similitudini». La semplicità è solo una prima apparenza, perché diventa molto presto chiara la ricerca approfondita a livello linguistico e psicologico necessaria a costruire una voce simile e mantenerla coerente sino alla fine. Com’è nato un personaggio così inusuale, da cosa nasce il desiderio di assumere un punto di vista così complesso?
I miei personaggi sono quasi sempre inusuali, e spesso marginali, e spesso hanno difficoltà a spiegare a se stessi quello che vivono e sentono. È il caso del protagonista di Baco, che appunto ha dieci anni, e ha avuto accesso solo molto tardi alla lingua dei segni, perché il padre era contrario, cosa spesso tragica che capita e soprattutto capitava a molti sordi, che così si trovano privi di uno strumento di pensiero e di comunicazione.
Mi interessava questo suo accesso difficile alla lingua – solo ora sta imparando anche quella verbale – perché credo che tutti noi abbiamo in qualche misura problemi a confrontarci con la lingua, anche se non ce ne rendiamo sempre conto, e con la gabbia di interpretazioni e di rappresentazioni – una lingua è anche una lettura del mondo – che si porta dietro. E naturalmente questo suo scrivere – in realtà detta come dici tu alla sua logopedista – è una metafora della scrittura, quella della letteratura: anche lì l’autore si confronta e lotta con la lingua, si dibatte con le sue inerzie e limiti.
Una delle caratteristiche salienti del romanzo è proprio la riflessione sul linguaggio. La sfiducia che il protagonista prova nei confronti della lingua parlata è la sfiducia di un individuo che non può comunicare nella sua “lingua madre”, la lingua dei segni, considerata da tutti inferiore – come un dialetto, o una lingua straniera che nessuno capisce. Ma è interessante come alla sua sfiducia si affianchi presto anche una sfiducia del lettore rispetto alle vicende raccontate: le persone che ha intorno mettono per prime in dubbio ciò che lui racconta, dando la sensazione di una realtà alterata, inaffidabile.
Quello del linguaggio è un tema fondamentale nei miei romanzi e nei miei racconti, fin dall’inizio: anche per esempio nel romanzo precedente, Sono Dio, dove a esprimersi era appunto Dio, con tutte le disavventure comiche connesse, perché per definizione la lingua umana non può veicolare l’infinitezza e la trascendenza, è irrimediabilmente umana e limitata, intrisa di passioni e emozioni che non hanno nulla di sacro.
Il mio non è un interesse teorico, ma un’attrazione per uno degli aspetti più importanti e problematici degli esseri umani, anche se nella vita corrente la maggior parte delle persone non ne è cosciente. E la lingua dei segni, che il mio protagonista ha imparato tardi, e che lo ha salvato, è interessantissima, perché non è una trasposizione della lingua parlata, come molti pensano, ma è uno strumento a sé, un linguaggio a sé stante, con una sintassi tutta sua.
Il ragazzino vede la nostra lingua attraverso questo prisma, che padroneggia meglio, e per così dire da lontano. Quindi per molti versi la capisce e ne vede i limiti meglio di noi, che la maneggiamo molto meglio di lui ma la usiamo macchinalmente, senza rifletterci. Lui vede molto meglio di noi che qualsiasi affermazione è fondamentalmente falsa, non rispecchia fedelmente la realtà, non può farlo, con tutte le zavorre e preconcetti che si porta dietro.
Quindi la verità del racconto è la sua, più cosciente degli inganni della lingua, e non quella degli altri personaggi? O forse più probabilmente una verità non esiste affatto e ogni personaggio coinvolto percepisce gli avvenimenti – anche quelli più oggettivi – a modo proprio, a seconda non solo del punto di vista da cui guarda ma anche della lingua che usa per raccontarli, prima di tutto a se stesso. Se penso alle categorie concettuali del nonno, un anarchico novecentesco, rispetto a quelle di QI185, il fratello genio, completamente immerso in una bolla digitale, il divario di percezioni è enorme.
Certo, non esiste una verità oggettiva, e tutti i romanzi novecenteschi e posteriori affrontano in un modo o nell’altro, con questa o quella tecnica, questo dato di fatto. Ognuno di noi decodifica e legge gli stessi avvenimenti in modi profondamente diversi, molto più di quanto ci si immagina comunemente. Le immagini che gli altri hanno di noi non hanno niente a che fare con quella che noi abbiamo di noi stessi, e sono diversissime tra loro. Non parliamo poi quando ci sono, come dici tu, barriere generazionali e/o ideologiche e culturali. E in un certo senso la lingua tende a appiattire queste differenze, a incanalarle entro codici precostituiti, accentuando le somiglianze. Il mio protagonista, proprio per il fatto che non maneggia molto bene la lingua, e per certi versi la osserva da fuori, si rende conto che ciò che dicono quelli che gli stanno attorno, e ciò che dice lui stesso, non corrisponde a quello che vede: non è la verità, ha sempre qualcosa di sbagliato, o almeno di forzato.
È proprio questa distanza dal linguaggio che gli permette di guardare il mondo da una prospettiva molto più ampia del comune. Come se, escluso da un antropocentrismo appreso culturalmente, riuscisse a percepirsi non come padrone del mondo ma come parte di un sistema più grande di sé, in cui le api allevate dalla madre, i bruchi studiati dal nonno, e anche l’intelligenza artificiale, hanno la stessa rilevanza e lo stesso diritto alla vita.
In effetti io credo che il romanzo abbia ancora senso e interesse se riesce a pescare anche da saperi che non sono quelli costituiti, quello che forse tu intendi quando dici “appresi culturalmente”. Noi occidentali siamo intrisi di “culturalismo”, quasi la cultura fosse solo quella accademica e speculativa, e ci dimentichiamo che le esperienze di vita possono costituire forme di sapere altrettanto profonde e istruttive. Abbiamo perso la cognizione di quella che per i filosofi antichi era la saggezza, che non era solo speculazione cerebrale. E è chiaro che l’antropocentrismo nel quale ci siamo cullati per un paio di millenni è ora in crisi profonda, perché da una parte scopriamo che le cose sono più complicate – noi non siamo il centro del mondo, e men che meno dell’universo – e dall’altra constatiamo i danni che questo ha portato, che cominciano a mettere in discussione la nostra stessa sopravvivenza.
È certamente un tema molto attuale in tempi di emergenza ambientale, e lo sarà sempre di più, anche nel futuro prossimo come quello in cui è ambientato Baco. A questo proposito vorrei chiederti, qual è il tempo del tuo romanzo?
Si tratta di un futuro molto prossimo, nel senso che tutti i giorni ci vengono decantate le possibilità dell’intelligenza artificiale, e i risultati a cui arriverà a breve, e gli impatti che avrà nelle nostre vite. Poi gli esperti ci dicono che le macchine restano per il momento piuttosto sciocche, ma la propaganda che va per la maggiore è quella.
Sono sciocche oggi, ma sono anche in costante evoluzione, “imparano” molto in fretta: lo sperimentiamo ogni giorno trovandoci a relazionarci con sistemi sempre nuovi e sempre più avanzati, in grado di risolvere i mille problemi quotidiani del mondo complesso in cui ci troviamo a vivere (penso banalmente agli assistenti vocali dei nostri cellulari e che cominciamo ad avere in casa). Proprio questa crescita continua, così rapida da lasciarci a tratti indietro, è rappresentata con precisione dall’intelligenza artificiale del tuo romanzo, che è un po’ co-protagonista e un po’ deus ex machina dell’intera vicenda.
Sì, certo, in certi settori, a cominciare da quelli che citi tu, i risultati lasciano a bocca aperta, e l’impressione del comune mortale è di essere sempre indietro, di faticare a tenere il passo. Nello stesso tempo, quando si tratta di ragionare, e non di scimmiottare esempi e procedimenti già successi, come fanno i traduttori automatici, le macchine restano stupidissime: ce lo dicono tutti gli esperti e gli addetti al mestiere, e ce ne accorgiamo noi stessi se per esempio abbiamo un problema e ci ritroviamo a battagliare con il bot deficiente di un negozio online. E non è detto che in futuro possano fare molto meglio.
Però noi abbiamo egualmente paura di essere scalzati dai congegni che creiamo, e questo corrisponde a un terrore ancestrale, alla sfida di Prometeo agli dei, e alla fascinazione del Golem, miti che poi nel Novecento, con il grande sviluppo della tecnica, diventano ben rappresentati nella letteratura. E il mio romanzo rispolvera questo topos letterario, in chiave contemporanea.
Vorrei che mi parlassi dell’ambientazione del romanzo: tutta questa tecnologia, che noi siamo abituati ad associare ad ambienti metropolitani, è invece immersa nella provincia profonda, in una campagna che guarda la città (che sta «acquattata nella sua buca», proprio come certe città del nord Italia) solo da lontano, e tutti i personaggi hanno un forte legame con la terra. È un contrasto interessante.
In realtà la tecnologia è dappertutto, perfino nei paesi poveri: pensiamo alla diffusione dei telefoni in Africa, impensabile solo qualche anno fa, e a quello che rappresenta. E mi sembra che una caratteristica dell’Italia sia proprio la compresenza di elementi arcaici, appunto da provincia profonda, con un forte legame con la terra, come dici tu, e molto contemporanei, associabili piuttosto a non luoghi. Questa caratteristica viene fuori in realtà in tanti miei lavori, e in particolare nei tre romanzi ambientati nelle Alpi. La città acquattata è una allusione alla cittadina dove sono cresciuto, Trento, e che è un esempio perfetto di convivenza di elementi tradizionali, anche molto gretti, e chiusi su se stessi, e di nuove tecnologie, che sono invece planetarie.
Ti faccio un’ultima domanda. La parola baco compare spesso nel romanzo, seppure con continui slittamenti di significato. Perché i bachi – e i bruchi, i vermi (Vermi trasparenti è il titolo, bellissimo, del file in cui è contenuto il racconto del ragazzo)?
Ho scelto Baco perché rimanda allo stesso tempo al mondo digitale, l’inglese bug che attacca o insomma inficia il funzionamento delle macchine informatiche, e alla natura, ai vermi dei quali appunto il nonno del protagonista è specialista. Perché appunto le due grandi tematiche del romanzo sono la natura e la tecnologia.


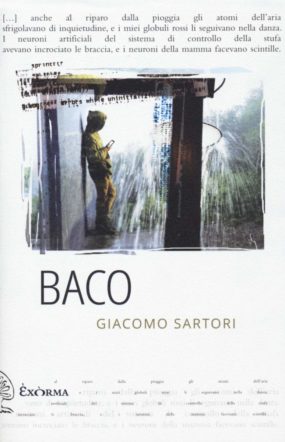



Comments