Libri
Sergio Atzeni tra incanto e tristi abbandoni
«Hai amato, sofferto e fatto il buffone»
di Ulderico Iorillo / 30 aprile
Sergio Atzeni è morto poco più che quarantenne nuotando nelle acque dell’isola di san Pietro di fronte a Carloforte. Era uno scrittore sardo, Atzeni, tutto lo diceva di lui, era «sardo, italiano, europeo» come egli stesso si è definito. Tutti i suoi scritti hanno la Sardegna come ambientazione, ma non la regione/nazione isolata e arroccata nelle proprie tradizioni cui ci aveva abituato la letteratura, piuttosto un’isola crocevia di popoli e luogo archetipico di métissage culturale e linguistico.
Proprio nel suo ultimo romanzo, Passavamo sulla terra leggeri (Mondadori, 1996), Atzeni realizza una sorta di cosmogonia della Sardegna, un racconto totale, poetico e biblico dell’isola, la cui narrazione è affidata all’oralità e al ricordo. Copre un arco temporale molto lungo partendo dal mito dei S’ard, “i danzatori delle stelle”, uomini colti, astronomi provenienti dall’Oriente, approdati in un tempo astorico sulle coste dell’isola senza nome.
«Nella lingua fra i fiumi. Cento e cento case di canne paglia e fango. L’alta zicura di limo e tronchi al limite dell’acqua, trecentotrentatré scalini per arrivare all’altare dove pulsava il cuore del capro, leggevamo la parola, interrogavamo il cielo e pronunciavamo oracoli».
Il racconto termina con l’arrivo degli Aragonesi a Caglié, l’antico nome di Cagliari, nel 1409 e, come se questa data rappresentasse l’ingresso della Sardegna nella Storia uscendo dal mito, Atzeni interrompe la narrazione orale che ha affidato fino a quel momento ad Antonio Setzu – custode del tempo – che a sua volta l’aveva appresa da bambino.
Ed è proprio Cagliari, la città di Atzeni, la città che il suo alterego Ruggero Gunale si lascia alle spalle, per andare nel continente a fare una vita da lavoratore precario ne Il quinto passo è l’addio (Mondadori, 1995).
«La nave bianca si allontana e dietro un dente alto e bianco di calcare sparisce l’antica fortezza vedetta dei Fenici, l’avamposto d’Europa al respiro dell’Africa e d’Oriente alle porte d’Occidente, popolato da una scura genia parente di Annibale, adocchiato da predoni scalzi, battuto da tutti i venti, abitato da tutti i profumi e i fetori e da ogni genere d’ingegno e vizio e da qualche virtù, come ovunque siano uomini. Ruggero conosce i venti, i profumi, i predoni. Si crede principe di antica stirpe, è figlio di un fabbro e di una bruscia, è ignobile e folle come un muflone».
Cagliari, la città bianca, Atzeni l’ha raccontata nella modernità, cruda, sporca e terribile del suburbio, e nella sua storia antica, in parte mitica e fantastica. Una città amata e odiata, da cui è fuggito, ma di cui non ha potuto fare a meno di parlare e di restarne affascinato per tutta la vita, incatenato come per una sorta di incantesimo da cui non gli riuscì mai di liberarsi.
Nato “in trasferta” a Capoterra, presso una zia ostetrica, visse la sua infanzia e adolescenza a Cagliari, ma si spostò anche in altre zone della Sardegna per via del lavoro dei genitori. Era figlio di un minatore poi diventato sindacalista e in seguito figura di rilievo nel PCI sardo, e di un’ostetrica, militante comunista, dirigente dell’Unione Donne Italiane. Anche la vita politica di Sergio fu attiva, e sin da giovane fu militante, poi dirigente, della FGCI sarda. Svolse molti lavori, da impiegato dell’Enel a giornalista pubblicista e traduttore, ma prima di raggiungere una realizzazione lavorativa dovette attendere a lungo. La prima delusione avvenne quando partecipò al concorso per giornalista in Rai, a Torino. Fu proprio da quella esperienza negativa che nacque il romanzo Il quinto passo è l’addio. In seguito, lo scrittore cominciò a girare per l’Europa, fino a che non si trasferì proprio a Torino.
La prima soddisfazione letteraria a livello nazionale la ebbe grazie all’intuito di Elvira Sellerio, che riconobbe il talento di Atzeni e pubblicò L’apologo del giudice bandito, un romanzo che ruota intorno al processo che l’Inquisizione spagnola istituì nell’isola a carico delle locuste che invasero la Sardegna nel 1492.
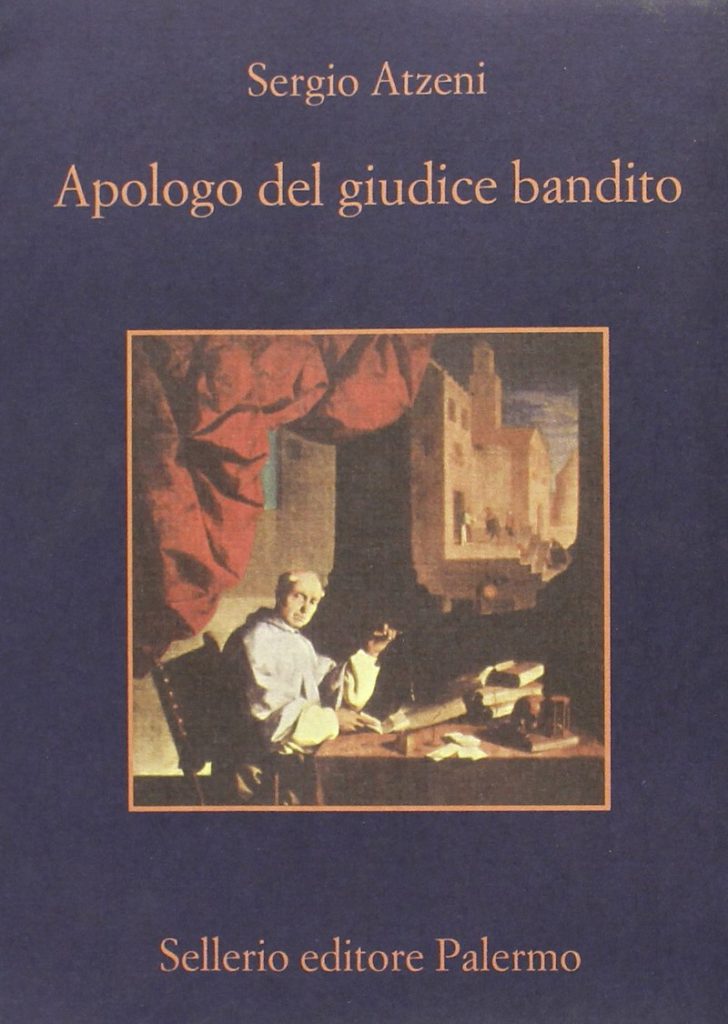
«Lilliccu apre gli occhi. L’aria è liquida, i contorni delle cose bisce in fuga, miraggi, barbagli luccicanti.
Laggiù dove la pianura si mescola col cielo, qualcosa si muove.
Lilliccu prega sia un inganno della luce. Porta la sinistra sugli occhi, per veder meglio: una nuvola gialla avanza bassa sulla pianura.
La zappa cade senza rumore».
Nonostante i primi successi letterari, rimase comunque molto critico nei confronti dell’attenzione che gli riservarono sia nell’isola che fuori. «Ho verificato che se tu lavori con editori sardi, i giornalisti, i quotidiani, il pubblico non ti considerano, in sostanza non esisti, in Sardegna. […] In Sardegna si accorgono di te solo se pubblichi per un editore nazionale […]. A dire il vero esisti poco anche se pubblichi per un editore nazionale, mentre esisti molto se pubblichi per un editore nazionale e hai un grande successo, nel senso che fanno un paginone su “la Repubblica”, quattro pagine su “Panorama”, quattro su “L’Espresso”. […] A cosa serve scrivere se la gente non ti legge? Non ha senso, diventa una forma di masturbazione intellettuale».
All’Apologo del giudice bandito, uscito nel 1986, seguì nel 1991 Il figlio di Bakunìn. In questo romanzo, come in tutto il corpus letterario di Atzeni, grande importanza ha la frammentarietà del testo e il vuoto tipografico che ne consegue. Il racconto è spesso spezzato in porzioni brevissime, al punto che alcuni capitoli sono composti da una sola frase.
«L’ho conosciuto a Carbonia. Aveva l’amante e non gli piaceva lavorare».
L’aspetto grafico del testo è funzionale al messaggio dell’autore, come nel caso, appunto, del figlio di Bakunìn, dove il romanzo è costruito come una serie di interviste che il narratore-giornalista riporta fedelmente con l’intento di ricostruire la mitica figura di Tullio Saba.
Nel racconto Bellas Mariposas, invece, sia l’assenza della punteggiatura, che il frequente uso di spazi bianchi, assumono un altro significato. Ci troviamo di fronte a una sorta di monologo-fiume scritto in un pastiche letterario molto composito dal punto di vista linguistico, una sorta di esaltazione del linguaggio, dove una bambina del suburbio cagliaritano narra una storia personale cruda e allo stesso tempo fiabesca.
«mia sorellina si è chiamata Luisella e alle cinque e trentatré
due minuti prima della fine dello spogliarello
è scesa dal letto di corsa è arrivata alla porta del bagno ha provato la maniglia ha detto Pipì pipì
babbo non l’ha sentita urlava Brava brava de aicci beni ainnantis bai cun sa telecamera prus acanta a su stamp’e sa udda brava bagassa
e Luisella si è messa a piangere Pipì voio pipì babbo siemo
e si è pisciata addosso».
L’impasto di termini colti e gergali, di italiano e lingue tagliate à la maniera gaddiana, deriva anche dalla sua esperienza di traduttore. Dice Ernesto Ferrero, in Atzeni «la lingua si configura come la casa, il paese, della letteratura». Lo scrittore conterraneo e amico Giulio Angioni descrive in questo modo lo stile di Sergio: «non ha gentilezze o spaventi muliebri alla Tamaro e nemmeno allegrie celto-italiche alla Benni, dice di sterco e sperma e sangue e sudore e scaracchi e cattivi odori e pessimi sapori, patatine e pecorino, coca-cola e cannonau, maestrale e scarsa pioggia con sabbia di deserti africani, scrive di tristi arrapamenti e di più tristi abbandoni, ma con lontani e straniti echi di speranza» (Il dito alzato, Sellerio 2012).
Nei romanzi come nei racconti, Atzeni mescola dati documentari, storici, folklorici, antropologici ed elementi personali, mentre l’inventio linguistica modella il mezzo espressivo e costruisce il luogo in cui tutto si compone.
Sempre in Bellas Mariposas (pubblicato postumo, nel 1996) trova posto, oltre il racconto omonimo, il suo esordio letterario, pubblicato inizialmente per un piccolo editore sardo nel 1984 con il titolo Araj dimoniu, antica leggenda sarda e riedito nella versione inviata dall’autore all’editore, col titolo Il demonio è cane bianco. Questo è stato il mio approccio alla scrittura di quest’autore e nel suo esordio ho trovato già tutta la sua poetica: c’è la Sardegna con le leggende da lui rielaborate, c’è la fiaba, l’epica e l’incanto, ma soprattutto c’è una scrittura musicale, lirica, accorta e sempre sorprendente.
«È notte, nevica, e la neve copre il fango, i cortili, gli alberi, ogni cosa. L’alba colora le colline a oriente, le fa lucenti, rosa e sangue. La terra di Papale Porcu invece resta nera, come se la notte non volesse lasciarla, volesse strapparla e portarla via. Ma a mezzogiorno il sole la conquista e anche su quella terra la neve è rossa».
In Atzeni convivono due anime della Sardegna, quella contemporanea, vivida e senza filtri, e quella antica, mitica e fiabesca. Ogni ricercata parola corrisponde a un continuo scavare dentro se stesso attraverso quello che ha vissuto e immaginato, e ogni sua esperienza e sofferenza, quasi come non potesse fare altrimenti, attraversa quella sua terra su cui lui è passato leggero.
«Fuggi. Dopo trentaquattro anni ti strappi alla terra dove hai amato, sofferto e fatto il buffone. Ogni angolo di strada testimonia una tua gioia, un dolore, una paura».




 www.flaneri.com
www.flaneri.com