“Mi chiamo Lucy Barton” di Elizabeth Strout
Il ritorno dell’autrice di Olive Kitteridge
di Francesco Vannutelli / 14 giugno 2016
È uscito all’inizio di maggio Mi chiamo Lucy Barton, l’ultimo romanzo di Elizabeth Strout, la scrittrice premio Pulitzer nel 2009 per Olive Kitteridge, diventata nell’arco di cinque libri in diciotto anni uno dei più importanti punti di riferimento della narrativa contemporanea.
Per i lettori affezionati, la prima cosa che salta all’occhio di questo nuovo romanzo è il cambio di casa editrice, da Fazi a Einaudi. Per quelli più attenti, poi, si passa a notare il cambio di traduzione, affidata questa volta a Susanna Basso dopo che gli ultimi tre libri erano stati curati da Silvia Castoldi (il romanzo d’esordio, Amy e Isabelle, lo aveva tradotto Martina Testa). A non cambiare, ed è la cosa che conta, è la grandezza del materiale narrativo.
Lucy Barton è ricoverata da tre settimane in un ospedale di New York che affaccia sul Chrysler Building. All’inizio doveva trattarsi di una banale appendicectomia, poi ci sono state complicazioni, febbre e un’infezione, e il mistero su quando potrà uscire. Un pomeriggio, spostando lo sguardo dalla finestra al centro della stanza, trova sua madre seduta ai piedi del letto. Non si vedono da anni, ma basta un piede strizzato sopra il lenzuolo e un saluto, «Ciao bestiolina», per rimuovere il silenzio. Non c’è la distanza del tempo e dello spazio, tra Lucy e sua madre, quella che va da New York ad Amgash, la piccola comunità rurale dell’Illinois dove è cresciuta e dove la madre vive ancora, quella che separa la vita di una donna diventata adulta, con un marito e dei figli che la aspettano a casa, con un ambizione da scrittrice da coltivare, dall’infanzia di miseria che Lucy ha vissuto.
Non era una vita facile quella ad Amgash, in un garage senza riscaldamento, con un padre con accessi di violenza senza un motivo e la madre sempre pronta ad assecondarlo. «Come sai come sei fatto se l’unico specchio che c’è in casa è un caso piccolissimo impiccato sopra il lavello della cucina, o se non hai mai sentito anima viva dirti che sei bella»? Eppure bastano quei giorni insieme all’ospedale per rimuovere ogni ricordo doloroso. La vita di Lucy si è sempre accontentata di piccoli segnali di affetto per trovare l’amore nell’indifferenza, come quel piede strizzato, o trovare la sala tac nel labirinto dell’ospedale, o una mela candita in una fiera di paese.
La grandezza della scrittura di Elizabeth Strout, da sempre, è nelle piccole cose, nella capacità di elevare a simbolo il dettaglio più insignificante, nel riempire di storia il quotidiano. Mi chiamo Lucy Barton conferma la capacità unica della scrittrice del Maine di raccontare la vita nella sua forma più simile alla realtà.
Il conflitto è uno degli elementi fondamentali dei lavori di Strout e ancora una volta al centro del romanzo finisce un rapporto madre-figlio con tutte le sue difficoltà, nei silenzi che si accumulano lungo le distanze di tempo e strada. Il dubbio di Lucy è il dubbio di tutti i figli: è meglio tacere con i genitori, non far conoscere il proprio risentimento, o è meglio chiedere perché c’è stato il male, come è stato possibile. Nella letteratura di Elizabeth Strout i figli sono sempre vittime pazienti di genitori, basta pensare a Christopher, il figlio vittima di Olive Kitteridge.
Per la prima volta, Elizabeth Strout parla direttamente di scrittura e del mestiere di scrittore in uno dei suoi libri. Lucy è una giovane scrittrice con qualche racconto pubblicato. Quello che sa sulla scrittura lo impara (anche) grazie a una romanziera di successo, Sarah Payne, che incontra per caso «in uno di quei negozi di abbigliamento per cui New York è famosa» e poi partecipando a un suo seminario. È Sarah Payne a spiegare a Lucy come affrontare la scrittura, è lei a dire ai suoi studenti che ciascuno di loro «ha una sola storia», che scriveranno quell’unica storia in molti modi diversi. «Non state mai a preoccuparvi per la storia. Tanto ne avrete una sola».
Forse anche Elizabeth Strout scrive sempre la stessa storia, una storia di madri e figli e del loro rapporto difficile, di anni che aggiungono strati di distanza in cui è sempre più difficile scavare per raggiungersi. Ogni volta che lo fa è un capolavoro.
(Elizabeth Strout, Mi chiamo Lucy Barton, trad. di Susanna Basso, Einaudi, 2016, pp. 160, euro 17,50)
LA CRITICA
Mi chiamo Lucy Barton ripropone i temi centrali della letteratura di Elizabeth Strout. In una forma più concentrata, c’è tutto: il conflitto tra genitori e figli, la grandezza delle piccole cose, l’epica del quotidiano. Ogni volta è la stessa storia, e un romanzo diverso. Un grande romanzo.


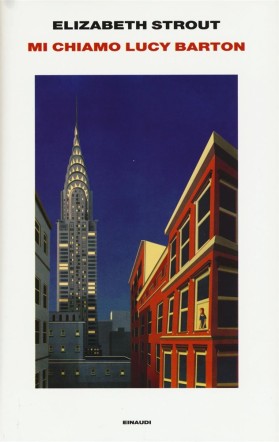



Comments