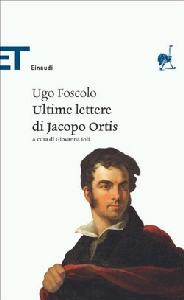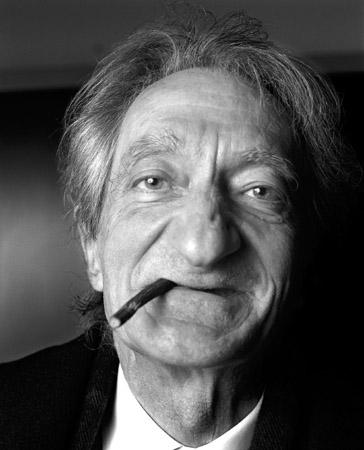Nelle rituali competizioni a eliminatoria diretta imposte dalla vulgata scolastica (Inferno vs Paradiso, Ariosto vs Tasso, Romanticismo vs Illuminismo, ecc.), Le ultime lettere di Jacopo Ortis, fino a un paio di decenni fa, vincevano con facilità il confronto con Promessi sposi o Malavoglia. Ma da allora una tendenza ribassista ha visto scendere implacabilmente le quotazioni del romanzo foscoliano nell’apprezzamento dei lettori liceali e delle nuove generazioni. Esito di cui, forse, sarebbero contenti Gadda, che mal sopportava gli atteggiamenti predannunziani del “vispo Nicoletto”, e Contini, che in un’intervista del 1989 dichiarò a proposito dell’Ortis: “è uno dei libri che detesto di più al mondo”. Eppure quell’esperimento narrativo così ibrido e eccessivo, tanto lontano dagli equilibri a tutto tondo delle strutture romanzesche dell’ottocento, è un lavoro che possiede tutti i numeri per agganciare ancora oggi l’attenzione del pubblico giovanile.
Infatti una volta superata la difficoltà imposta dalla patina arcaica della retorica tragico-lirica, con cui Foscolo cerca di far fronte all’assenza di un linguaggio narrativo italiano, l’Ortis si rivela un romanzo di formazione adolescenziale a tutti gli effetti. D’altronde Foscolo lo compose nel 1798, quando aveva venti anni appena compiuti. Ma il suo nucleo ideativo va retrodatato di altri due anni, al 1796, quando lo scrittore progetta il suo primo e incompiuto romanzo epistolare (Laura, lettere) e resta turbato dalla notizia del suicidio di Girolamo Ortis, suo collega di studi nell’università patavina. Un evento capace di catalizzare tutte le energie irrisolte di un Foscolo diciottenne nella sua prima prova di peso, in cui prendono forma fantasmi, passioni, incertezze, aspirazioni e delusioni di chi si affaccia alla vita adulta con ancora addosso la suggestione di un sogno che sta per dissolversi nei contorni certi del mondo adulto. Insomma l’Ortis come “ritratto dell’artista da giovane”, opera dunque di un Foscolo poco più che adolescente, alle prese con le sue prime e totalizzanti esperienze di apprendistato ideologico, nei circoli democratici veneziani, e di iniziazione erotico-culturale, grazie alle cure di una generosa e affascinante Isabella Teotochi, non ancora risposata Albrizzi, aristocratica trentenne che “si studia di piacere non per altro che per conquistare […]”, come appare nel ritratto che l’autore le dedica nelle vesti della moglie del patrizio M***.
Ma al di là del semplice accidente biografico è la strategia complessiva del testo a farne un romanzo giovanile o, meglio, di formazione adolescenziale. Adolescente è il protagonista. Ma anche il lettore ideale cui Foscolo si rivolge ha il profilo di un adolescente: infervorato dal mito della Rivoluzione francese e dai primi bagliori risorgimentali, deluso dalla deriva autoritaria dell’astro napoleonico, alle prese con le prime incandescenti esperienze amorose, eccitato dalla scoperta di autori e opere che gli rivelano orizzonti inaspettati della propria interiorità e lo proiettano verso un desiderio di assoluto che sta per assumere il nome di Romanticismo. Quello che hanno rappresentato Sulla strada e Il giovane Holden per i ventenni degli anni ’50 e ’60, quando i fermenti che avrebbero poi condotto alla rivoluzione sociale della contestazione erano ancora segnali di una confusa ricerca di identità, trova un’analoga fusione di ribellismo e insofferenza per il buon senso borghese e per l’età adulta nell’inquietudine che il giovane Ortis comunica alle generazioni (pre)risorgimentali. Basta pensare alla rabbiosa reazione con cui il personaggio foscoliano si scaglia contro la morale benpensante dei due sposini nei confronti del suicidio – un’anticipazione di quello del protagonista – del comune amico Olivo P*** (“voi dunque perché siete favoriti dalla fortuna vorreste essere onesti voi soli […] e illudere in questo modo la vostra coscienza? […]”, lettera del 17 Aprile). Una intransigenza morale, un istintivo rifiuto dei compromessi che nell’Italia dei primi anni dell’800 provocò effetti di immedesimazione emotiva ed eccitazione psicologica così forti da essere alla radice di un’ondata di suicidi giovanili simile a quella che, nel 1994, ha accompagnato per diverse settimane la fine di Kurt Cobain. Tanto che il professor Cesarotti, allora docente di fama dell’università patavina e intellettuale di grido tra le nuove generazioni per la sua traduzione dell’Ossian,in una lettera del 1802 avvertiva il suo dotato ex allievo Foscolo: “Del tuo Ortis non ho voglia di parlarne. Esso mi desta compassione, ammirazione e ribrezzo […] è un’opera scritta da un Genio in un accesso di febbre maligna, d’una sublimità micidiale e d’una eccellenza venefica”.
In ogni caso il tema del suicidio costituisce uno dei motivi ricorrenti nelle storie di ambientazione giovanile (tra i tanti esempi: la morte volontaria di Neil Perry nell’Attimo fuggente o quella di Martino, l’amico-Mr. Hyde di Alex, protagonista di Jack Frusciante è uscito dal gruppo) ed è un elemento chiave per capire il profilo adolescenziale del protagonista foscoliano. Al di là delle motivazioni biografiche da cui nasce l’interesse foscoliano per il suicidio – quello del fratello Giovanni e quello dello studente Girolamo Ortis –, la scelta di farne fin dalle prime battute (“mi caccerei un coltello nel cuore […], lettera del 13 Ottobre) il basso continuo del romanzo è frutto di una strategia narrativa che punta a suscitare una incondizionata proiezione identificativa nel suo lettore ideale, così come postulato in apertura dall’amico-editore Alderani (“darai, spero, la tua compassione al giovine infelice dal quale potrai forse trarre esempio e conforto”).
Un altro aspetto che concorre a fare dell’Ortis un romanzo adolescenziale è il pastiche sentimental-politico, con una prevalenza del primo elemento sul secondo. Infatti nell’edizione Marsigli del 1798 il tema patriottico resta sullo sfondo come una massa minacciosa e imprecisa, che serve a dare rilievo all’incandescente emotività del protagonista. Ma anche nell’edizione del 1802 e in quella zurighese del 1816, in cui il testo subisce una più decisa sterzata nazional-patriottica, il romanzo resta indefinito in programmi, circostanze, nomi e riferimenti alla tumultuosa esperienza del triennio giacobino italiano che pure costituisce il fondale della narrazione. Un po’ quello che succede con gli eventi del ’77 bolognese nelle pagine del Boccalone di Palandri o con le riflessioni sull’attentato al giudice Falcone presenti nel Jack Frusciante di Brizzi, che valgono più come spie di una inquietudine di fondo che come indizi di un progetto sociale ben definito. Con Boccalone e Jack Frusciante, l’Ortis condivide anche altri aspetti del Bildungsroman giovanile italiano. A partire dalla casuale, ma significativa, relazione che tutti e tre i testi intrattengono con Bologna, fino al bisogno condiviso di ricostruire il sound di un’epoca e i gusti di una generazione attraverso dei puntuali riferimenti a autori, libri o musiche che ne hanno accompagnato lo sviluppo. La funzione che nel Boccalone è svolta dalle citazioni dei Beatles, di Battisti, del Giovane Holden, nel romanzo di Brizzi è rappresentato dalla fittissima serie di agganci alla musica punk rock (Pogues, Sex Pistols, ecc.), a Blade Runner, ma anche ai romanzi di De Carlo e Tondelli o ai fumetti di Pazienza. Non bisogna però scordarsi che quando Ortis celebra Omero, Dante e Shakespeare (“hanno investito la mia immaginazione ed infiammato il mio cuore […], lettera del 13 Maggio) o allude in maniera più o meno esplicita a Ossian e a Wieland, non sta citando quelli che da noi sono percepiti nella luce solenne ma museale dei classici. Per la nuova generazione che si affaccia alla soglia del primo ottocento quelli sono testi e autori antiaccademici, anticonvenzionali, che incarnano un desiderio di novità e di protesta, sono compagni di strada nella evoluzione di un percorso di ricerca dell’identità di una generazione che, nel giro di poco tempo, prenderà il nome di romantica.
Infine, anche l’enfasi gesticolante del libro foscoliano, la sua irruenza scomposta ma autentica, tornano nelle pagine dei suoi nipotini di fine novecento. Se non fosse per qualche spia ortografica o lessicale, chi saprebbe riconoscere al primo colpo la paternità di frasi come queste?
- “Nella sofferenza pressoché ininterrotta che mi ha tenuto prigioniero da ottobre a febbraio si aprono dei buchi, dolci deliri in cui desidero la morte, la liberazione dal male”;
- “Mi assumo mille argomenti; mi s’affacciano mille idee: scelgo, rigetto, poi torno a scegliere; scrivo finalmente, straccio, cancello e perdo spesso mattina e sera: la mente si stanca, le dita abbandonano la penna, e mi avvengo d’avere gittato il tempo e la fatica”;
- “pensieri ribollenti mi si agitano in testa mentre sono qui tutto solo in camera mia. L’interrogativo che mi ha abbastanza attanagliato nelle ultime due settimane – passo ulteriore, o forse semplice presupposto della mia teoria sulla Commedia Totale: che senso ha essere sinceri, nella vita?”
A questo punto perché non pensare che il titolo Jack Frusciante è uscito dal gruppo sia un omaggio cifrato all’Ortis foscoliano? Brizzi – si sa – decise di cambiare il nome del chitarrista dei Red Chili Hot Peppers, John Frusciante, simbolo di quell’“uscire dal gruppo” che è la nota dominante del romanzo, per non incorrere in problemi legati al diritto d’autore. Ma perché ha scelto di ribattezzare il suo idolo musicale proprio Jack? Forse perché Jack è anche il diminutivo di Jacopo, Jacopo Ortis, il riflesso postmoderno e in chiave rock di quel lontano antenato letterario che per primo ha seguito l’istinto di “uscire fuori dal gruppo”?
Soluzione: a) Boccalone; b) Le ultime lettere di Jacopo Ortis; c) Jack Frusciante è uscito dal gruppo.
Carlo D’Alessio è nato a Roma (1965), dove ha conseguito il dottorato di ricerca in Italianistica. Attualmente vive e lavora in Spagna, come Lettore di italiano dell’Università di Saragozza. Ha pubblicato numerosi interventi di filologia e critica letteraria, tra cui i volumi: Lune di giada. Poesie cinesi tradotte da Arturo Onofri (Roma, Salerno Editrice, 1994); Il poema necessario. Poesia e orfismo in Dino Campana e Arturo Onofri (Roma, Bulzoni, 1999); Carteggi Cecchi – Onofri – Papini (1912 – 1917) (Milano, Bompiani, 2000). È anche autore di racconti, usciti a più riprese su «Galleria» e «Nuova prosa», e di poesie pubblicate in «Fermenti». Nel 2009 ha dato alle stampe il romanzo Solo la penombra (Milano, Lampi di stampa).