Libri
Come nella nebbia
Gli invisibili di Eliane Brum nel Brasile contemporaneo
di Elisa Carrara / 29 settembre
Si potrebbe scegliere una strada sicura per raccontare il libro della reporter brasiliana Eliane Brum Le vite che nessuno vede (Sellerio, 2020), ossia affidarsi alle parole dell’avvincente e rigorosa prefazione (scritta dalla stessa autrice), e disquisire sul senso della professione giornalistica, su cosa significhi scovare storie, spogliarsi della propria identità per indossare i panni altrui, «vestire la pelle dell’altro». Sarebbe sicuramente una scelta saggia, quantomeno corretta, se non fosse che l’autrice, ha saputo affrontare l’argomento con una tale dose di audace idealismo, che aggiungere altro sembrerebbe quasi commettere un sacrilegio. Perché questa raccolta di reportage insegna che essere un giornalista significa anche saper usare (e misurare) le parole per raccontare ciò che è al di fuori di noi: il primo passo non è varcare la soglia di casa e calpestare un terreno sconosciuto, ma compiere un «movimento radicale» e interno, «la necessità di disabitare sé stessi per abitare l’altro».
A questo punto ci si potrebbe inoltrare in un territorio più impervio, scrivere della politica di Bolsonaro o di Lula e cercare di avvicinarsi al Brasile, e alle sue lotte, se non fosse che la narrazione di questo Paese è offuscata dallo sguardo intransigente di chi si trova dall’altra parte del mondo. Il sentire comune tende, infatti, a voler costringere in un’unica immagine imprecisa, uno Stato vasto e complesso. Il Brasile, spiega Eliane Brum, è invece un Paese declinato al plurale: per comprenderlo occorre tendere l’orecchio e ascoltare il brusio delle vite minuscole che lo popolano.
A dispetto del titolo, non c’è nulla di visivo in quest’opera: le vere protagoniste sono le parole, le voci, la scrittura. Per rendere giustizia a questi 17 reportage, o meglio alle storie che hanno dato forma alla rubrica che Eliane Brum ha tenuto ogni sabato sul giornale “Zero Hora” alla fine degli anni Novanta, intitolata proprio La vita che nessuno vede, e a quelle raccolte nel settimanale “Época” all’inizio del nuovo secolo, bisognerebbe, forse, partire da una frase, scovata anch’essa tra le pieghe dell’introduzione: «la vita è caos, un caos senza senso. Quello che mi affascina è il modo in cui ognuno inventa una vita, per quanto nudo e con pochissimi mezzi».
In Amazzonia si nasce tra mille donne, come racconta nel primo articolo “La foresta delle levatrici” (sconsigliato a chi non ama Marquez e il realismo magico, dai quali attinge con eccessiva ingordigia, atmosfera e stile). E si muore soli o accanto ai propri figli, in un letto d’ospedale, come Ailce de Oliveira Souza, protagonista dell’ultimo capitolo, che a 66 anni dopo una vita spesa a nutrire gli altri, scopre di avere un tumore e si consuma lentamente, fino a non avere più le forze e la volontà di mangiare, senza pronunciare mai, neppure una volta, la parola cancro. La malattia le appare come un inganno amarissimo, arrivato nel momento più sereno della sua vita, nel periodo in cui, senza più un marito e dei figli dei quali occuparsi, la parola libertà cominciava ad assumere contorni reali: non solo un insieme di sillabe, ma una serie di azioni e di gesti pacificatori ripetuti nel tempo.
Morire nella normalità è ancora possibile: in una società che dimentica la morte, al punto da trovare ogni giorno modi nuovi per nasconderla allo sguardo, Eliane Brum ne descrive i segni quotidiani, le abitudini, i rituali. «Non c’è niente di più triste del funerale di un povero. Perché il povero comincia a essere sepolto in vita»: si muore – e si vive – senza avere i soldi per la propria tomba o per quella dei propri bambini; si muore di malattia, di vecchiaia. Si muore di lavoro, con sintomi rivelatori della fine che si nascondono ovunque, nel rumore costante del respiro del signor T., che ha trascorso l’intera esistenza a contatto con l’amianto.
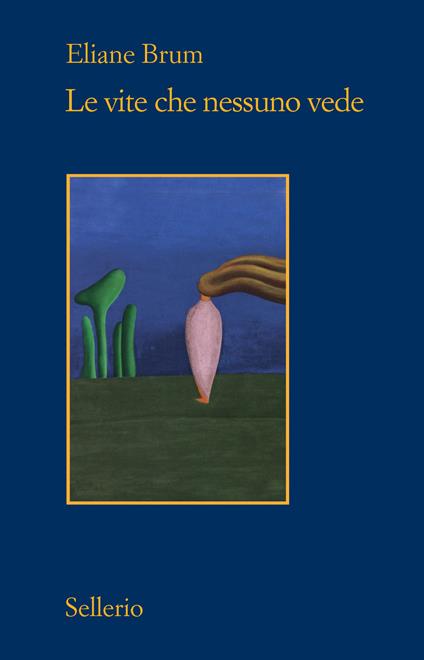
«Ci raccontiamo storie per sopravvivere», scriveva Joan Didion: frase fin troppo abusata, come gran parte dell’opera della giornalista e scrittrice americana, che però fa giustamente capolino anche nel libro del reporter David Rieff, dedicato alla malattia di sua madre, Susan Sontag (Senza consolazione. Gli ultimi giorni di Susan Sontag, Mondadori, 2008). Molti trascorrono la vita a raccontarsi incessantemente una storia sbagliata e crudele: ossia sentirsi speciali, diversi, talmente eccezionali da essere destinati alla sopravvivenza. Perdere la speranza è un’impresa difficile per chi sta morendo: la maggior parte delle persone, racconta Rieff, si aggrappa a una parola, una percentuale, a uno studio citato distrattamente dal medico. Chiunque abbia letto Sontag sa quanto la singolarità e la comprensione viscerale delle cose siano elementi essenziali della sua scrittura.
Ma comprendere non significa essere immuni alla sofferenza. Per questo gli uomini e le donne di Eliane Brum sono distanti anni luce dalla vita di Susan Sontag e di Joan Didion, perché non hanno la minima traccia neppure dell’illusione di sentirsi speciali. Sanno di vivere una vita che nessuno vede e che l’eccezionalità non esiste. Eppure, non possono fare a meno di raccontarsi delle storie, bellissime e altrettanto crudeli. Come quella di Vanderlei Ferriera, l’uomo che ogni anno si presenta alle fiere di bestiame a cavallo di un manico di scopa: «senza un po’ d’invenzione la vita non ha gusto», risponde quando Eliane Brum gli chiede se sia consapevole che il suo cavallo è, in realtà, solo un pezzo di legno.
Sono uomini e donne nudi, traditi dalla vita, ingannati dalle promesse di un futuro migliore, beffati dalla società: il mondo narrato in questo libro è il racconto intimo e universale di chi sopravvive tra la polvere e il fango, di chi cade e non si rialza, non perché non ne abbia il coraggio, ma perché sa che alzarsi non cambierebbe le cose.



 www.flaneri.com
www.flaneri.com