“Montaigne” di Stefan Zweig
di Mario Massimo / 9 maggio 2014
Ad attrarre, in un libro come questo Montaigne di Stefan Zweig (Castelvecchi, 2014), può essere l’idea di entrare in un contatto più diretto, più umano, con una delle grandi ombre del passato: di accostarvisi, cioè, dal punto di vista degli aspetti più concreti, comuni dell’esistenza – la famiglia in cui si nasce, la casa in cui si abita, il modo in cui ci si mescola ai propri simili, o ci si procura di che vivere – dopo averne, forse in una delle letture obbligate dell’adolescenza, sfogliato con segreta partecipazione le pagine. E tanto più, una simile curiosità sembra destinata a venir soddisfatta, se si bada al nome dell’autore: magari dopo aver appena letto l’appassionata silhouette tracciata da Zweig di un’altra di quelle grandi ombre letterarie, Dostoevskij, e solo pochi mesi prima tradotta, meritoriamente, dalla stessa casa editrice.
Certo, qualcosa di meno risolto c’è, in quest’ultimo lavoro di Zweig: sicuramente, a causa della morte, così oscuramente cercata insieme alla sua giovane compagna nell’esilio sudamericano, che ha lasciato alcuni brani del testo in una redazione non definitiva; e tuttavia quel profilo umano di cui prima si diceva, ugualmente finisce per delinearsi davanti ai nostri occhi, e sia pure in una forma in qualche misura più essenziale, scarna. Anche perché è lo stesso Montaigne, a non aver lasciato, negli Essais, quasi nessun cenno ad altro che non fosse il proprio ritratto interiore: «Sono tutto meno che uno scrittore di libri. Il mio interesse è dar forma alla mia vita, questo è il mio unico lavoro e la mia unica vocazione»; o, in maniera ancora più esplicita, parlando della sua preferenza per le biografie: «ai biografi interessa di più quel che succede dentro di ciò che accade fuori. Per questo Plutarco, più d’ogni altro, è l’uomo che fa al caso mio».
Solo a fatica, del resto, (e forse, più per aderire al programma filosofico-stoico del distacco da ogni legame mondano) lo vediamo insistere sulle proprie incapacità: «Di destrezza e di abilità pratica, non ne ho nessuna. […] Nella musica, né per la voce, che avevo così inetta, né per gli strumenti, mai mi si è potuto insegnare nulla, […] né ho mai saputo far la punta a una penna o tagliare a tavola come va fatto, o ancora mettere la sella a un cavallo, reggere sul pugno un falcone e lanciarlo a volo, o parlare ai cani»; o, quando la morte di suo padre lo mise, nel 1568, a trentaquattro anni, di fronte ai suoi doveri di amministratore del patrimonio nobiliare, il fastidio estremo di doversi «imporre di leggere da cima a fondo i contratti o di esaminare le transazioni che necessariamente passavano per le mie mani e dovevano essere da me controllate. […] Avrei fatto tutto, piuttosto che leggere un contratto».
Zweig però non si lascia disarmare da questa ostentata impenetrabilità; anche se rileva non senza un filo di disapprovazione che: «A questa madre di sangue ebreo, con la quale vive per oltre mezzo secolo nella stessa casa e che addirittura sopravvive al famoso figlio, Montaigne non dedica una sola parola nelle sue opere e nei suoi scritti», come per altro «non parla nelle sue opere né della propria moglie, né di sua figlia, fatta eccezione per un’unica dedica». Viene così rintracciata caparbiamente la genealogia di commercianti di pesce che il bisnonno Ramon si era incaponito a cancellare pagando in denaro sonante il castello e il titolo di Sieur de Montaigne, e l’unione del nipote di lui ormai nobile con la figlia di un uomo d’affari ebreo, a sua volta cristianizzato e profugo da Saragozza; e quando infine Zweig commenta, di Montaigne, «possiamo solo dire che, grazie a questa miscela, egli era predestinato a diventare un uomo del centro e dell’unione, […] uno spirito libero e tollerante, figlio e cittadino non di una razza o di una patria, ma del mondo, oltre i Paesi e il tempo», ci sembra di vedere, in filigrana, il ritratto di lui, Zweig, o di qualche altro degli intellettuali della Vienna fin-de-siécle: Hofmannsthal in cui al sangue ebraico dei molti antenati si era mescolato quello italiano della nonna paterna, o Mahler fattosi cristiano cattolico perché non c’era altro verso di avere la carica di direttore dell’Opera di Vienna, o Musil che sembra aver mutuato la privazione di qualsiasi “specificità” del suo Ulrich proprio dalla mancanza di ogni attitudine che Montaigne si attribuisce.
E magari quello che più resta impresso, di quest’uomo minuto di complessione, passato fra obblighi amministrativi, incarichi politici e perfino un paio di missioni diplomatiche fra Enrico III ed Enrico di Navarra, con l’impenetrabilità di una goccia di petrolio nell’acqua, la cosa, si diceva, che rimane nella memoria è la camera in disuso («il luogo più inutile della casa») che lui scopre in una torre del castello di Montaigne e, fattala attrezzare a libreria, «All’età di trentotto anni […] disgustato da molto tempo dalla schiavitù della corte e dagli incarichi pubblici», vi si ritira a «riposare sul seno delle dotte vergini», le Muse cioè, sperando di restarci per tutti «i giorni che avrà ancora da vivere»: la cosa, si direbbe, che ce lo rende simpatico più di ogni programma di eroico, algido stoicismo.
(Stefan Zweig, Montaigne, trad. di Ilenia Gradante, Castelvecchi, 2014, pp. 128, euro 16,50)


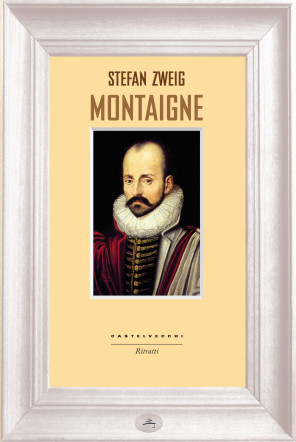



Comments