Insegnami a non avere paura
Intervista a Andrew O’Hagan, autore di “Effimeri”
di Davide Tamburrini / 23 luglio 2022
«Take me out tonight, where there’s music and there’s people and they’re young and alive». Era il 1985 e la scena musicale britannica era infiammata dalla voce melanconica e suadente di Patrick Morissey, che dal palco sputava la sua noia strascicata elegantemente, come se non gli importasse nulla di quello che stava dicendo o facendo in quel momento.
La fine della Beatlemania aveva lasciato dietro di sé i postumi di una generazione delusa, anticonformista, che non si riconosceva più nelle parole limpide e chiare dei baronetti e viveva nei boroughs dispersa fra Londra, Liverpool e Manchester.
Sono gli anni del thatcherismo imperante, dei minatori e degli operai delle fabbriche in sciopero, del postpunk, della rabbia sociale covata sottopelle pronta a esplodere cieca dopo anni di repressione coatta. Migliaia di Zanardi con le mani in tasca e la bocca colma di risentimento che invadono le strade, vomitando nichilismo anestetizzati dall’alcol e il fumo.
Una cultura sotterranea che vive tra i negozi di dischi e cerca di sbarcare il lunario come possibile, all’interno di situazioni difficili che hanno spesso per protagonisti genitori incapaci di comunicare con i propri figli o nel peggiore dei casi totalmente assenti. Un mondo in cui sperare di stabilire un legame di affetto con qualcuno è da considerarsi ancora come qualcosa di prezioso, a cui attaccarsi con tutte le proprie forze in cerca di un sentimento di appartenenza, di rivendicazione sociale.
Effimeri di Andrew O’Hagan, edito Bompiani nella traduzione di Marco Drago, è la storia di un’amicizia, quella fra James, detto “Noodles”, e Tully Dawson, entrambi nati fra i confini dell’Ayrshire, a pochi chilometri da Glasgow. Due vite complicate che si incontrano e si riconoscono consumando la loro adolescenza fra progetti e sogni sussurrati in cima alle bitte dei canali, i cantieri in costruzione che si espandono all’orizzonte.
James è più riflessivo, ama leggere il Bardo e recitare i versi di Yeats, mentre Tully è impulsivo, pieno di spirito e pronto a spiccare il volo, non una farfalla ma «più l’aria che la trasporta», il tipo di persona che è sempre l’anima della festa e non si riesce a trattenere.
E la più grandiosa delle feste si presenta finalmente nel 1986 quando i due ragazzi assieme a una combriccola di amici decidono di partire per un fine settimana a Manchester, per assistere dal vivo al “Festival della decima estate” che si terrà al G-Mex (una vecchia stazione ferroviaria riconvertita in uno spazio adibito a ospitare concerti). L’evento, organizzato da Factory Records – un’etichetta discografica indipendente capace di riunire band del calibro di The Smiths e New Order – è un inno alla vita punk, alla giovinezza, al sentirsi liberi, ribelli e senza regole, l’occasione per molti di un riscatto atteso a lungo. Un’estate che sarà capace di cambiare il loro modo di percepire il mondo, il ricordo fondante di un’amicizia che durerà per sempre, la gloria di aver avuto amici così, come urlano in esergo i versi di Yeats.
La prosa di Effimeri si snoda come un serpente, fra quadri diversi colmi di giochi di parole, citazioni cinematografiche e musicali («il titolo, se non mi sbaglio, era “Love Will Terrace Apart”»), da cui emerge il cuore pulsante di una generazione, quella degli anni Ottanta, la cui identità viene delineata per così dire dall’interno, senza abbandonarsi mai a eccessive descrizioni di contesto.
La prima parte del romanzo si chiude con la voce di Morissey («è più grande di Gesù») che al G-Mex canta del panico per le strade di Carlisle mentre Limbo, uno degli amici del gruppo, qualcosa a metà fra Sick Boy e Jeffrey Lebowski, si arrampica sugli altoparlanti fino a sbucare sul palco, ballando e sorridendo per l’eternità, la folla che lo acclama e spande luce verso di lui, mentre Manchester si trasforma nel «sinonimo di quello che eravamo stati tutti insieme».
Poi improvvisamente la sceneggiatura cambia, e ci ritroviamo nel 2017. Sono passati poco più di trent’anni da quei giorni a Manchester e alla fine come spesso accade la vita ha tolto ma ha anche dato. Limbo è morto, portandosi con sé un intero mondo di risate, James è diventato uno scrittore di successo e Tully ha una cattedra in inglese nell’East End di Glasgow. Tutto sommato le cose non sono andate poi così male per quei due ragazzi nati senza nessuna prospettiva futura allettante. Tuttavia, gli eventi subiscono una decisa impennata quando di ritorno da una cena James riceve una telefonata di Tully che lo informa di essere un malato terminale. Cominciano così mesi difficili, in cui invece di abbandonarsi al vittimismo i due cercano in tutti i modi di riavvicinarsi alla vita, godendosi insieme gli ultimi istanti che il tempo ha concesso loro.
Sono pagine di un realismo denso, dove a situazioni difficili si alternano momenti di delicata leggerezza, immagini che spesso assumono la forma sottile dei ricordi, di due menti che hanno il potere di comunicare su frequenze parallele, distanti dai pensieri comuni della gente. Prima Tully decide di sposarsi, poi insieme alle loro rispettive compagne, Anna e Iona, i due amici decidono di partire alla volta di Taormina, per un’ultima vacanza spensierata. «Induciamo la morte a essere orgogliosa di ghermirci», ripeteva la Cleopatra di Shakespeare, ormai conscia del suo destino funesto. La stessa frase che James e Tully ripetono da quando sono ragazzi, e che ora quasi fosse un mantra guida le loro decisioni e le loro scelte di vita, senza che ci sia più la possibilità di guardarsi indietro.
Alla fine, paradossalmente, sarà la fedelissima di Dio, Gemma, la credente, a schiarire le paure di James, in un incontro-scontro sul tema della morte. «Mi sono concesso il lusso di dimenticarmi che tutto è effimero», si abbandona a dire Noodles, sconsolato. Ma questo non è l’essenziale, sembra dirci Andrew O’Hagan. Questo è un errore che facciamo tutti. Ciò che noi possiamo fare è stare vicini alle persone che amiamo e lasciarci semplicemente andare, senza aver paura di camminare insieme.
Di Effimeri abbiamo parlato con l’autore, in occasione del festival Letterature, tenutosi a luglio a Roma.
Mi piacerebbe cominciare dal titolo, Mayflies (“efemere”), che ricorda fin da subito la fugacità di questo insetto e il suo breve stare al mondo. Come ti è venuto in mente di sceglierlo? In italiano, forse per assonanza, il libro è stato tradotto a partire dalla parola ephemeral, “effimero”. Puoi spiegarci questa scelta?
Un’efemera è un insetto che vive solitamente uno o due giorni. Il titolo mi è venuto in mente molto velocemente, volevo un simbolo che rappresentasse la brevità dell’esistenza, e l’ho trovato in quest’essere che fa tutte le esperienze della vita in un tempo estremamente breve, un simbolo che rappresentasse l’uomo (Tully) nel libro. Volevo che questo fosse il tema del romanzo, e il titolo mi è arrivato come un lampo, fissandosi nella mia mente per non lasciarmi più. E oltre a essere un simbolo o una metafora, è anche il correlativo oggettivo dell’uomo, un’immagine che gli dà speranza nell’affrontare gli eventi che gli capitano.
Guardando ai tuoi libri precedenti, come Stammi vicino o Bravissima, mi viene la sensazione che il centro della tua attenzione sia spesso focalizzato sull’uomo. Figure umane, ma non maschere, che si trovano ad affrontare delle sfide che spesso le portano a confrontarsi con sé stesse, qualcosa che mi ricorda in un certo senso alcuni dei personaggi nei film di Ken Loach.
Sì, penso ai romanzi di Henry James, a quelli che chiamava the drama of incidents, the novel of problems. Ci svegliamo tutti i giorni affrontando i nostri problemi, piacevoli o dolorosi che siano. Credo che a volte come lettori guardiamo ai romanzi cercando un aiuto per vivere la nostra vita e anche per suscitare risposte e percezioni che altrimenti non si verificherebbero mai. A volte capita che ti approcci a un romanzo cercando una sorta di guida morale e un luogo in cui la vita è drammatica in un’ambientazione e un modo differenti da quelli in cui vivi tu. Amo i romanzi che riescono a costruire questo tipo di architettura e ho cominciato a volerlo fare anche io per avere l’opportunità ogni volta di portare il lettore in un viaggio verso situazioni “scomode”. Voglio che il lettore si immerga nel libro, ma senza dare nessuna lezione, sperando solo che questi apprezzi il libro per la vita che viene rappresentata al suo interno.
Una delle cose che ho più apprezzato in Effimeri è il modo in cui sei riuscito a ricreare un contesto, una cultura, che è quella della generazione degli anni Ottanta, senza però indulgere in alcuna spiegazione o descrizione. Qualsiasi generazione crea i suoi miti e quindi le sue battute, il suo linguaggio, e tutta una sua forma di esistere che trae forza dal suo essere incatalogabile. Secondo me il più grande pregio di questo libro è come hai dato vita a quest’atmosfera, al senso di un gruppo che ha e definisce i propri codici senza che questi siano comprensibili alla maggior parte della gente, specialmente alle vecchie generazioni.
Sì, questo per me è un gran complimento perché è stata una questione prettamente tecnica a cui ho lavorato molto. Penso che nessuno voglia leggere un romanzo in cui una persona si colloca al di sopra degli altri descrivendo il mondo e la vita dei giovani come in un saggio. Questa vita deve esplodere da sola nella pagina, con tutta la sua irruenza. Il tuo scopo come scrittore è riuscire a far vivere i personaggi sulla pagina, tutta la loro cultura fatta di citazioni, dalle canzoni ai film, dai The Smiths ai Joy Division. E non è importante se come lettore non riesci a cogliere tutte quante le citazioni, la loro cultura troverà ugualmente un modo per raggiungerti e colpirti. Ogniqualvolta leggo un romanzo, che sia italiano, americano o francese, e mi immergo in un mondo che non è il mio, mi sento felice.
Ho letto una tua precedente intervista in cui a un certo punto affermi che la generazione cresciuta negli anni Ottanta sta cominciando a trovare un suo posto, quello giusto, solo ora.
A volte capita che una generazione arrivi in un momento perfetto della Storia creando con questa un impatto fortissimo, così come è capitato ai nostri genitori negli anni Sessanta. Erano stanchi della loro società, dei valori che la dominavano derivati dalla Seconda guerra mondiale, stanchi di tutta l’ideologia; il femminismo cominciava a farsi sentire, la musica era tutto, c’era la coscienza di un’intera rivoluzione. E noi negli anni Ottanta eravamo i figli di quella generazione, arrivati con un senso di sconfitta schiacciante. Ma abbiamo reagito, il thatcherismo invadeva la nostra società e c’era un senso costante di malinconia, di gioiosa depressione, un postindustrial wasteland feeling che credo solo adesso cominci davvero a curarsi.
Una delle parti più belle è secondo me il finale. Mi sembra racchiudere un po’ la risposta a tutte le domande che vengono in qualche modo poste nel libro. A parte il bellissimo confronto con la credente Gemma, che scioglie definitivamente tutte le paure di James, sembra quasi che alla fine sia solo l’accettazione di tutto quello che sta accadendo a rendere più pieno il viaggio, la coscienza di quanto tutto sia profondamente effimero. Ma a volte capire non è abbastanza, bisogna accettare, anzi interiorizzare per essere realmente liberi. Proprio ciò che succede a James e Tully, di modo che il romanzo si potrebbe interpretare come un lungo percorso verso la libertà. Che è un po’ il concetto di And make Death proud to take us («Induciamo la morte a essere orgogliosa di ghermirci»).
Sì, quello che James impara in quella scena è che devi affrontare la vita con coraggio. Tra molti anni tutte le persone intorno a noi non ci saranno più, forse questi edifici che ci circondano resteranno ma noi no, e se non lo capiamo vivremo questa vita sotto una falsa prospettiva. Ed è esattamente quello che stava facendo James, fino a quel momento, anche se il libro non ha una chiave religiosa. E alla fine poi la frase di Shakespeare, And make Death proud to take us. Quello che Gemma gli sta chiedendo è: Vuoi vivere per sempre? Vuoi che la morte di Tully sia una tragedia? No, trasforma questa morte in una festa e sii grato del tempo che avete avuto a disposizione per stare insieme. Mi sembra come se questa scena l’abbia scritta per tutta la mia vita, è venuta come un lampo, come se l’avessi avuta dentro da sempre.


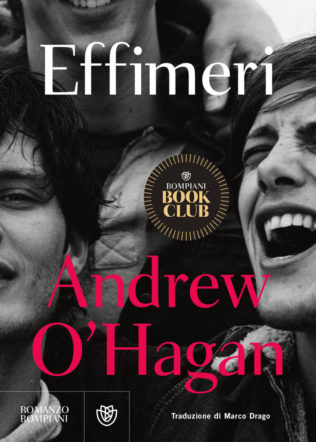



Comments