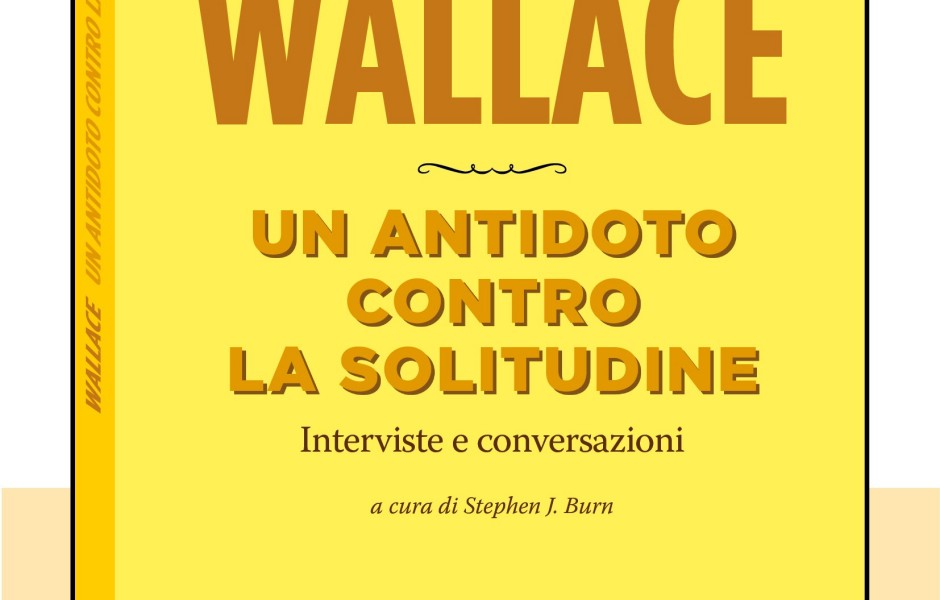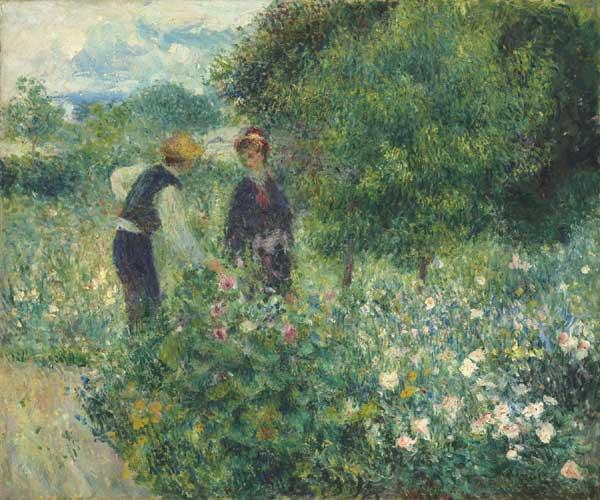«Quando avvistava un autostoppista per la prima volta, Isserley non si fermava mai, si concedeva un po’ di tempo per prendergli le misure. Quel che cercava erano i muscoli: un pezzo d’uomo ben piantato sulle gambe. Di esemplari gracili, pelle e ossa, non se ne faceva nulla».
Fin dalle prime righe di Sotto la pelle, Michel Faber catapulta il lettore nell’azione, lungo le strade provinciali delle Highlands scozzesi: sulla A9, Isserley guida, ed è in cerca di autostoppisti. Perché scelga con tanta minuziosità solo un certo tipo di autostoppista, dove intenda portarlo, e soprattutto perché, sono misteri che verranno svelati passo passo dall’autore con superba regia, in modo ambiguo e mai esaustivo, spingendo il lettore verso ipotesi differenti e costringendolo ad abbandonarle via via, dopo ogni spiraglio di comprensione. Freddezza, crudeltà, assenza di empatia, dalle prime pagine ci si aspetta un seguito di violenza e sesso, e quindi un noir. Ma l’ipotesi noir avrà vita breve, non passerà molto prima che appaiano nei pensieri di Isserley alcuni strani termini incomprensibili, che non verranno mai spiegati dall’autore, termini appartenenti a un’altra cultura, a un’altra civiltà, forse addirittura a un’altra specie vivente: «I vodsel non sapevano fare nessuna delle cose proprie degli umani. Non potevano siuwil né mesnishtil, non avevano il concetto di slan. Nella loro brutalità non si erano mai evoluti abbastanza da usare l’hunshur; le loro comunità erano così rudimentali che l’hississins non esisteva ancora; né queste creature sembravano manifestare il bisogno di un chail e nemmeno del chailsinn».
Non noir, ma fantascienza, dunque? Le informazioni fondamentali per la comprensione di ciò che sta avvenendo verranno concesse senza alcun colpo di scena, attraverso una sorta di banale svelamento dell’evidente, e la prospettiva con cui gli eventi e i personaggi venivano osservati e valutati fino a quel momento dal lettore muterà per l’ennesima volta.
Da che parte stare? Con chi identificarsi? Quanto può essere labile la barriera tra Bene e Male, Giusto e Sbagliato, Umano e Inumano? Impossibile procedere oltre nel racconto, senza rischiare spoiler involontari.
Il romanzo si svela lentamente, sconvolge e polemizza in modo sottile, contrapponendo la crudeltà degli esseri viventi alla bellezza silenziosa e ipnotica della natura scozzese. Persino lo stile asciutto, sintetico, a tratti ripetitivo, viene abbandonato solo e unicamente nei brevi momenti di descrizione della natura circostante, momenti nei quali Faber concede immagini di un lirismo appassionato: l’incanto della pioggia che cade, la neve candida che tutto ricopre, il mare in tempesta. La storia cresce e muta insieme alla consapevolezza e alla sensibilità del lettore e della protagonista, quest’ultima costretta in un corpo fino all’ultimo disconosciuto e odiato, a lei innaturale e causa di sofferenza; con fatica, persino lei alla fine si renderà conto, però, di quanto “sotto la pelle” si sia tutti uguali, umani e non. Spetta a noi decidere se accogliere la polemica di Faber, se far nostre le riflessioni esistenziali che, inevitabilmente, ne conseguono, e scegliere quindi più consapevolmente se continuare a definire noi stessi e gli altri in base alle differenze che ci distinguono, oppure se iniziare a farlo in base alle somiglianze che “sotto le apparenze” ci accomunano.
(Michel Faber, Sotto la pelle, trad. di Luca Lamberti, Einaudi, 2000, pp. 268, euro 10,50)