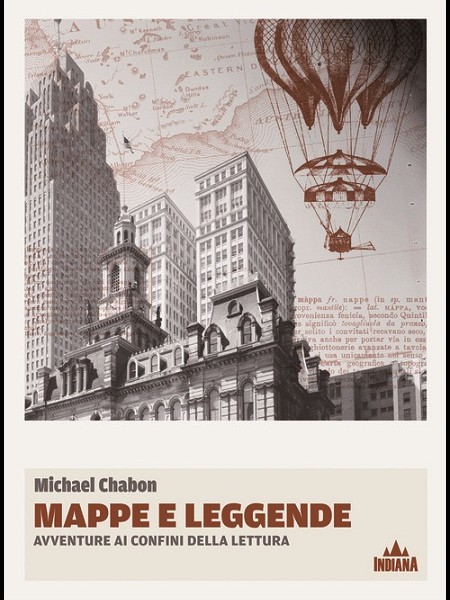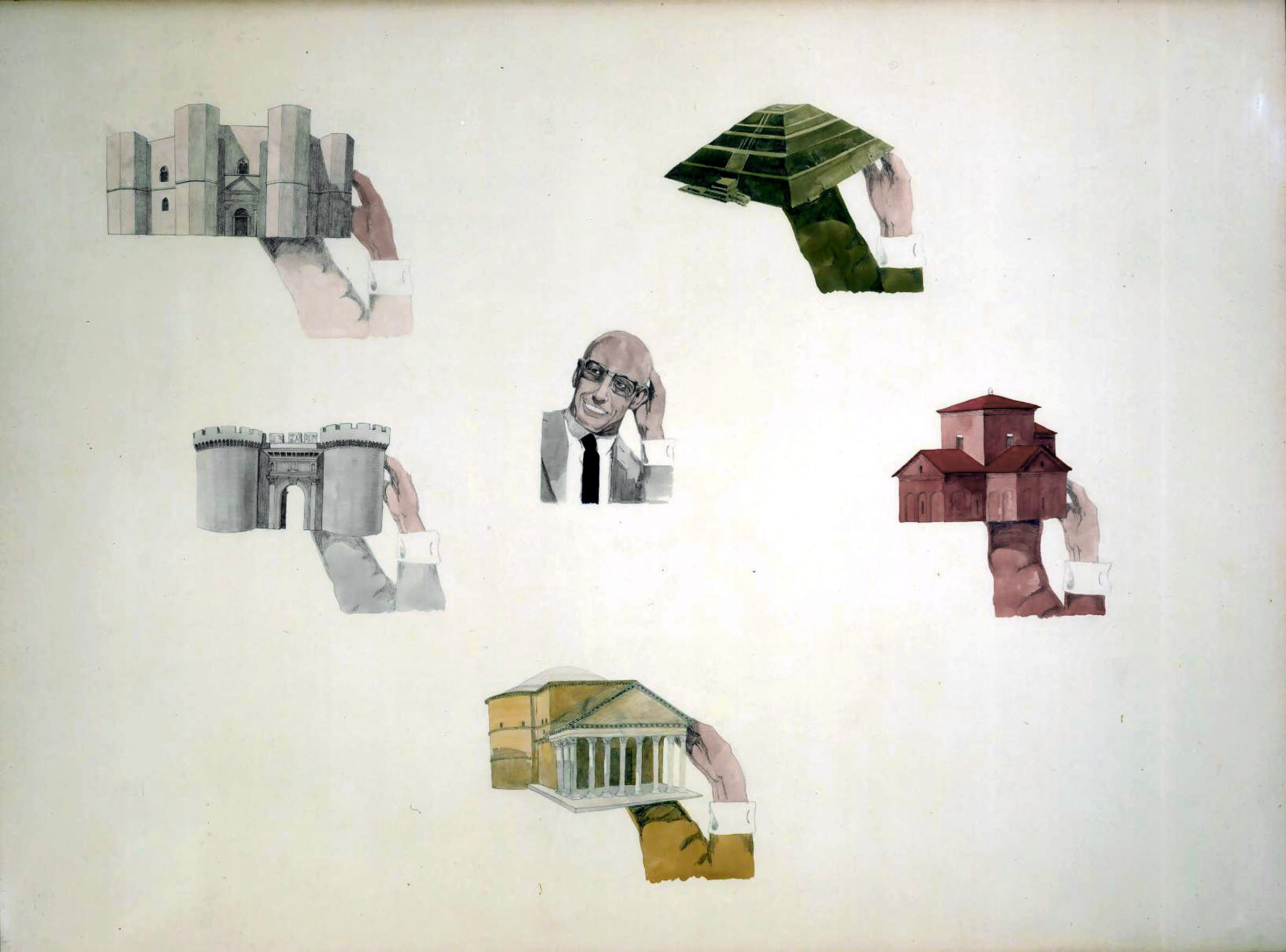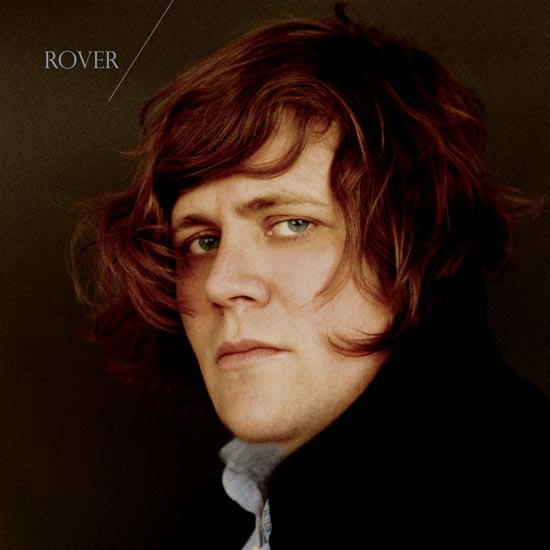Stati Uniti. Anni Sessanta. Piccola cittadina di provincia nel Maryland. Il romanzo comincia in prima persona sul tono del macabro e il finale rincara la dose con un mid-dark happy-ending da brivido.
Tutta la vicenda di La ragazza dei cocktail (Isbn Edizioni, 2013), di James M. Cain, ruota intorno alla signora Joan Medford – che nel corso del romanzo diverrà la ricca signora White – la quale registra un nastro di difesa a suo favore contro le accuse che le sono rivolte. Triplice omicidio e passioni compromettenti.
Dopo un matrimonio disastroso, a seguito dell’ennesima bevuta, il primo marito di Joan muore in un incidente d’auto. Il funerale dell’uomo le farà incontrare l’uomo del desiderio e della passione, Tom Barclay. Il sergente Young, ammaliato dalla sua bellezza e impietosito dalla sua condizione economica, le consiglia di lavorare come cameriera presso il Garden of Roses. Servirà invece alcolici al bar e si troverà di fronte all’occasione della sua vita: il vecchio e ricco Earl K. White Terzo, un amministratore d’impresa. Joan escogiterà le mosse giuste per adescarlo e sedurlo, tanto da riuscire a sposarlo dopo aver abbandonato il passionale Tom. Il piano però non va esattamente come premeditato. Il vecchio Earl desidera il fisico della protagonista sebbene soffra di angina pectoris. Joan però ne è disgustata, tanto da spingerlo tra le braccia di una prostituta. Ed è così che si giunge al secondo omicidio. White si concede fisicamente alla prostituta e ha un attacco fatale. Nel cadavere dell’uomo viene trovata una sostanza ben nota alla protagonista: talidomide.
Si svolge il funerale del secondo marito e Tom ritorna all’attacco. Joan ci ricasca: fuga amorosa, secondo incontro passionale, secondo abbandono. Il mattino seguente, colpo di scena: si assiste all’arresto definitivo della protagonista per la morte di Tom Barclay, trovato esanime in bagno con i polsi tagliati e una siringa impregnata di talidomide. Joan, alla fine, scampa la prigione per mancanza di prove. O meglio, per l’ottimo avvocato che riesce a permettersi grazie ai quattrini del defunto marito. Così Joan non solo si riprende il figlio Tad portatole via dalla sorella del primo marito, ma al terzo funerale scopre di essere incinta di Tom. Il romanzo si chiude sulla nascita prossima di questa bambina, e sulla chiusura del nastro che la scagionerà – almeno in parte – dalle accuse infamanti che i media rivolgono alla “ragazza dei cocktail”.
La ragazza dei cocktail è un noir al femminile dalle tinte fosche, un romanzo enigmatico e un ritratto fedele dell’America economica e sociale di quegli anni. James M. Cain crea un personaggio di difficile interpretazione, un vero “mostro femminile” della pianificazione sia psicologica che sociale.
La vera genialità del libro sta nell’enigma della protagonista, e non tanto in quello dei tre omicidi. Joan è una personalità superbamente modellata. È fredda ma passionale e irruente nei modi, cinica ma sensuale, tutte caratteristiche che la rendono la vera chiave di volta del romanzo.
Basterà leggere la storia parola per parola per arrivare a un’interpretazione degli omicidi? Sarà pronto il lettore a vestire i panni dell’investigatore? A lui l’ardua sentenza.
(James M. Cain, La ragazza dei cocktail, trad. di Marco Rossari, Isbn Edizioni, 2013, pp. 253, euro 19,90)