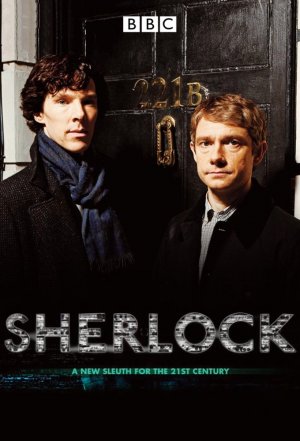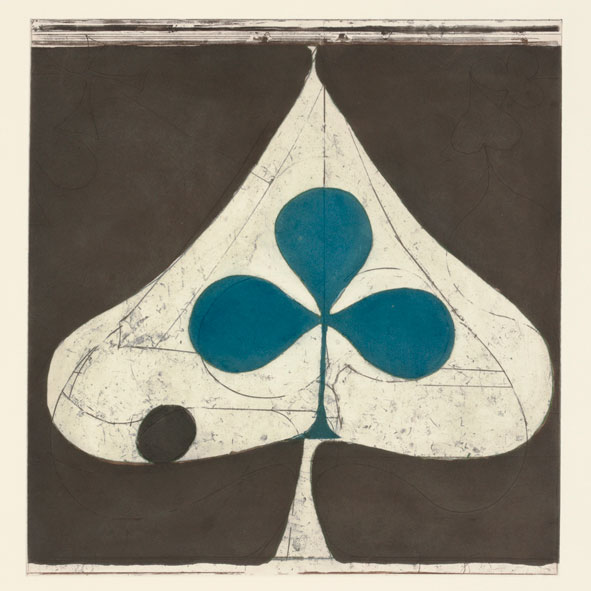La chiusura dei Murazzi sembra aver causato il sovraffollamento di qualunque locale variamente notturno di Torino, con la conclusione che quel minimo di rilassamento che si cercava in uscita dopo le visioni serali ha il solo risultato di alterare l’umore, logica conclusione di una giornata iniziata all’insegna del volume altissimo, abile a cacciare diverse persone dalla sala ma non il sottoscritto. Pazienza in vero ben riposta, sia per l’avvenuto abbassamento del volume di lì a poco sia per il mediometraggio inglese oggetto dell’assalto sonoro.
Film realizzato nell’ambito di un progetto di studio sugli anziani nelle comunità rurali inglesi, Rufus Thomas è la triste quanto poetica e delicata storia di omosessualità frustrata, derisa e scacciata nelle campagne inglesi degli anni ’50. Rufus e Flip non hanno nemmeno il tempo di comprendere ciò che sono e desiderano che subito il paese li mette alla berlina e Rufus, incapace di frenare il suo essere, parte per Londra verso un futuro di successi e realizzazione. Alla morte dei suoi genitori, cinquant’anni dopo, Rufus torna a casa e tutto riaffiora. L’opera è una efficace fusione di flashback e presente, con i ricordi che alimentano e si fondono con il vissuto odierno grazie a un digitale dai toni pastello e un gioco di rallentamenti, accelerazioni e contorni sfumati, capace di rendere il tutto fiabesco e surreale. Un gioiello che sperimenta visivamente trasformando la tecnica in delicato strumento al servizio della poesia.
Dimenticabile e a tratti sfiancante è invece il tedesco Silent Youth, tipico esempio di film da festival e per festival. Silenzi che vorrebbero dire ma non dicono, passeggiate interminabili e sguardi accennati che vorrebbero disvelare un’omosessualità latente. Il nulla offerto in camere fisse o che filmano le spalle e dettagli in slow motion. Le nuove leve del cinema d’autore europeo a uso e consumo di sale semivuote nei festival.
Di tutt’altro tono è l’esordio registico di Jules Mann-Stewart, madre di quella Kristen universalmente nota come Bella della saga di Twilight, che, dopo una trentennale carriera come script supervisor per cinema e tv, decide di passare dietro la macchina da presa. Lo fa con un progetto bislacco e decisamente sui generis. Il discografico Raymond Saxx, dopo una notte di bagordi tossici e alcolici, viene arrestato per l’omicidio di un musicista, suo assistito e amico. Il suo però non sarà un semplice destino da detenuto ma da detenuto tossicodipendente: Raymond viene infatti rinchiuso nel K-11, una sezione del carcere di Los Angeles dove carcerati con problemi di droga vivono ammassati l’uno sull’altro. Dramma dai toni bizzarri e surreali, in bilico tra ironia e violenza, K-11 appare quasi un prison-movie che fonde la seriosità di Oz e la follia da serie z di Bitch Slap. Personaggi macchiettistici come il transessuale ispanico Mousy, che governa e dirige con fare da regina l’intera sezione, il transgender Butterfly dalla mente contorta, in bilico tra angelo e diavolo, il pedofilo Detroit e il viscido poliziotto Johnson, vanno a formare un girone dantesco che, pur colpendo inizialmente, alla lunga sfianca a causa di una scrittura banale e priva di interesse, quasi che ciò che contasse fosse solo mettere in piazza le bestie del circo, senza poi curarsi dello spettacolo da offrire.
A inizio serata arriva quel che non ti aspetti. Entrare in sala senza sapere nulla di nulla di un film può alle volte riservare incredibili sorprese.
Vera rivelazione di questo primo weekend di festival è senz’altro Compliance di Craig Zobel, il classico regalo inatteso. Una scritta enorme a caratteri cubitali invade lo schermo: «Ispirato a fatti realmente accaduti». Una frase di importanza radicale, ben oltre l’immaginabile. Parte placido e didascalico, quasi si limitasse a raccontare un tranquillo e normale weekend lavorativo in un fast food di provincia. Piccole questioni organizzative e l’afflusso di clientela del venerdì come unici grandi problemi dell’esistenza. Qualcosa però accade e si materializza in una semplice e apparentemente innocua telefonata della polizia. Delirante e ai limiti della stupidità e follia umana è tutto ciò che accade dopo. Follia e stupidità che pur suscitando ilarità iniziale, ben presto la tramutano in sconcerto. Analisi spietata dei danni che può causare l’ignoranza e lucida finestra aperta su una società americana da raccapriccio, Compliance è film politico sotto neanche tanto mentite spoglie, capace di accumulare tensione e ansia e legare elementi chiave con stile e simbolismo. Magistrale una delle sequenze finali che indugia sul poliziotto e il suo viaggio in auto, apparente accademia registica in cui è in realtà dischiuso gran parte della ricchezza del film. Da guardare preferibilmente senza sapere nulla più di quanto descritto qui.
Come già detto all’inizio, il previsto rilassamento serale non ha luogo e, sociopatia a parte, si ritorna a casa carichi di speranze per il giorno successivo.
Speranze ben riposte e ottimamente ripagate dallo svedese Call Girl che conferma come lo sfruttamento e l’abuso del corpo femminile siano una costante di questi primi giorni di festival. Ambientato tra il finire degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, e in parte ispirato a fatti realmente accaduti, Call Girl segna l’esordio cinematografico di Mikael Marcimain, dapprima attivo solo in produzioni televisive di genere. La storia è un intreccio tra prostituzione d’alto bordo, sfruttamento di minorenni, politica e servizi segreti, con sullo sfondo la Svezia del progressismo sessuale, tra ipocrisie e scheletri nell’armadio. Opera rigorosa e al contempo personale, segue le orme del più classico thriller politico americano degli anni ’70 di autori come Pollack e Pakula, alternando con abilità le vicende intime e contorte di teenager allo sbando catapultati in mondi troppo più grandi di loro, all’interno del quadro globale di un paese in forte cambiamento economico e sociale. Più un thriller sociale che politico, infatti, e con lo spionaggio solo sullo sfondo, Call Girl richiama non di meno operazioni marcatamente retrò come Tinker, Tailor, Soldier, Spy – in Italia La talpa – del connazionale Alfreson. Simile è infatti la cura per la ricostruzione storica e la fascinazione vintage per un’estetica dominata da colori caldi, movimenti di macchina lenti e cambi di sequenza anticipati sempre un attimo prima dal cambio di tono musicale. Grande eleganza e cura formale restituiscono un film ottimamente girato e interpretato, dominato da personaggi ambigui ed equivoci, mai davvero buoni o cattivi. Ennesima conferma dello stato di grazia del cinema scandinavo contemporaneo.
Purtroppo il pomeriggio non prosegue sulla stessa linea e ci regala, se cosi si può dire, uno dei peggiori film visti fin ora.
V/H/S è un curioso esperimento di film horror a episodi, uniti dalla matrice comune del recupero di un’estetica e un carattere visivo da vecchia videocassetta anni ’80. Peccato che oltre alla curiosità iniziale vi sia il nulla più assoluto, senza contare come il recupero di una certa estetica sia spesso solo sulla carta, il tutto si risolve infatti, nella maggior parte degli episodi, in una sterile ripetizione dell’abusatissimo e sfiancante cliché dell’horror mockumentaristico che, con la scusa del girato amatoriale, offre la possibilità di gettar via ogni tecnica di ripresa. Totale mancanza di personalità e novità rendono l’operazione sfiancante e noiosa e offrono l’ennesimo spunto di riflessione su quanto, continuando su questa linea, abbia realmente senso di esistere un certo tipo di approccio al genere.
La situazione migliora solo parzialmente con il coreano Nameless Gangster, atipico gangster movie che narra le gesta di un malavitoso casuale, ex doganiere, divenuto faccendiere e poi catapultato più o meno consapevolmente nelle alte sfere del crimine coreano, con sullo sfondo la Corea del Sud di fine anni ’80, tra il boom economico e le possibilità offerte dalle Olimpiadi di Seul e un nascente intrallazzo con la politica. Curioso come non si esploda un solo colpo di arma da fuoco in tutto il film, ma oltre questo, e qualche battuta comica, il film non va, percorrendo strade senza infamia e senza lode per un minutaggio francamente eccessivo.
Conclusione di serata decisamente positiva invece grazie al franco-americano Maniac. Prodotto da Alexandre Aja e con, divisi tra montaggio, scrittura, fotografia e regia, alcuni dei suoi collaboratori più fidati, Maniac giunge qui a Torino accompagnato da squilli di tromba e commenti esaltati che sottolineano una certa diversità dallo stile classico della crew produttiva francese. Grande curiosità soprattutto per chi non ha mai particolarmente apprezzato un certo approccio eccessivamente ludico all’horror. Maniac altro non è che un remake, in vero assai personale, dell’omonimo cult anni ’80 di William Lustig che pone lo spettatore in primissima linea, narrando in soggettiva le gesta di uno psicotico serial killer restauratore di manichini dotato di una macabra e insana concezione del corpo umano. L’uso quasi totalizzante della soggettiva porta il regista a misurare con garbo i movimenti di macchina, permettendo di entrare sin da subito nella psicosi del personaggio, anche grazie a un’intelligente alterazione del parlato, quasi fosse sdoppiato come la personalità, e rimbombasse come una continua emicrania nella testa del protagonista e dello spettatore. Un montaggio accorto e situazioni splatter non banali intrattengono e divertono, cosi come interessante risulta il tentativo di innestare un abbozzo di storia d’amore, apparentemente capace di mitigare il delirio e la follia. Il film però è altrove, e sequenze meta-cinematografiche per una volta non gratuite, come quelle in cui il protagonista al cinema si rivede nei panni del Dr.Caligari, e il finale all’insegna di uno splatter simbolico e psicologico, confezionano un prodotto magari non esaltante ma di ottima fattura.
Si torna a casa con forti dubbi su quel che si vedrà il giorno dopo e una fastidiosa pioggerellina a sottolineare, forse, l‘arrivo definitivo dell’inverno, non ancora palesatosi in pompa magna qui a Torino.