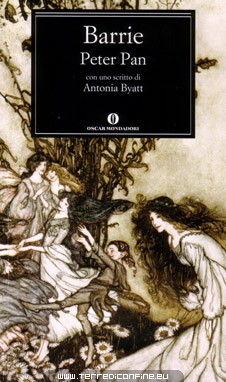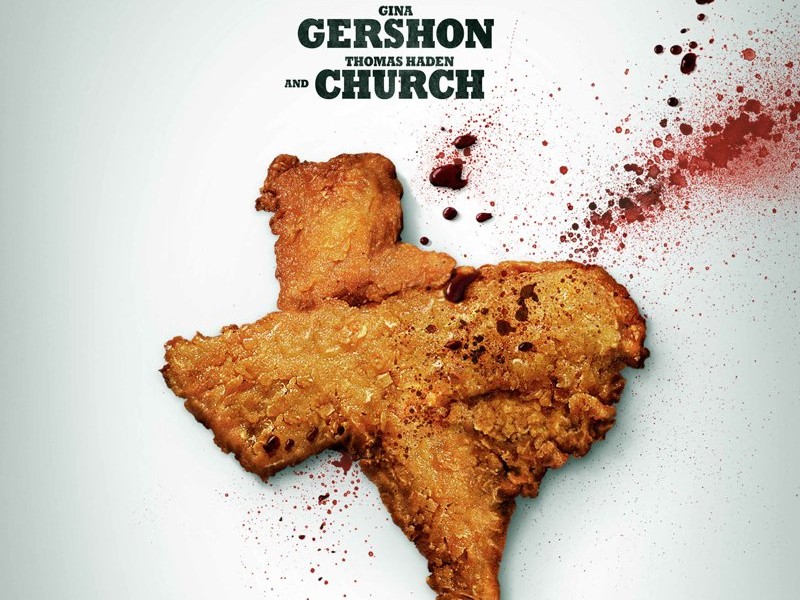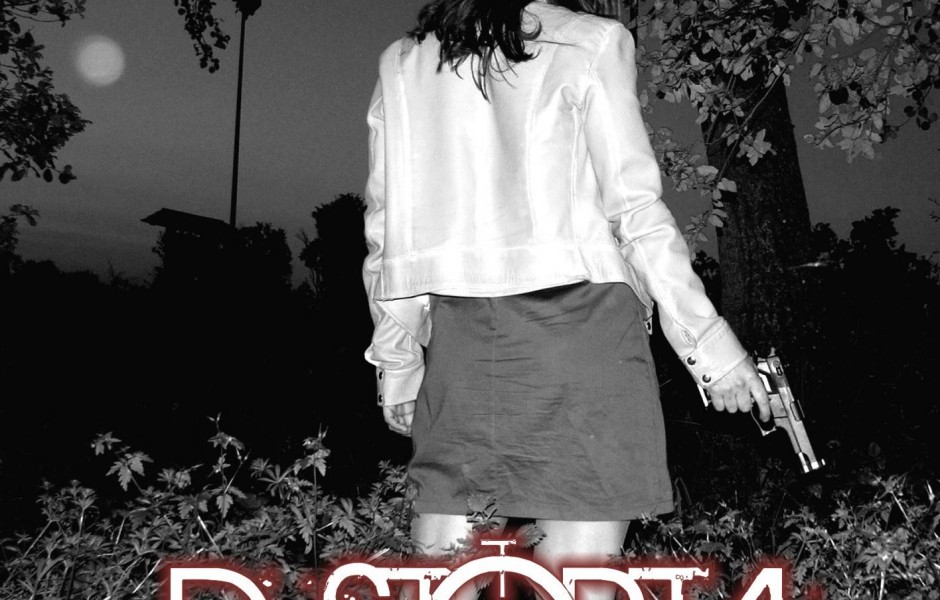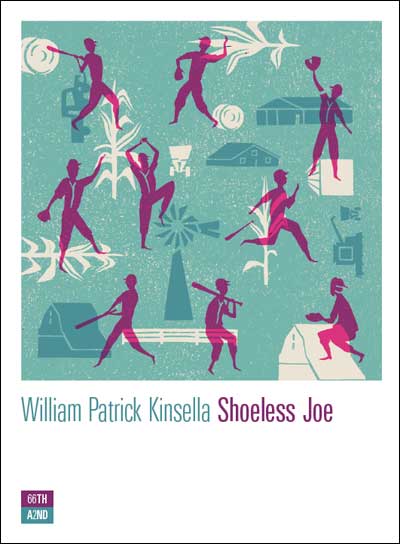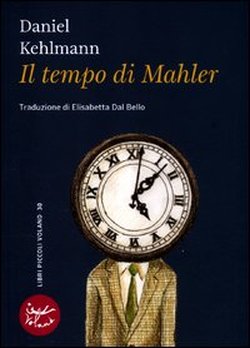Nella laicità il dolore non ha senso, è un’ingiustizia intollerabile.
La religiosità è contagiosa. Dove la religiosità è poca non c’è contagio. Anche la fede di quelli religiosi si stinge un po’, si ammanta di dubbi.
Le religioni sono nate per dare un senso al dolore.
D’altra parte qualcosa bisogna pur fare, intanto che impazzano cancro e la sclerosi laterale, nella fiduciosa attesa dell’età dell’oro, quando l’arte medica servirà solo per impiantare le branchie e le ali in previsione delle vacanze estive. Sempre che nel frattempo l’AIDS non ci stermini, l’inquinamento non ci soffochi, la spazzatura non ci sommerga, il medioevo postnucleare non ci inghiotta, il buco dell’ozono non ci mangi, le cavallette non ci annientino, le calotte polari restino dove sono, gli extraterrestri non arrivino e, nel caso, somiglino ai coniglietti della Walt Disney e soprattutto l’Islam si dimentichi di essere una religione fondata con l’unico e irrimandabile compito di asservire militarmente il mondo.
In un mondo laico, chi fermerà il dolore? Chi lo consolerà? Chi potrà dargli un senso?
Come è possibile senza religione affrontare la morte di un figlio bambino?
Nulla prepara alla morte di un figlio piccolo, ma in un mondo di credenti, diventa sopportabile. Persino la morte di un figlio bambino diventa sopportabile se devo comporre il corpo di mio figlio in una chiesa dove qualcuno mi leggerà la preghiera dei morti di S. Agostino:
Se mi ami non piangere!
Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo,
se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e sento
in questi orizzonti senza fine,
e in questa luce che tutto investe e penetra,
tu non piangeresti se mi ami.
Se non sono credente, la morte di mio figlio sarà intollerabile. Mio figlio sarà stato solo un ammasso casuale di atomi.
Il dolore della morte del figlio, Dio, la religiosità, essendo intollerabili finiscono nel luogo dove mettiamo le cose intollerabili: la narrativa fantastica.
Sono quattro le grandi storie che parlano della morte di un figlio bambino.
Pinocchio è figlio adottivo di un falegname che non è veramente suo padre (già sentita), finisce nel ventre di una balena (già sentita anche questa) viene condotto sulla via della perdizione da un tizio che si chiama Lucignolo (l’altro si chiamava Lucifero) e muore per poter risuscitare.
Alice cade in uno spaventoso mondo verticale e si perde. Cade nella tana del Bianconiglio, cade e cade e arriva dove arrivano i tunnel verticali: sottoterra. Le metafore di morte in Alice nel Paese delle meraviglie sono moltissime. Le regole del mondo dei vivi, la gravità e la stabilità delle dimensioni non valgono perché è un Ade pagano con tre mani di vernice sopra.
In Peter Pan le metafore sono ormai scoperte, sono scorticate: stiamo parlando della morte del bambino, della morte del bambino in ospedale.
Peter Pan è perso da una mamma distratta e diviene il bambino che non cresce. Tutti i bambini cresceranno, tranne uno, Peter.
There were odd stories about him;
As than children died
He went part of the way with them,
So that they should not be frightened.1
Peter Pan è l’angelo della morte. Lui e i bambini perduti sono morti. Sono morti in ospedale:
«Forse non avete mai visto la pianta della mente di un uomo. I medici talvolta disegnano piante di altre parti del corpo, anche del vostro, e la vostra pianta personale può risultare interessante, per voi. Provare a dire loro di tracciare la pianta della mente di un bambino, che, non solo, è confusa, ma è in, continuo movimento. Difficilmente ci riescono. Vi sono linee a zig-zag come quelle che segnano la vostra temperatura su una tabella clinica e con ogni verosimiglianza rappresentano le vie di un’isola. Infatti l’Isolachenoncè è, più o meno, un’isola con meravigliose macchie di colore, qua e là, e banche di corallo, e vascelli pirata al largo, e selvagge tane solitarie, e gnomi che per lo più esercitano il mestiere di sarto». (Peter Pan, Capitolo 1. Presentazione di Peter)
Ci sono nel libro frequenti allusioni a un mondo di malattia e ospedalizzazione. I tre bambini ospiti sono in pigiama o camicia da notte per tutta la narrazione: loro torneranno a casa. Peter e i bambini perduti no: loro in quelle corsie sono morti. Nel Medio Evo i bambini crepavano come mosche, ma a casa e in braccio a mamma.
Poi, con l’industrializzazione, i bambini hanno iniziato ad andare in ospedale. E non sempre tornavano. Non c’era il telefono. La mamma andava la domenica a trovare il suo bambino e le consegnavano le scarpine e il vestitino perché lui era morto il giovedì. Solo. Impotente e solo.
Peter ha sogni atroci, incubi sconvolgenti, da cui solo Wendy lo consola come consolano le madri: ninnandolo. Quando Peter non è presente tutto l’ingranaggio si ferma, anche indiani e pirati smettono di guerreggiare: l’Isolachenonc’è è il sogno di un bambino malato. Il romanzo gronda sangue. È un sogno, certo, un gioco, però è il sogno cruento di un bambino malato che sposta il sangue che imbratta le siringhe che usano per lui sulle spade dei Bimbi perduti. Quando i pirati aggrediscono gli indiani è una carneficina. Un gioco, certo, ma le parole sangue e morte vengono ripetute ossessivamente. Peter è un bimbo piccolo. Non ha ancora cominciato a perdere i denti. Ha i denti da latte e li ha tutti. Una fila di perle. Più di una volta questa fila di perle viene nominata e l’idea di questi denti caduchi che non cadranno mai accentua l’impressione di qualcosa di profondamente tragico.
Il mondo di Alice, come l’Isolachenonc’è, è un condensato di sogni, giochi e fantasticherie infantili, quello di Peter più strutturato e logico, quello di Alice più ermetico e onirico. Sotto un’allegria di facciata celano l’orrore dei regni dei morti di epoca precristiana. Sono rappresentazioni multicolori dell’Ade. In realtà la tragedia di fondo di questi mondi senza futuro è che, in cambio di una manciata di giocattoli, di indiani amichevoli e pirati pasticcioni destinati alla sconfitta permanente, è stato tolto il crescere. I bimbi perduti raccolti da Peter Pan nell’Isolachenonc’è si riuniscono attorno a Wendi perché racconti una storia, in uno slancio di nostalgia atroce per la madre che «li ha persi».
Ho perso mio figlio: il mio bambino è morto. Tutti i bambini crescono, ma non il mio. Come Peter Pan, il mio bambino è confinato in un limbo che somiglia a un ciclopico parco giochi, altrettanto insulso e triste.
Ossessivo, nelle due narrazioni, è il tempo. Il cipollone del Bianconiglio, sempre in ritardo e la sveglia nello stomaco del coccodrillo scandiscono un tempo senza futuro.
Il ticchettio dell’orologio è una della grandi scoperte dell’umanità. Non è solo lo strumento indispensabile alla totalità della tecnologia recente, ma è stato lo strumento necessario per misurare e pagare il tempo del lavoratore. In luoghi non abituati all’orologio, come le vecchie comunità agricole il tempo del lavoro non viene calcolato come valore.
Il ticchettio dell’orologio è quello che ci permette di prendere il treno. È quello che permette l’esistenza del treno.
Se però il tempo di mio figlio è contato, se questo tempo non è destinato ad avere un domani, se qualcuno mi ha detto: ancora un mese, signora, forse tre, allora il ticchettio dell’orologio diventa altro.
Dipende da quanto risponde alla digitale.
Dipende da quanto gli farà bene il sanatorio.
Ancora un mese, forse due, forse cinque, dipende da quanto risponderà alla chemioterapia.
Allora il ticchettio dell’orologio diventa un’ossessione. Un incubo.
Ne Il Piccolo Principe ci perdiamo anche le metafore. Il Piccolo Principe non cade nella tana del Bianconiglio, non parte per l’Isolachenonc’è.
Il Piccolo Principe, semplicemente, muore.
Il Piccolo principe muore perché non sopportiamo la morte del figlio e da qualche parte dovevamo metterla. Quindi l’abbiamo messa nella narrativa fantastica, luogo dove, ricordiamo Kafka, da sempre mettiamo i mostri.
In Peter Pan c’è anche l’ anticipazione delle distopie attuali.
La morte del figlio perché mamma lo ha perso, lo ha abortito.
Mamma lo ha perso perché papà non lo vuole.
Un nuovo genere, o forse sarebbe più corretto dire una nuova sfumatura, per un genere da sempre esistito. Sto parlando della distopia, dell’antiutopia, della fantapolitica sociale, i figli e nipoti di 1984, sempre più presente nella cosiddetta letteratura per ragazzi, che in realtà, non sarà mai ripetuto abbastanza, è una letteratura anche per ragazzi, perché qualcosa che è buono per un dodicenne lo è anche per un sessantenne, mentre non è valido il contrario. Possiamo assurgere come esempi: Bambini nel bosco di Beatrice Masini (Fanucci Editore), e La dichiarazione (Salani Editore). Sono tutte narrazioni che sottolineano il rischio delle nuove generazioni di ragazzi, di essere sterminati, dagli anziani. C’è una strana forma di mancanza d’amore, nell’impedire la nascita. Una straordinaria forma di aridità. È già descritta in Peter Pan.
Prima dell’epoca contemporanea i bambini erano una ricchezza. Potevano essere mangiati, nelle tribù primitive per non morire tutti di fame nei periodi di carestia si sacrificava il bambino più piccolo. Poteva essere venduto: fino al secolo scorso, sino al secondo dopoguerra i bambini erano “affittati” nelle fattorie dove facevano i servi e dormivano nelle stalle mangiando avanzi. Il bambino lavorava e, in età adulta, avrebbe mantenuto i genitori. Molti genitori erano genitori orribili, ma mettevano al mondo i figli perché non c’era altra scelta, visto che madre natura ha messo sessualità e riproduzione attaccate l’una all’altra. Con il divieto allo sfruttamento del bambino e con le assicurazioni sociali che garantiscono la pensione mettere al mondo un figlio è un peso. L’uomo moderno non sempre ha voglia di accollarselo. Da quando con gli anticoncezionali sessualità e riproduzione sono state separate, la paternità si è dispersa in una marea di dubbi.
Il padre di Wendi, per ogni bambino spiega alla moglie, facendo tutti calcoli, come quel bambino non se lo possano permettere, come sarebbe meglio non averlo.
Il dialogo ha un effetto comico, questa almeno era l’intenzione dell’epoca, ma rileggiamolo adesso, che l’aborto è permesso e normale, la contraccezione obbligatoria e ci stiamo estinguendo per mancanza di bambini. Vengono i brividi lungo la schiena. Ho ascoltato nella mia vita il pianto di donne che avevano “liberamente” scelto l’aborto perché il marito e il compagno avevano spiegato che no, vedi, non ce lo possiamo permettere, mi sembrava di rileggere Peter Pan. E lei si lascia convincere, certo e poi resta lì, dopo anni è ancora lì che dice «Oggi avrebbe 6 anni, andrebbe a scuola».
Di Peter Pan è straordinario il colore, la leggerezza del volo. L’ultimo grande significato del libro è la capacità della nostra mente di creare una realtà e viverci.
All’interno della nostra testa c’è solo il nostro pensiero. La mente umana può volare, anche dal fondo delle prigioni o dei lazzaretti. È il messaggio che ci ha dato dal campo di concentramento Victor Frankl, quello che ci ha dato Erikson dalla sedia a rotelle. Noi siamo gli unici padroni del nostro pensiero e quindi della nostra gioia. La capacità di portare la mente in luoghi incantati è l’estrema libertà, quella inviolabile.
Silvana De Mari è nata nel 1953 in provincia di Caserta e vive a Torino. Laureata in medicina, ha esercitato come chirurgo in Italia e in Etiopia come volontaria e oggi si occupa di psicoterapia. Ha ricevuto svariati premi per i romanzi L’ultimo Elfo e L’ultimo Orco. L’ultima profezia del mondo degli Uomini chiude la saga già avviata dall’editore Salani. Con Fanucci Editore ha pubblicato, nel 2009, Il Gatto dagli occhi d’oro e, nel 2011, Io mi chiamo Yorsh.
1«Si raccontavano di lui molte strane storie, si diceva che quando bimbi morivano, lui li accompagnava nel primo tratto di strada, perché non avessero paura». James Matthew Barrie, Peter Pan, Capitolo 1. Presentazione di Peter.
![]() Acquista “Peter Pan” su Amazon.it
Acquista “Peter Pan” su Amazon.it