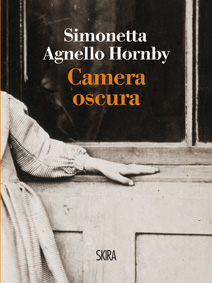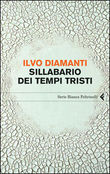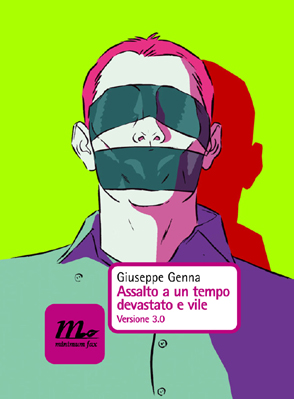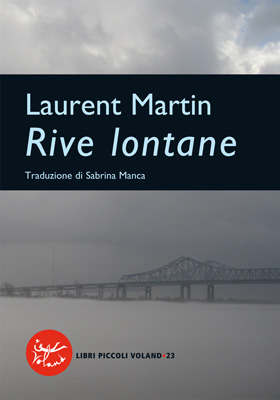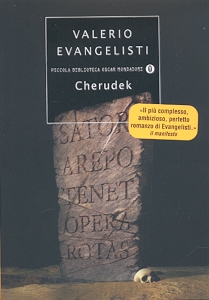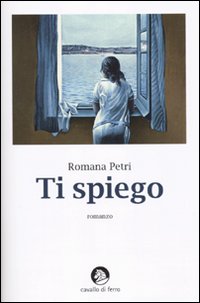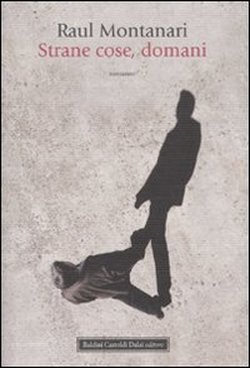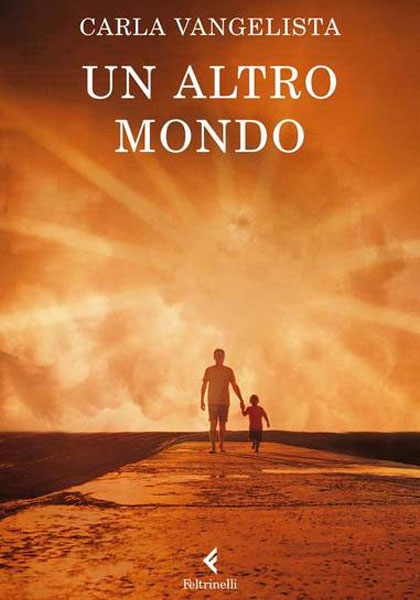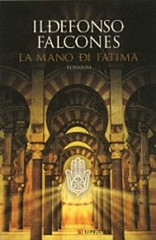Abbiamo intervistato Simonetta Agnello Hornby che, dall’Inghilterra, ci ha parlato del suo ultimo libro Camera oscura (Skira, 2010), un volume che racconta “l’altra faccia” di Lewis Carroll, l’enigmatico autore di Alice nel paese delle meraviglie.
Buongiorno Simonetta, innanzitutto grazie per l’intervista. Ho finito di leggere da poco Camera Oscura (Skira, 2010), un libro che mi ha “aperto un mondo” su aspetti della vita di Lewis Carroll che, sono sincero, non sapevo affatto. Per me Carroll era soltanto il visionario autore di “Alice nel paese delle meraviglie”. Nient’altro. Puoi spiegare ai nostri lettori su quale aspetto della personalità dello scrittore si inserisce il tuo volume?
Sulla sua malattia. Molti autori di opere grandiose, così come uomini di stato o altre persone, commettono o hanno commesso reati, persino omicidi. Sapere che l’autore è una brutta persona non può sorprendere, soprattutto se si parla di Carroll. Carroll ha provato a costruirsi un’immagine, ha bruciato i suoi diari, c’era in lui l’idea di un’opera di funzione. Conosceva la sua malattia e ha continuato a fare quello che voleva, con il consenso tra l’altro delle famiglie. Il problema è che si è inventato una figura “santa”, quella di un uomo che amava i bambini. Le amava guardare, toccare e fotografare. Basta vedere anche solo quattro foto, quelle del libro, per capire che in lui non c’era niente di puro
Altro aspetto che non conoscevo è quello legato alla professione, quella di avvocato in difesa dei diritti dei minori. Per me eri soltanto la bravissima autrice de La zia marchesa, La mennulara, Boccamurata. Immagino che l’ambito di cui ti occupi regolarmente abbia influito nella stesura di Camera oscura. Mi sbaglio? Da dove è venuta l’idea del libro? Che ne pensi di Alice nel paese delle meraviglie?
Ha influito eccome. Il libro mi è stato proposto dalla casa editrice. Mi è sto proposto in quanto scrittrice e in quanto avvocato dei minori, su consiglio di Camilleri. All’inizio avevo rifiutato, anche io non sapevo nulla di Carroll, poi mi hanno convinta. Alice nel paese delle meraviglie non è un però libro per bambini, è una macchina pubblicitaria che continua ancora oggi a funzionare. Abbiamo tutti negli occhi il film della Disney. Ci sono molti libri migliori di questo da far leggere ai bambini. Penso a Pinocchio, ma ce ne sono molti altri. Di Alice nel paese delle meraviglie mi piace l’assenza di morale. Sì, l’assenza di morale è l’aspetto migliore del libro.
Certo è incredibile pensare a Carroll come di un uomo incapace a resistere a tali pulsioni. Chi era questo scrittore oltre ad essere uno dei nomi fondamentali della letteratura anglosassone? Un esteta? Un malato? Un uomo dal doppio volto?
Era un pedofilo, inutile girarci intorno. Pensate che in Inghilterra è considerato uno dei massimi scrittori di sempre. Come Milton, per intenderci. Sicuramente po era una persona intelligente. Attirava i bambini cercando di dare loro fiducia. Il pedofilo deve avere dai bambini la fiducia e l’omertà. Per fare questo li deve conoscere.
Ed è per questo che la giovane protagonista, una quattordicenne che, diventata una delle "amiche" dell'illustre e originale scrittore-fotografo, subisce tutta l'opera di seduzione di Charles Lutwidge Dodgson (vero nome di Lewis Carroll), con il pieno consenso della famiglia, finisce per innamorarsi e soffrire terribilmente per il brusco troncarsi degli incontri (voluto dalla madre)?
Sì, in un certo senso sì. Qualche complimento, qualche parola dolce, qualcosa per farle sentire importanti. Lui ci sa fare, le bambine si innamorano di lui. Anche la protagonista. Un’opera di seduzione vera e propria. A quell’età è facile cascarci. Giocare con il loro aspetto e con il linguaggio, basta poco. A mio avviso però Carroll non “consuma” sempre il suo amore, probabilmente con le ragazze di buona famiglia “gioca” soltanto. Con le ragazzine del popolo dà il peggio di sé. Il consenso delle famiglie arriva anche per questo motivo. E poi Carroll è un “sant’uomo”.
Mi viene in mente il caso di Roman Polanski. Il regista fa venire a casa una bambina di tredici anni, Samantha Geiger, per un servizio fotografico. Era il 1977. La madre probabilmente aveva acconsentito. Denunciato, scappò dall’America per poi essere fermato giusto lo scorso anno. Trenta anni dopo e dopo molti riconoscimenti internazionali, oscar compreso. Che ne pensi di questa storia? Te lo chiedo sia come donna sia come scrittrice, e quindi artista, sia come avvocato.
Un reato è un reato, non c’è prescrizione. Polanski deve pagare la sua pena. La madre della ragazza? Il “consenso” arriva molto spesso. Oggi avviene con le veline, le attrici o pseudo-tali. Le famiglie mandano le figlie in pasto ai produttori. Abbiamo perso l’idea che i bambini non devono lavorare. Ci scandalizziamo per il lavoro minorile ma questo cos’è? Accettiamo la corruzione dei minori, in questo modo si corrompe l’infanzia. Anticipiamo la vita d’adulti per poi avere momenti lunghissimi di gioventù. Viviamo in un paradosso. In Inghilterra c’è forse una maggiore maturità nei ragazzi ma in fondo, almeno in occidente, è dappertutto uguale. C’è scompenso tra il fisico e l’intelletto, si matura prima fisicamente ma psicologicamente si è più indietro. Faccio un esempio, sia i bambini inglesi sia italiani non hanno “lavori”, compiti a casa, compiti che però sono lavori perché i compiti sono quelli che si fanno a scuola. I miei figli li avevano, noi li avevamo. Oggi si dice “aiuta la mamma”, un aiuto presuppone che ti devo dire “grazie” e quindi è facoltativo. Un lavoro non è facoltativo. Un bambino a tre anni sa che il suo lavoro è andare per esempio a prendere il latte alla porta, a cinque è quello di sparecchiare e così via. Oggi non è così. Non riesco a capire quando è stato il tempo in cui è scattato questo qualcosa che ha ribaltato tutto. Oggi siamo noi a dover fare cose per i figli, non viceversa. Forse con la liberalizzazione del ’68, non so.
Ci vuoi dire qualcos’altro sul libro? E su di te? Ci sono “lavori in corso”?
Nel libro sono stata attenta a non dare un giudizio, a lasciare al lettore il compito di farlo. Oggi i giudizi sono difficili da dare, bisogna osservare, osservare bene, trarre le conclusioni e non aver paura. Non lo dico ma lo faccio capire. Che posso dire? Sicuramente a Carroll non gli darei mio nipote…
Lavori in corso? Il 29 uscirà La monaca, con Feltrinelli, la storia di una monaca del 1840 che non voleva prendere i voti. Non vuole farsi monaca ma non perde la fede, invoca Dio per un destino migliore. Poi una storia d’amore dal sapore siciliano-napoletano con nello sfondo i moti del ’48 e primi richiami all’Italia che sarà.
Permettimi di fare i complimenti alla casa editrice Skira che, ancora una volta, ci ha regalato un volume preziosissimo, in tutti i sensi, anche per il formato e per la qualità tipografica. Grazie mille a e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a te, spero che verrai alla presentazione del nuovo libro.
A Roma, sicuramente. Dove sarà?
A Feltrinelli, come sempre. Galleria Colonna.
Ci sarò. A presto e grazie ancora.
Grazie a te.