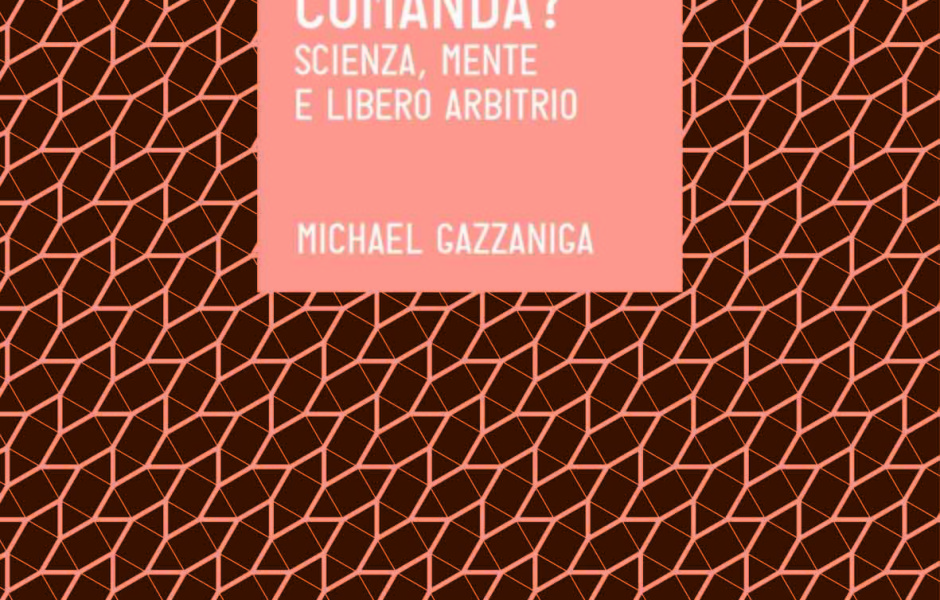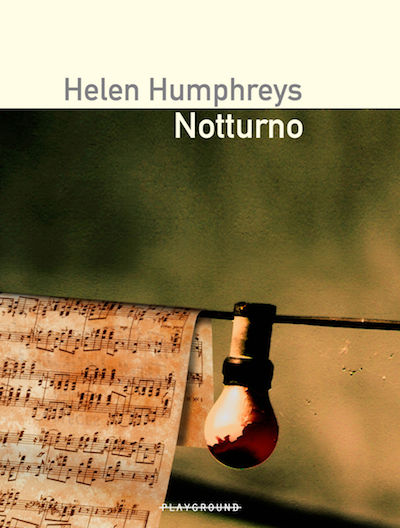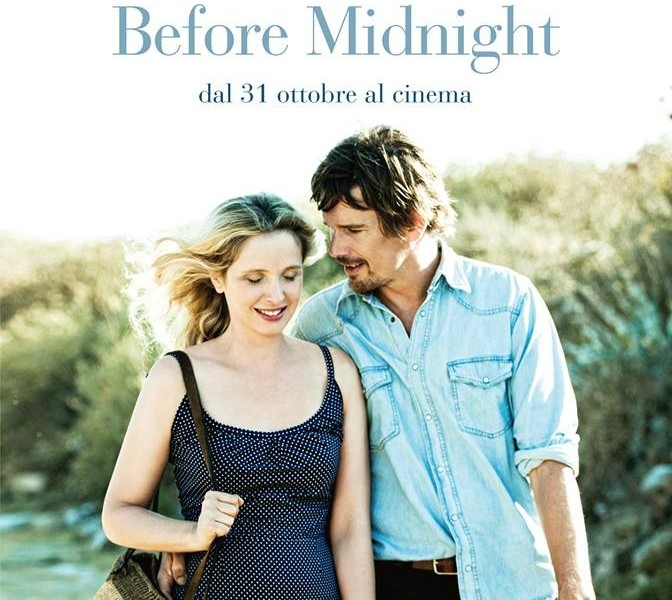Per alcune correnti scientifiche e del pensiero filosofico la nostra esistenza assume il significato che noi stessi le attribuiamo. Nell’ottica di una visione deterministica, invece, il cervello umano segue le leggi del mondo fisico in maniera passiva, senza alcuna volontà.
Michael Gazzaniga, neuroscienziato statunitense, direttore del nuovo centro studi per la mente in California, in Chi comanda? Scienza, mente e libero arbitrio (Codice, 2013) auspica di dimostrare come dicotomie semplicistiche come determinismo/casualità, natura/cultura, non possono più essere accettate dalle neuroscienze moderne che devono abbandonare questa visione parziale in favore di un approccio che riconosca il funzionamento cerebrale come un sistema complesso, soprattutto poiché: «Le implicazioni dell’idea che il cervello umano sia un sistema complesso si ripercuotono sulle discussioni sul libero arbitrio, le neuroscienze e il diritto, ma anche sul determinismo».
Gazzaniga afferma che «non c’è una ragione scientifica per non essere considerati individui responsabili». Il senso di responsabilità modifica il comportamento. Esperimenti hanno dimostrato che «le persone sono più efficienti quando pensano di possedere libero arbitrio».
Ma cosa accade quando attraverso metodi sperimentali è possibile dimostrare che le azioni vengono svolte e portate a termine prima che il cervello ne prenda consapevolezza? «Pensate a quando col martello vi schiacciate un dito e lo ritraete di colpo. La vostra spiegazione sarà che vi siete colpiti il dito, avete sentito male e l’avete tirato via. Ciò che accade però è che voi lo tirate via prima di sentire il dolore. Ci vogliono alcuni secondi per percepire il dolore, o per essere coscienti, e il vostro dito si è già sottratto al pericolo da tempo».
Questo è l’esempio di un’azione riflessa in cui il movimento avviene prima che la persona ne abbia coscienza. Ciò sembrerebbe far pendere sempre più l’ago della bilancia verso un’ottica determinista, ma la complessità risponde a un insieme di leggi differenti: «I cervelli sono macchine automatiche che seguono percorsi decisionali, ma analizzando i singoli cervelli in isolamento non si riesce a mettere a fuoco la capacità di essere responsabili: la responsabilità è una dimensione di vita che deriva da uno scambio sociale, e lo scambio sociale richiede più di un cervello. Quando più cervelli interagiscono, cominciano a emergere elementi nuovi altrimenti imprevedibili, stabilendo un nuovo insieme di regole. Due delle proprietà che vengono acquisite in questo nuovo insieme di regole, e che non erano presenti in precedenza, sono la responsabilità e a libertà».
È chiaro dunque che responsabilità e libertà sono il frutto di un’interazione sociale, che va molto al di là del determinismo individuale. Dare un senso a ciò che siamo, questo è il viaggio tentato da Gazzanica attraverso la narrazione delle rivoluzioni che hanno scosso le neuroscienze per arrivare a un approccio capace di tener conto della complessità del funzionamento cerebrale, al punto da parlare di “cervello sociale”.
Cervello e mente non sono sinonimi. La mente ha il potere di limitare il cervello, così come i processi sociali hanno la capacità di limitare la mente individuale: «La cultura a cui apparteniamo ha davvero un ruolo importante nel dare forma ad alcuni dei nostri processi cognitivi».
Proprio in virtù di ciò Gazzaniga sottolinea l’importanza del riconoscimento della responsabilità personale nelle scelte, soprattutto in ambito giudiziario dove, ancora troppo spesso, si fa riferimento a una visione determinista in cui viene negata la colpa, con conseguente mancanza della pena.
Chi comanda? Scienza, mente e libero arbitrio è un libro di impronta scientifico-filosofica scritto in modo accessibile a un ampio pubblico di lettori curiosi di affacciarsi sull’eterno dibattito del libero arbitrio: in un momento in cui lo sviluppo neuroscientifico ci vuole “macchine biologiche”, sistemi deterministici, Michael Gazzaniga propone una teoria opposta, che situa la nostra coscienza al di là dell’individuo, in una «comunità delle menti» che aprendoci alla dimensione sociale svela una maggiore complessità.
(Michael Gazzaniga, Chi comanda? Scienza, mente e libero arbitrio, trad. di Silvia Inglese, Codice Edizioni, 2013, pp. 288, euro 15,90)