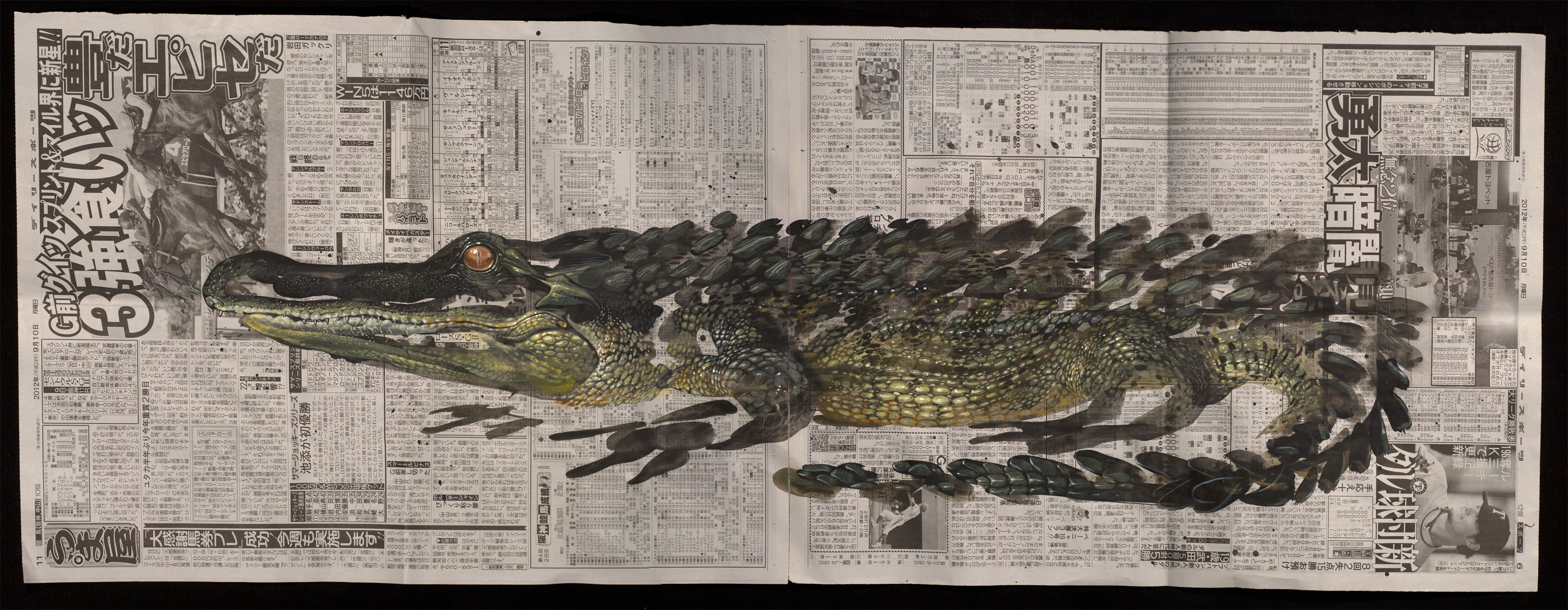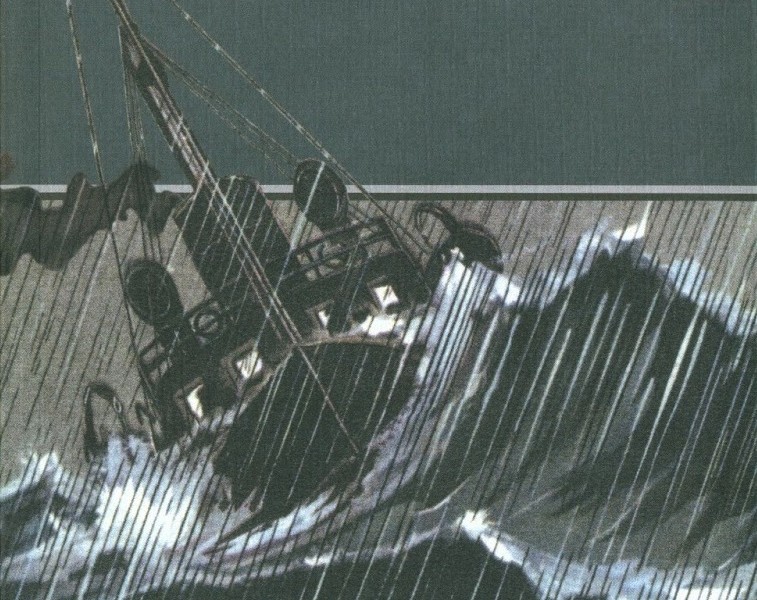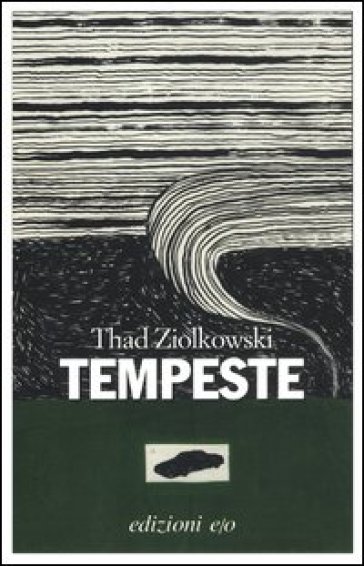Si è conclusa l’11 aprile la XII edizione del RIFF, il Rome Independent Film Festival, rassegna cinematografica che si svolge ormai da diversi anni presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma. Punto di riferimento delle produzioni non legate alle grandi major, l’evento ha visto come in concorso più di 120 opere tra lungometraggi, corti e documentari, provenienti da circa 40 paesi diversi, in anteprima italiana. Il RIFF, così come altre kermesse molto più note e modaiole, svolge un importante e fondamentale ruolo di promozione per un cinema dinamico e fresco che, nonostante una disponibilità di budget limitata e talvolta quasi inesistente, riesce a trovare un piccolo spazio nella grande distribuzione internazionale. Tutto ciò avviene mantenendo standard qualitativi molto alti e dal contenuto significativo, testimoniati anche dal record di incassi e partecipazioni che registra ogni anno questa manifestazione romana.
Il Direttore Artistico, Fabrizio Ferrari, descrive l’evento proprio in questi termini: «Il RIFF è una manifestazione che nasce dall’amore per il cinema e che dunque aspira a valorizzarlo in tutte le sue forme. Il principale obiettivo che perseguiamo è infatti quello di promuovere quel segmento della cinematografia che troppo spesso non riesce a ottenere la meritata visibilità attraverso i canali tradizionali, ovvero quello indipendente. É un tipo di cinema slegato dai vincoli dalle major e dunque libero: libero di sperimentare, di raccontare, di osare, libero di esprimere idee e di inventare scenari, e libero di non tacere. É spesso un cinema giovane, timido o arrogante, brillante e comunicativo, che cerca la sua strada per poter esprimere la creatività e il talento dei suoi artefici».
L’edizione 2013 è stata aperta da Il Futuro (2013), della regista cilena Alicia Scherson. Già presentato con successo al Sundance Film Festival, il film è frutto di una coproduzione tra Italia, Cile, Spagna e Germania ed è tratto da Un romanzetto canaglia di Roberto Bolaño. La storia è molto semplice: Bianca e il fratello Tomas perdono i genitori in un incidente stradale e si ritrovano soli a Roma, nell’appartamento della famiglia. La svolta avviene quando Tomas trova lavoro in una palestra e diventa amico di due ragazzi più grandi che poco dopo si stabiliscono a casa loro. I due, dediti alla delinquenza, convinceranno Bianca a introdursi nella villa di un ex attore per sedurlo e, successivamente, provare a ricattarlo. Del film colpiscono la fotografia e le interpretazioni di Rutger Hauer e Nicolas Vaporidis, un po’ meno lo sviluppo di una storia dal grande potenziale forse non sfruttato a pieno.

Continuiamo parlando di un corto fuori concorso e di un film made in USA. Il primo è Zinì e Amì (2012) storia d’amore tecnologica e leggera che strappa molti sorrisi in sala. Zinì, interpretato da Alessandro Tiberi (noto al grande pubblico per Generazione 1000 euro e Immaturi, oltre che per la serie tv Boris), decide di acquistare Amì (Sasha Zacharias), donna-androide perfetta programmata per innamorarsi di lui. Ma qualcosa non va e la sua perfezione mancata diventa l’ossessione del giovane che prova a farla riparare. Da citare anche la partecipazione sempre apprezzabile di Silvio Orlando e le diverse chiavi di lettura donate allo spettatore in soli cinque minuti.
Two Hundred Thousand Dirty (2012) narra invece, in maniera comica, le vicende di uno squallido negozio di materassi della provincia americana, nel quale lavorano lo scorbutico Rob, lo sboccato Manny (il rapper Coolio) e Martin, uno squilibrato. Le loro vite sembrano cambiare quando la deliziosa Isabelle viene assunta e li convince a uccidere, con la promessa di 200.000 dollari, l’ex marito.
Il lungometraggio, tra quelli che abbiamo visto, che ci è piaciuto di più è I’m Nasrine (2012) della regista Tina Gharavi. Nato da una coproduzione tra Inghilterra e Iran, proprio in Iran inizia la vicenda: Nasrine viene arrestata ingiustamente e durante l’interrogatorio subisce violenza. Il padre, a quel punto, decide che per lei e il fratello Alì la soluzione migliore è andare a vivere lontano, nel nord dell’Inghilterra. Poco dopo il loro arrivo, Nasrine inizia l’università e stringe amicizia con una comunità gitana inglese, mentre Alì inizia a lavorare e tutto sembra andare per il verso giusto in questa nuova vita da occidentali. Tutto si complicherà con gli eventi dell’11 Settembre e altre spiacevoli sorprese. Il film appare completo, una storia semplice che non sfiora mai la banalità e porta a riflessioni e spunti interessanti.
Altri lavori che meritano una citazione sono i due corti tedeschi Waldesruh (2012) di Marc A. Misman e The last border (2012) di D. Butterworth. Nel primo, due uomini devono liberarsi di un cadavere seppellendolo in una foresta ma una serie di eventi tragicomici cambieranno i loro programmi. Il secondo, invece, è la storia di Alfred guardia di frontiera che lavora alla frontiera tra Germania e Repubblica Ceca. Ogni giorno, Suzanne arriva su una bicicletta e oltrepassa il confine con un sacco di riso, fino a quando i nuovi trattati dell’Unione Europea decideranno l’apertura delle frontiere. La decisione sconvolgerà la vita di Alfred che sfogherà il suo rancore e diventerà cinico e spietato nel controllare la giovane, dimenticando un piccolo ma decisivo particolare.
Infine, molto interessante il documentario del regista Pawel Pstragowski, Buffer Zone (2012). Tra il 2011 e il 2012 un gruppo di attivisti decide di occupare Ledra Street, a Nicosia, per protestare contro il mancato accordo che doveva risolvere l’annosa questione della frattura cipriota. In questa striscia di confine (più mentale che fisica), ragazzi turco-ciprioti, greco-ciprioti, spagnoli, francesi, polacchi e di altri paesi si accampano per una settimana, poi un mese, poi cinque mesi e così via. Inizia così la storia (vera) di decine di giovani che provano a combattere quotidianamente il capitalismo, le divisioni dell’isola e l’odio ideologico. Una bella favola moderna che è diventata realtà.

Il Festival si è concluso con i RIFF Awards e con la consapevolezza che la rassegna è stata, come ogni anno, qualcosa di unico e essenziale per il cinema, una boccata d’ossigeno importante. Questi sono i premi assegnati dalla giuria:
Miglior Lungometraggio Internazionale
Ombline di Stéphane Cazes, Francia 2012
Miglior attore/attrice sezione lungometraggi internazionali
Melanie Thierry per Ombline
Miglior Lungometraggio Italiano
Ex-aequo: Transeuropae Hotel di Luigi Cinque
Aquadro di Stefano Lodovichi
Miglior attore/attrice sezione lungometraggi italiani
Giorgia Cardaci per L’ultima Foglia di Leonardo Frosina
Miglior Film Documentario internazionale
Mapa di León Siminiani, Spagna 2012
Menzione Speciale
The Suffering Grasses di Iara Lee, Usa 2012
Miglior Film Documentario Italiano
La valle dello Jato di Caterina Monzani & Sergio Vega Borrego
Menzione speciale
Con quella faccia da straniera – Il Viaggio di Maria Occhipinti di Luca Scivoletto
Miglior Cortometraggio Internazionale
Column di Ujkan Hysaj, Repubblica del Kosovo 2012
Miglior Cortometraggio Italiano
Matilde di Vito Palmieri
Miglior Cortometraggio Studenti
Momo di Teodor Kuhn, Slovacchia, 2012
Menzione
Nicoleta di Sonia Liza Kenterman, Grecia/UK 2012
Miglior Cortometraggio d’Animazione
Animalario di Sergio Mejía Forero, Colombia, 2012, 3D Animation
Miglior Soggetto per Sceneggiature di Lungometraggio – Premio Fabrique du Cinema
L’invito di Massimo De Angelis.
Miglior Sceneggiatura per Cortometraggio – Premio Factotum Art
Primo di Marco Tosti