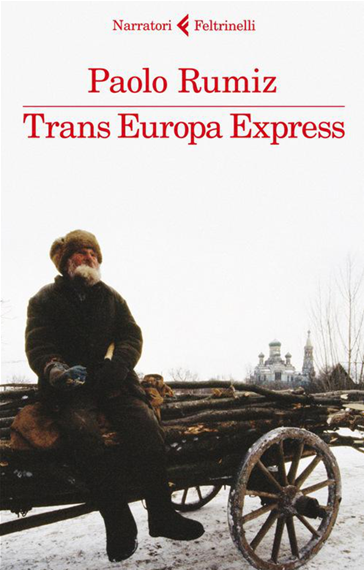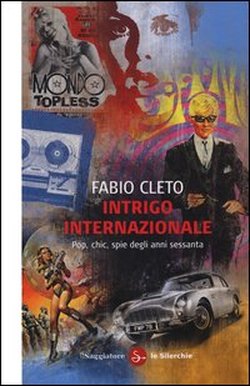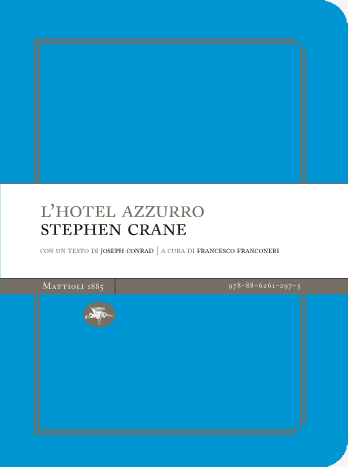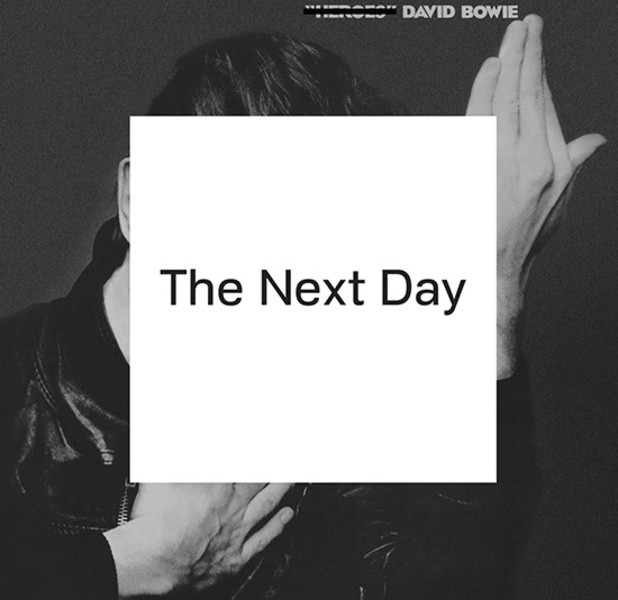Presentato con successo all’ultimo Sundance Film Festival arriva nelle saleUn giorno devi andare, terzo lungometraggio di Giorgio Diritti con Jasmine Trinca, Anne Alvaro e Pia Engleberth.
Augusta ha un dolore, terribile; la morte di un figlio mai nato, la perdita della capacità di procreare, l’abbandono di un marito insensibile. Decide di scappare da sé e dai ricordi seguendo suor Franca, missionaria amica della madre che gira tra le tribù dell’Amazzonia insegnando la civiltà e l’amore di Dio. Augusta conta di ritrovare un senso per la propria esistenza, lontana da tutto, sperimentando il fascino di una vita primitiva. Decide di staccarsi da suor Franca quando si rende conto di non essere in grado di condividere “la professione dello Spirito” che anima lei e gli altri missionari, l’offrire conforto e medicine in cambio di battesimi e matrimoni. Va a vivere in una favela vicino Manaus, ospite di persone conosciute nel viaggio. Lì, pur tra la miseria autentica, il degrado e la sporcizia, ritrova la felicità e la propria femminilità all’interno di una comunità in cui il poco che c’è è importante solo se condiviso.
Sentirà di nuovo l’impulso ad andar via, vedendo quella comunità venir meno travolta da un lutto così vicino al suo. Si isolerà su una spiaggia solitaria, in compagnia dei pensieri, fino a ritrovare il sorriso.
Il cinema di Giorgio Diritti si è sempre interrogato sul rapporto tra l’uomo e la natura, allo stesso tempo conforto e minaccia, ma unica dimora verso cui tornare. È il modo in cui l’uomo si colloca nella natura uno dei temi deIl vento fa il suo giroe deL’uomo che verrà.È il rapporto tra individuo, comunità e natura il centro diUn giorno devi andare.
Il dolore di Augusta la porta via dalla vita di tutti i giorni per spingerla lungo un cammino interiore che parte da migliaia di chilometri di distanza da casa. La ricerca di sé parte da un isolamento in una realtà aliena, in un mondo al di là del mondo conosciuto in cui annullare l’esperienza quotidiana in un randagismo evangelico su una mappa infinita di tribù. Non è quello che Augusta cerca, e lo capisce presto. La sedentarietà e lo spirito di condivisione sono l’essenza della sua ricerca, la dimensione in cui ritrovarsi. Nella favela trova la possibilità di quella famiglia che mai più potrà avere, madre, finalmente, non solo dei numerosi bambini vestiti di stracci, ma anche dei loro genitori e fratelli, guida di tutti, parte di una solidarietà più grande in cui acquisire, di nuovo, un senso. «Non è tempo di Dio ma di rimanere sulla terra», dice a suor Franca prima di separarsi da lei. Come Simone Weil inAttesa di Dio,che riceve in dono da un missionario, Augusta segue una via solitaria al cristianesimo, al di fuori della Chiesa ma in mezzo agli altri, per accoglierne e comprenderne le esigenze e le contraddizioni. Il suo viaggio parte dalla metafisica, dalla ricerca trascendentale del senso del dolore per arrivare a trovare risposte nell’immanente, nel contatto con gli uomini e con la terra, nello spirito dell’uomo, non in quello di Dio.
Giorgio Diritti, con la consueta fotografia di Roberto Cimatti, fa grande cinema di immagini, di paesaggi in cui è possibile sentirsi annientati dal tutto o parte di esso. Continua la sua indagine sulla natura, ne denuncia l’intimo legame con la vita sin dall’apertura, con l’ecografia del figlio mai nato proiettata nel blu del cielo amazzonico, accanto alla luna.
È la natura, nella forma di fiume impetuoso, a trascinare via il fragile equilibrio della favela e la ritrovata serenità di Augusta. È la natura, nell’isolamento finale, a consolarla e accoglierla e a offrirle un nuovo futuro, dal mare.
Jasmine Trinca porta addosso il dolore di Augusta come una maschera di apatia che lentamente si sgretola rivelando un volto nuovo, più forte, più sicuro. Regge il film con poche parole e con la sola presenza.
(Un giorno devi andare, Giorgio Diritti, 2012, drammatico, 110’)