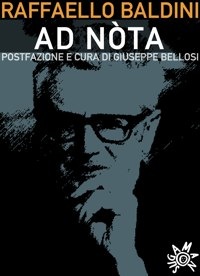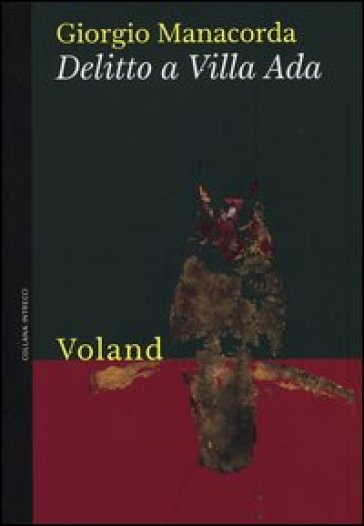Disponiamo la farina sul tavolo a formare un vulcano. Al centro di questo andiamo a inserire gli ingredienti da impastare. Al centro c’è l’inferno. Ma l’inferno del vulcano centrale è definito dalle pareti di farina bianca. Sono i contorni a definire gli ambiti. Si può descrivere una guerra con il negativo della sua fotografia. Così come un vulcano non sarebbe che uno spazio vuoto, se non fosse per le pareti di pietra che lo rinchiudono in sé. Se quindi se ne ha abbastanza delle guerre descritte per la loro perdita di senso, forse è il caso di definire le guerre per il senso che intorno ancora scorre tumultuoso. Forse in quel senso ritroveremo anche una certa allegria. È l’allegria della farina bianca, che pian piano definisce l’impasto centrale. È una ricetta delle più antiche, da cui il teatro può trarre molto.
Stefano Massini affida a Luisa Cattaneo il compito di creare tali legami di senso. Mimica e gestualità sono fatte per scolpire queste pareti di ironia talora spensierata, talaltra amara. L’amarezza non è mai indagata, se non come negativo di una vita che scorre tra i monti della Bosnia-Erzegovina e che presto dovrà cimentarsi con l’ineluttabilità delle guerre di religione. Razna (Luisa Cattaneo) dovrà rapidamente cavalcare la topografia della Bosnia per rimanere in vita. Eppure lo farà come un torrente che scende a valle, con svolte improvvise, che tuttavia hanno il pregio della naturalezza, come se ogni ostacolo non fosse altro che una demarcazione dello slalom di movimenti fluidi che avvolgono lo spettatore. Anche le religioni, presunto scrigno di verità umane, sono per Razna solo un vestito da dismettere al cambio di stagione, una piccola parte di una filastrocca di un alfabeto di feste religiose che travalicano nomi e insegne. Razna deve danzare su queste note, danzare intorno alla guerra, sfiorando quel vulcanico centro, senza mai toccarlo, per definirlo.
Le musiche di Enrico Fink non sono dunque solo il tappeto rosso degli eccidi balcanici, ma il motivo che permette a Razna di oscillare attorno agli eventi accarezzando con dolcezza la loro brutalità. Perché al centro c’è il macello balcanico, il Balkan Burger del titolo. In mezzo ci sono ponti di barche in fiamme, teste mozzate e sangue rutilante. E anche quando uno schizzo di quel sangue colpirà il volto di Razna, la ragazza saprà macellarlo a suo modo e immetterlo in un prodotto di macabra quanto ironicamente spensierata fattura.
Il testo di Stefano Massini ha dunque il pregio di contenere un personaggio che afferma con forza il proprio punto di vista, sino a portare allo spettatore una visione che solo di riflesso mostra le cupe ombre degli orrori umani, forse troppo accecanti per essere osservate direttamente.
Balkan Burger
di Stefano Massini
con Luisa Cattaneo
musiche di Enrico Fink
Prossime date:
Arezzo – Teatro Verdi, 15 marzo
Modena – Teatro Tempio, 16 marzo