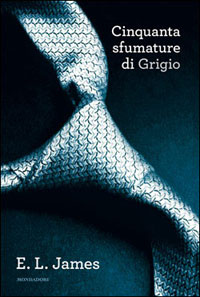Le cose stanno andando proprio così anche se facciamo finta di non accorgercene o, peggio, non ce ne accorgiamo affatto. «Abbiamo creato la Macchina perché eseguisse il nostro volere, ma noi ora non riusciamo a farle eseguire il nostro volere. Ci ha privato del senso dello spazio e del senso del tatto, ha offuscato ogni rapporto umano e ha ridotto l’amore a un atto carnale, ha paralizzato i nostri corpi e la nostra volontà, e adesso ci costringe a venerarla». Queste frasi non sono il manifesto di un neo-luddismo di seconda mano: la tecnica, concepita per essere funzionale al progresso, ci ha oltrepassato facendoci il più delle volte suoi prigionieri; ha modificato i nostri connotati, psichici e fisici, rendendo obbligatorio ideare nuove categorie antropologiche per tentare di definirci. Più di un secolo fa, qualcuno si è divertito, non senza un fondo di pura amarezza, a fotografare la nostra condizione. L’abilità è consistita nell’averci impressionato molto tempo prima che la tecnologia fosse giunta a uno stadio così avanzato, che i computer diventassero protagonisti e artefici di ogni ambito della vita, abituale totem domestico come da passeggio, mouse da azionare per decidere in un istante per via telematica le sorti mondiali che siano i mercati finanziari a farlo o altri; prima che grandi menti (filosofi, semiologi, sociologi, psicoanalisti) si applicassero ad aggiornare il diario di bordo dando conto di tutto ciò. Insomma molto prima che Levy e de Kerckhove (per citare che gli studiosi più celebri) sfornassero i concetti di intelligenza collettiva e connettiva evidenziando come la realtà virtuale cambi il tempo, lo spazio, il pensare, le categorie consuete con le quali siamo abituati a stare al mondo, le relazioni umane, il senso delle distanze, delle proporzioni, dei limiti, persino il campo percettivo: caduta la preminenza visiva, ora è il tatto a trasportarci nel mondo (ricorda de Kerckhove). Molto prima che il sociologo Zygmunt Bauman parlasse delle relazioni virtuali nel nostro mondo “liquido-moderno” come «modello che esclude tutti gli altri tipi di relazione». Infine, molto prima che psichiatri e psicoterapeuti individuassero un Internet Addiction Disorder tra le condotte psicopatologiche che si manifestano online (In Italia numerosi sono stati fin dagli anni ’90 gli studi dello psichiatra Tonino Cantelmi e collaboratori, e della psicoanalista junghiana Simonetta Putti).
Chi ci ha fotografato con tanto anticipo raccontando un mondo tecnologico senza più direzione è sorprendentemente lo scrittore inglese Edward Morgan Forster, conosciuto e celebrato per i romanzi Passaggio in India, Camera con vista, Maurice a cui ha arriso il successo anche grazie alla trasposizione cinematografica. Poco noto è invece La macchina si ferma (The machine stops), racconto che li precede. Sarebbe improprio definirlo fantascientifico perché, almeno in parte, è profezia che si avvera. Piuttosto rientra nella narrativa anti-utopica o distopica da Swift a seguire, che ha connotati precisi, compreso l’uso dell’immaginazione, attiva, verrebbe da dire, per fare la radiografia al futuro. Ora lo ripropone la casa editrice italo francese Portaparole che l’ha pubblicato nella collana Maudit applicando il felice criterio editoriale della proposta bilingue: in lingua originale e nella traduzione in italiano. Certo è bene sempre contestualizzare ogni atto creativo: come spiega nell’introduzione la docente universitaria Maria Valentini che ne ha curato anche la traduzione, il racconto di Forster, pubblicato per la prima volta nel 1909 sulla Oxford and Cambridge Review e in seguito nell’antologia The Eternal Moment, ben prima delle più celebri produzioni di Huxley e Orwell (rispettivamente Brave New World del 1932 e 1984 del 1948), nacque con un intento polemico nei confronti dell’ideologia positivistica imperante, fiduciosa nella realizzazione di un paradiso in terra grazie all’estensione della tecnica a ogni ambito dell’esperienza umana. Così è nella visionedi Herbert George Wells cui Forster si contrappone: l’autore de La Guerra dei Mondi e La Macchina del Tempo, nel 1904 in A Modern Utopia descriveva la nascita di uno stato mondiale perfetto perché governato dalla tecnologia. Ben diversamente vanno le cose nel racconto di Forster che ci porta in un pianeta in cui, tanto per cominciare, si abita nel sottosuolo perché le città sono precipitate in basso fino a una dimensione sepolcrale, private del contatto con la superficie, l’aria, la luce, il corso del sole, l’avvicendarsi del giorno e della notte, e totalmente automatizzate. Vashti e Kuno, la madre e il figlio protagonisti della storia, vivono come tutti gli altri, non più terrestri, ognuno in minuscole celle, tutte uguali tra loro, come quelle di un alveare, isolati e senza contatto che non sia attraverso uno schermo, sorta di computer e videotelefono insieme, che collega all’istante chiunque con il globo tutto dando luogo a relazioni tanto immediate quanto sempre a distanza e superficiali. Non si fa fatica a riconoscere almeno in parte modalità comportamentali e relazionali quotidiane, diffuse e automatiche: dall’uso di Facebook o altri cosiddetti social network, a quello di chat e webcam. Li accudisce, li protegge e al tempo stesso li nullifica la “Macchina”, pronta a soddisfare ogni esigenza di umani non più umani, dai corpi molli, atrofizzati perché disabituati a svolgere le loro naturali funzioni, dall’individualità indifferenziata; Macchina, in assenza di religione o ideologia, venerata come divinità. Gli abitanti di questo mondo del sottosuolo si spostano raramente perché la Macchina ha reso anche i posti uguali tra loro per cui non esiste più varietà e se si spostano lo fanno per mezzo di enormi aeronavi. Kuno però, da novello Ulisse, non si omologa, vuole conoscere il mondo che sta sopra e oltre, non crede sia inabitabile e irrespirabile come dicono e trova il modo di salire in superficie. Convoca sua madre (la costringe a viaggiare, non si vedono di persona da dopo la nascita secondo le regole della Macchina guidata da un fantomatico comitato centrale) per raccontarle ciò che ha scoperto: il sistema lasciato a se stesso si sta guastando. Solo abbandonando la città sotterranea ci si potrà salvare. Vashti non gli crede, nessuno gli crede né vuole uscire dal torpore. Il meccanismo di questo mondo invece collassa perché l’aggiustatore automatico smette di funzionare e uccide tutti. Tuttavia la morte è l’unica via di redenzione perché finalmente realizza il contatto umano: la madre bacia il figlio.
«Parli come se un dio avesse creato la macchina (…). Sono gli uomini che l’hanno creata, non dimenticartelo. Grandi uomini, ma uomini. La macchina è tanto, ma non è tutto», dice Kuno alla madre. Grandi uomini hanno ideato e realizzato la bomba atomica o armi di distruzione di massa o l’impianto nucleare di Fukushima esploso nell’aprile del 2011 a seguito di un terremoto e di uno tsunami con conseguenze che neanche immaginiamo. Alla tecnologia l’uomo ha delegato la responsabilità del proprio benessere; a essa si è affidato passivamente al punto che la situazione gli è sfuggita di mano. «Aveva sfruttato in modo eccessivo le ricchezze della natura. Con pacata compiacenza stava sprofondando nella decadenza; per progresso si era finito con l’intendere il Progresso della macchina» si legge nel racconto. Non è quello che accade e vediamo accadere? D’altra parte come non riconoscerci in un’umanità migrata nel mondo virtuale che vive soprattutto di relazioni “tecno-mediate”? Le nostre condizioni esistenziali non sono poi tanto diverse da quelle raccontate da Forster nel 1909: ce ne stiamo “pacificamente” in solitudine circondati magari da qualche migliaio di amici virtuali che sono motivo di vanto e orgoglio, esempio di riuscita integrazione sociale. Come i protagonisti del racconto viviamo ogni giorno l’incorporeità delle relazioni che è lo specifico della Rete, la destrutturazione spazio-temporale, l’illusione della vicinanza che talvolta può occultare la paura di contatti veri, autentici, respinti in una lontananza siderale seppur magari accessibili a un passo da noi nella vita reale. Il caso estremo a cui fa pensare il racconto di Forster è quello dei cosiddetti hikikomori, i ragazzi giapponesi che si chiudono nella loro camera rifiutando ogni contatto con la realtà che non sia quella mediata dalla virtualità; una forma di segregazione spontanea che si apparenta con il suicidio in vita. E chissà se il vivere nelle celle loculi del racconto, oltre a essere emblema di uno spazio sovraffollato e saturo, di un mondo prigione che ci rende reclusi sia pure tecnologicamente efficienti, non sia un simbolo potentissimo di un’umanità mai nata, rimasta fissata a una vita intrauterina collegata con una madre-macchina deresponsabilizzante che mentre tutto dà uccide perché annienta? Kuno sfida l’apparato anonimo e prova la nascita spingendosi in superficie che è anche ascesa sofferta alla dimensione della consapevolezza e dell’uscita dall’indistinto. Nascere in forma adulta alla vita richiede coraggio e forza eversiva. Kuno impara a usare il corpo, si muove nello spazio, scopre o riscopre in sé che «l’uomo è la misura»: spetta a lui autodeterminarsi, compiere scelte consapevoli di istante in istante, creare la realtà, diventare l’artefice di un mondo umano. Altrimenti si diviene succubi della tecnologia, con il rischio di esserne travolti e autodistruggersi. L’alternativa è un uomo che sia anche misura di tutte le cose, secondo la valutazione del filosofo Protagora, ovvero universo di potenzialità da sviluppare al meglio, che ci rendono distinti e differenziati, che ci permettono di individuarci direbbe il padre della psicologia analitica, Carl Gustav Jung. Lo stesso tema sviluppato da Forster ci porta non casualmente alla Laputa dei Viaggi di Gulliver di Johnatan Swift dove ci sono scienziati alienati e nocivi perché senza più contatto con la realtà della vita, al Castello nel cielo del grande regista giapponese Hayao Miyazaky; grandi metafore visionarie che sottintendono nella continuità straordinaria che lega artisti di ogni tempo e cultura sempre lo stesso concetto: l’uomo mosso dalla volontà di controllo e potere totale sulla natura si destina a essere un drammatico Prometeo incatenato, vittima dei suoi stessi errori. La tecnica se non padroneggiata con senso di responsabilità e coscienza del nostro essere solo ospiti di passaggio su questo pianeta ci porta all’annientamento. In quest’ottica l’esistenza di ogni individuo è sempre e a ogni istante una questione politica, una scelta continua che ha ripercussioni sull’intero globo. Forster l’ha comunicato attraverso una inquietante e profonda profezia letteraria. Il filosofo francese Pierre Levy ne L’intelligenza collettiva ce ne dà piena conferma: «Le tecnologie intellettuali non occupano un settore qualsiasi della mutazione antropologica contemporanea, esse ne sono potenzialmente la zona critica, il luogo politico».
(Edward Morgan Forster, La macchina si ferma, trad. di Maria Valentini, Portaparole, 2012, pp. 156, euro 16)