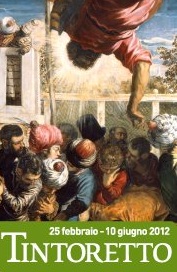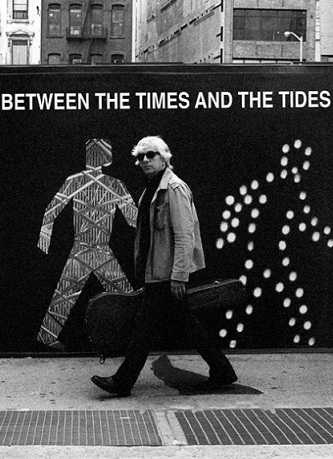Giunge finalmente alla Galleria Toledo di Napoli uno dei lavori più rappresentativi di Ricci/Forte, Macadamia Nut Brittle, non un omaggio al gelato Haagen Dazs quanto piuttosto una critica mirata alla società dei consumi. È di sesso che si parla, della sua natura carnivora e delle modalità di consumo, attraverso lo schema del dominante e del dominato in una performance magmatica, anti-narrativa, dove il palco diviene uno stambugio frequentato da quattro corpi abitati da solitudini tormentate. Un sesso anaffettivo che mangia e si fa mangiare, in cui il corpo esplica ciò che di oscuro risiede nell’anima, che ha appetiti proprio perché possiede un involucro. Il corpo introietta un’immagine, maschile/femminile, e ne assorbe forme, odori, umori, desideri. Questo processo, che poi provoca una coazione a ripetere, viene reso sul palcoscenico attraverso una performance d’impatto, cinica, disperata, feroce nei momenti comici – che spesso rimandano, nel caso in questione, a una Napoli popolare e a sua volta violentata – e straziante nelle narrazioni dei protagonisti le cui parole si conficcano nella carne, divorandola pian piano. L’ossessività del pos-sesso si riflette anche in uno stile di vita incentrato sul superfluo, sull’oggetto, organo esterno al corpo ma anche un supporto alla psiche, per citare Ruyer, che non sottrae ma riempie quando ci si sente svuotati. Le serie tv, i reality show, il gelato Macadamia da divorare davanti al televisore, il sesso meccanico, i muffin.
Infine il corpo stesso, che s(’)offre e deve divorare, anche senza gu(a)stare la sua preda, antropofago, dominato da istinti primari che, reiterati, diventano rituale condiviso. Un cannibalismo che può essere endogeno, praticato nei confronti dei membri della stessa comunità, o eterogeno. Ma, in realtà, il sesso descritto da Ricci/Forte, per quanto umiliante e degradante, è il retaggio proprio di pratiche scomparse, che oggi si ritrovano solo nell’atto del mangiare o giustappunto nel sesso vorace, soprattutto quello più estremo. Gli uomini di Ricci/Forte hanno una chiara coscienza del sé, non si sottraggono alla propria identità ma la vivono, andando contro l’etica dei nostri giorni, minando l’esperienza romantica per morire tutte le volte nel coito sadomasochista, nella crapula, che serve solo per sopportare meglio una società che, a sua volta, padroneggia e schiavizza i nostri corpi. Il sesso, allora, violento, spietato, che non vuole lasciare il posto alla purezza dell’amore (bellissima la sequenza in cui la magnifica Anna Gualdo viene legata come un salame e presa a calci mentre lei parla d’amore vero), diviene un viatico per scaricarsi, annullarsi in un altro corpo, a sua volta, martoriato da un Potere più grande di lui.
Difficile sostenere un lavoro tanto ardito ma i tre bravissimi performer – Giuseppe Sartori, Andrea Pizzalis, Fabio Gomiero – e la stravagante Wonder Woman, interpretata dall’ottima Anna Gualdo, riescono nell’impresa di centrifugare gli stilemi del contemporaneo – anche nelle quanto mai perfette improvvisazioni – per darli in pasto senza pietà ad un pubblico, ormai, preparato rispetto alle prime repliche. Un teatro necessario, forse ipercalorico, talvolta ammiccante, ma intelligente e sfrontato, importante proprio perché pieno di coraggio.
Macadamia Nut Brittle
di Stefano Ricci e Gianni Forte
regia di Stefano Ricci
con Anna Gualdo, Fabio Gomiero, Andrea Pizzalis, Giuseppe Sartori
in collaborazione con Garofano Verde Festival
Andato in scena dal 23 al 25 marzo presso la Galleria Toledo di Napoli.