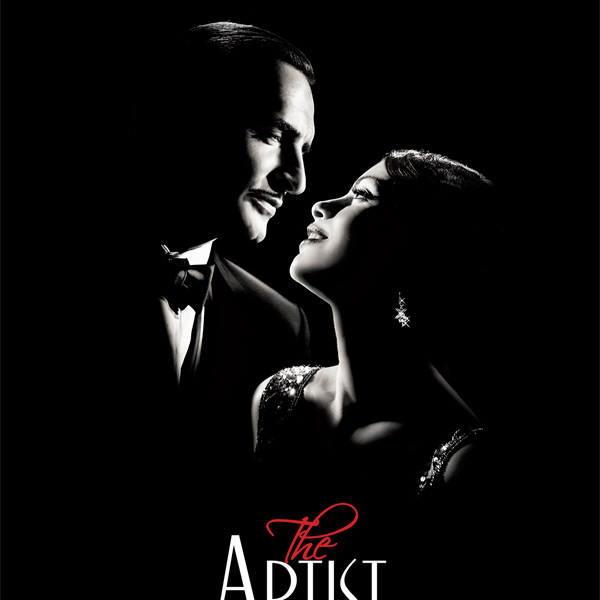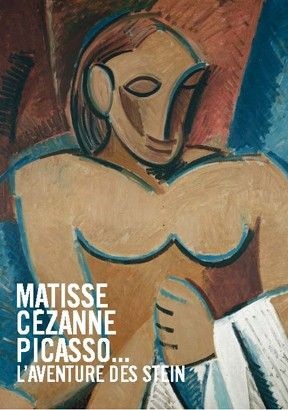Il cantiere di un palazzo in costruzione, a Buenos Aires. La mattina dell’ultimo dell’anno: architetti e arredatori che mostrano lo stato dei lavori, futuri inquilini che capricciosamente rimescolano la disposizione delle stanze, operai cileni che non aspettano altro che il pranzo, ad accorciare, per una volta, la giornata lavorativa. E, come se niente fosse, un plotone di fantasmi che fluttuano nell’aria, sghignazzando qua e là, senza destare il minimo scompiglio.
Nulla di incredibile, non ci siamo imbattuti in una storia per bambini, né in un romanzo fantasy, siamo semplicemente approdati nell’universo narrativo di César Aira, scrittore argentino estremamente prolifico e, a tratti, delirante. Chi già conosce l’autore non si stupirà, infatti, che in una narrazione apparentemente iperrealista, come quella de I fantasmi (edizioni Sur, 2011), il suo ultimo libro, si vadano a inserire elementi del tutto fantastici. Non si tratta di realismo magico, nulla a che vedere con l’atmosfera mitica e favolistica di Macondo: non vi è nulla di più reale – e realistico – della stanchezza di una ventina di operai che lavorano sotto il sole cocente di Buenos Aires, né delle infinite proteste di quattro bimbetti scalmanati che scappano via tra gli appartamenti ancora in costruzione piuttosto di fare la siesta. Non vi è nulla di più reale dei sogni e delle insicurezze della Patri, la giovane protagonista del romanzo, che vive con la sua famiglia in una casetta improvvisata all’ultimo piano dell’edificio perché suo padre, Raul Viñas, un cileno che sognava di fare l’architetto, si è ritrovato in Argentina a fare la guardia al cantiere.
Queste sono le scene alle quali assistiamo, quasi come davanti a un film, perché la scrittura di Aira ci avvolge, inondandoci di dettagli impercettibili, grazie ai quali ogni impressione che abbiamo è profondamente visuale e riconoscibile. Nel contesto apparentemente comune costruito dall’autore, però, ci sono almeno due elementi stranianti, che richiedono piena fiducia e pieno affidamento da parte del lettore: nella calma sospesa e afosa del pomeriggio del 31 dicembre, infatti, nessuno sembra preoccuparsi del fatto che quattro bambini scorrazzino indisturbati per un edificio sprovvisto di ringhiere e protezioni, quasi l’intero palazzo fosse come avvolto da un’immobilità tale da non concepire nemmeno l’idea della caduta; allo stesso modo, nessuno è apparentemente scosso dalla presenza dei fantasmi. Non immaginiamoci paurosi ectoplasmi o lenzuoli bianchi, i fantasmi di Aira sono del tutto simili a uomini nudi con la pelle cosparsa di calce: «Robusti, alti come argentini», dispettosi, appaiono schiamazzando qua e là, sapendo che, oltre ai membri della famiglia Viñas, solo i bambini possono vederli. Tra questi, la Patri è l’unica che riesce a entrarvi in contatto davvero. Li sente ridere e vociare, e ne è perfino attratta: dal suo punto di vista – quello di una ragazzina in crisi, alla ricerca di un amore adolescenziale che curi la sua perenne sensazione di inadeguatezza – quegli uomini semitrasparenti rappresentano l’ignoto, la novità, qualcosa di irripetibile. Come irripetibile è l’occasione che le si presenta quando viene invitata al veglione di Capodanno dei fantasmi. Ne è tanto affascinata da accettare quasi senza esitazioni, forse senza rendersi conto che, per parteciparvi, dovrà essere morta.
È solo verso la fine del romanzo, quando la narrazione sembra decisamente accelerare – celebre è la cosiddetta huida hacia adelante, ovvero lo slancio della scrittura di Aira, sempre protesa verso un finale, per quanto improbabile –, che d’improvviso comprendiamo la storia che abbiamo davanti: non il semplice resoconto, a tratti surreale, di un pomeriggio dell’ultimo dell’anno, ma uno spaccato profondamente realistico e commovente. Tutto è in bilico, tutto è precario, non costruito: il cantiere, la situazione economica della famiglia Viñas, le certezze della Patri, l’arte stessa. Come sempre, la cifra stilistica di Aira unisce alla pura e semplice narrazione ricercate incursioni nel campo della saggistica. Un sogno è il pretesto per un’ampia digressione sull’architettura da un punto di vista sociologico, la scena di madre e figlia davanti alla tv richiama un commento tecnico sulla struttura degli sceneggiati, e così via. Il fulcro continua a essere, in ogni caso, la discussione sulla letteratura stessa: «Il non costruito è caratteristico delle arti che esigono per la loro realizzazione il lavoro retribuito di un gran numero di persone […]. Il caso più tipico è quello del cinema […]. Con le altre arti, in misura maggiore o minore, succede la stessa cosa. Però si potrebbe concepire un’arte nella quale le limitazioni della realtà fossero minime, nella quel il fatto e il non fatto si confondessero, un’arte istantaneamente reale e senza fantasmi. Forse esiste, ed è la letteratura».
(César Aira, I fantasmi, trad. di Raul Schenardi, Sur, 2011, pp. 140, euro 15)