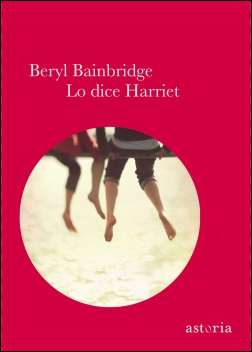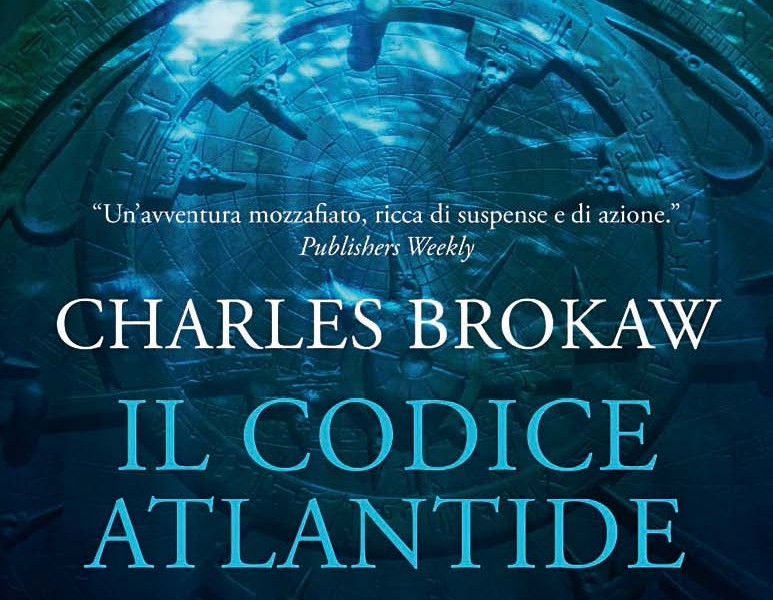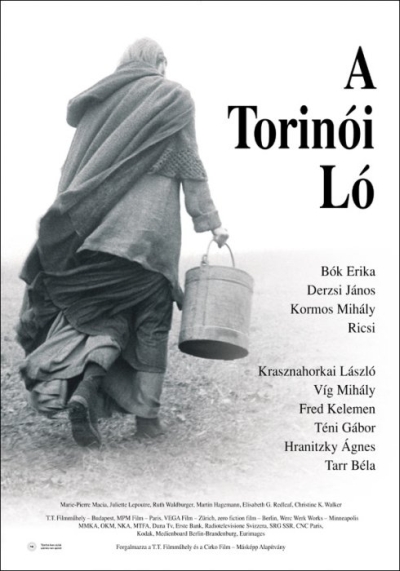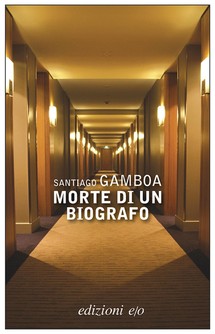Virtuosistico pezzo di bravura, questo La porta sbarrata di Edith Wharton, a cura di Angelica Chondrogiannis, per la prima volta tradotto in italiano a così tanti anni di distanza dalla sua prima uscita, sullo Scribner’s Magazine del marzo 1909. La raffinatissima arte letteraria della scrittrice americana (ma che, proprio come il suo mentore-amico Henry James, finì per cedere al fascino del “vecchio mondo” europeo in cui trascorse la propria maturità, fino alla morte) andrebbe magari additata come esempio a più di un raffazzonato e successoso vendi mila-copie italiano, ma può in ogni caso costituire fonte di sottile, sublime piacere intellettuale per lettori del tipo (se ci è lecito cedere a un’assonanza martellataci in testa dalla pubblicità) «che non si accontenta».
Come non gustare, infatti, la sottile abilità narrativa con cui sono costruite queste 80 pagine che solo nelle più grossolane apparenze risultano un giallo, con tanto di delitto, assassino e finale punizione del medesimo? Intanto, perché l’assassino è sulla scena fin dalla prima riga del racconto, ma, di più e meglio, perché, contro ogni regola codificata del genere (l’assassino verrà identificato con lente, complesse manovre narrative, magari toccando le 300, o 600, pagine fitte e, ça va sans dire!, identificato là dove meno il lettore si aspettava), qui è proprio lui, l’assassino, che narra il suo delitto, ma lo fa, occorre dire, con una calibratissima frantumazione narrativa: a tre diversi, successivi destinatari. Non solo: la ricerca di un destinatario intradiegetico per l’assassino-protagonista finisce per diventare morbosa, ossessiva, fino a condurlo, per il tramite del più ovvio qui pro quo di molestatore sessuale, nell’agognato carcere. Sì, perché, l’altro capovolgimento funambolico delle regole del genere sta poi nel fatto che qui l’assassino vuole essere, anzi fa di tutto, per essere scoperto, arrestato e, sperabilmente, mandato a quel supplizio finale cui la sua viltà umana gli impedisce di accedere con l’uso della sua pistola-gingillo di madreperla.
Ed è qui che s’innesta il colpo di genio: se è vero, com’è stato autorevolmente detto, che ogni opera letteraria è resa possibile da una “sospensione d’incredulità”, ebbene: è appunto questo, che qui non avviene. L’incredulità permane, impera, anzi giganteggia fino a spingere il malcapitato narratore nel limbo punitivo della follia: uno dei suoi ultimi gesti è quello di redigere memoriali di maniacale precisione in merito al proprio delitto, da consegnare, come una manoscritto nella bottiglia, a chi, finalmente, farà ai lettori grazia della canonica soluzione del plot.
Ma non è un giallo, questo, si diceva: è, in realtà, (e non casualmente, il protagonista è uno scrittore-drammaturgo fallito: sarà magari una cifrata, dolente allusione all’immensa bravura narrativa di Henry James, che invece non riuscì a sfondare mai sulla scena, ai suoi tempi?), il narrare stesso che si auto-rappresenta. Nel suo porsi in antitesi alla vita (fu Pirandello, che cadde nella facile ovvietà dell’omoteleuto «la vita o la si vive o la si scrive») qui appunto rifiutata dal protagonista-narratore. Nel suo identificarsi – per esorcizzarla? – con l’estrema inanità, con lo scacco, che qui viene incarnato non solo dai destinatari uno dopo l’altro incapaci di prestar fede alla storia del protagonista, ma perfino nell’ultimo gesto su cui il racconto si chiude: «“Tienila, prendila, mi dà la nausea” disse bruscamente, allungando il foglio al cronista».
Esorcizzarla: perché, che altro è, nella sua perfetta misura, questa narrazione, se non un ulteriore trionfo della vera, grande letteratura?
(Edith Wharton, La porta sbarrata, trad. di Angelica Chondrogiannis, Mattioli 1885, 2011, pp. 80, euro 10,90)