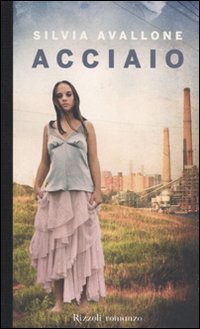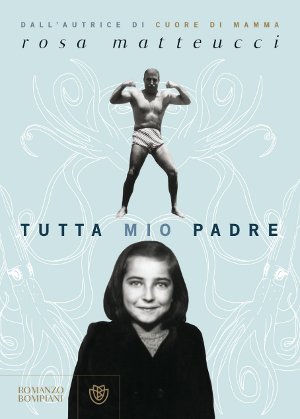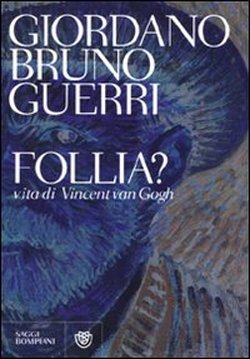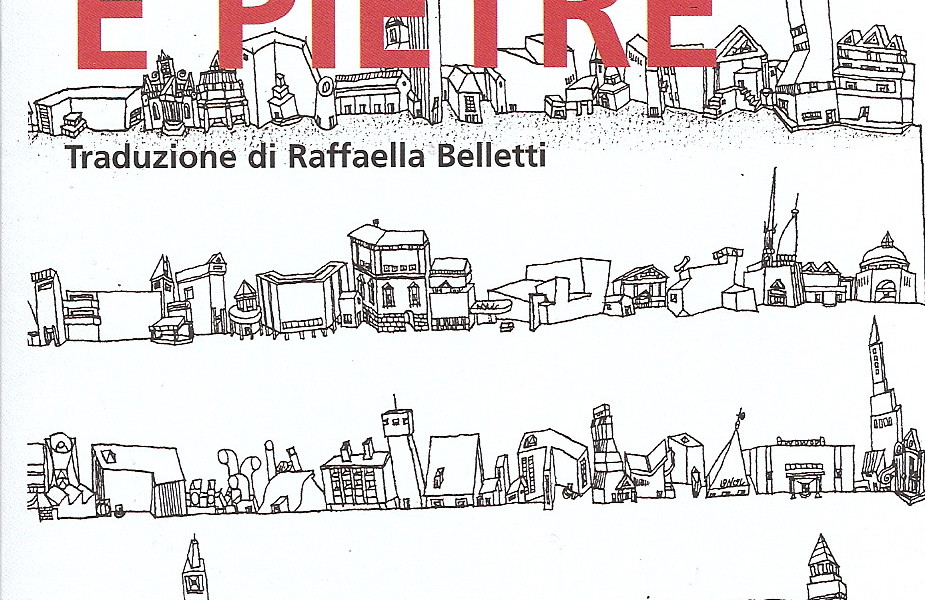Il racconto relativo ad Adamo ed Eva, la loro cacciata dal giardino di Eden e l’inizio della vita sulla Terra, è considerato, senza ombra di dubbio, uno dei miti fondanti dell’umanità. Sebbene la narrazione originale sia sviluppata nel libro di Genesi in poco più di cinquanta versetti, fin dall’antichità troviamo traccia di rielaborazioni e ampliamenti del nucleo iniziale con cui scrittori d’ogni epoca hanno cercato di ridare ai nostri progenitori un senso maggiore di universalità e di umanità. “L’infinito nel palmo della mano” (Feltrinelli, 2009), di Gioconda Belli è una ricostruzione moderna della storia di quella giovane coppia, così sola ma anche così profondamente coraggiosa. La scrittrice nicaraguense racconta, nella breve nota iniziale, come una lettura casuale di alcuni libri apocrifi dell’Antico Testamento, qualil’“Apocalisse di Mosè” e la “Vita di Adamo ed Eva”, abbiano generato in lei la voglia di riscrivere la storia dei nostri due antenati comuni. Ciò che ne vien fuori è una narrazione poetica, rapida ma commovente, capace di trasmettere le emozioni primordiali della prima coppia dell’umanità, in un costante intreccio di angoscia e meraviglia, di paura e di stupore.
Leggendo queste pagine così coinvolgenti scopriamo allora che Dio non è altri che un demiurgo invisibile e annoiato, intento a creare universi e mondi di cui poi si dimentica all’improvviso. E ancora che il Serpente, riflesso contrario di Elohim, è, in realtà, l’unico essere sovrannaturale che ha la volontà di interagire con i poveri umani e che aiuta Eva a capire come, in fondo, non vi sia colpa nel peccato originale perché tutto è già deciso, nei piani del Creatore, sin dall’inizio.
Dalla beatitudine incosciente vissuta in Paradiso, Adamo ed Eva passano, improvvisamente, all’insicurezza e alla precarietà esistenziale della Terra, gettati al mondo senza dettami né certezze, liberi di scoprire sulla propria pelle ciò che è bene e ciò che è male. Passo per passo, rivelazione per rivelazione, i due esseri umani prenderanno atto della loro nuova condizione, arrivando quasi a preferire una libertà cosciente alla cecità banale del Giardino: “Se non avessi mangiato quel frutto, disse lei fissandolo negli occhi, non avrei mai assaggiato un fico o un’ostrica, non avrei visto l’Araba Fenice risorgere dalle sue ceneri, non avrei conosciuto la notte, nè avrei saputo cosa significa sentirmi sola quando tu non ci sei; non avrei sentito il mio corpo, gelato anche in mezzo alle fiamme, che si scaldava appena pronunciavi il mio nome e avrei continuato a vederti nudo senza sussultare e non avrei mai saputo come è bello quando scivoli dentro di me come un pesce che inventa il mare”.
È così che ha inizio la Storia dell’umanità: la scoperta dell’agricoltura e della caccia, l’addestramento degli animali, la sofferenza del parto e la meraviglia di mettere al mondo delle creature a propria immagine e somiglianza. Fino all’incomprensibile rivelazione della morte, vista, per la prima volta, negli occhi lucidi di un coniglio catturato da Adamo, poi nello sguardo fisso e gelido di Abele, ucciso dal fratello Caino per amore e per gelosia. È con magistrale bravura che Gioconda Belli ci racconta tutto questo, arrivando a toccare le corde più profonde del cuore del lettore perché, come sostiene lei stessa nella chiusa finale della Nota dell’autrice: “Con tutta la meraviglia e il suo stupore, questa è la storia di ciascuno di noi”.