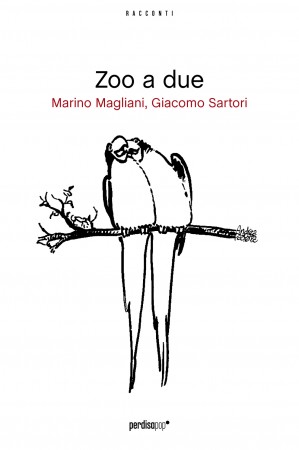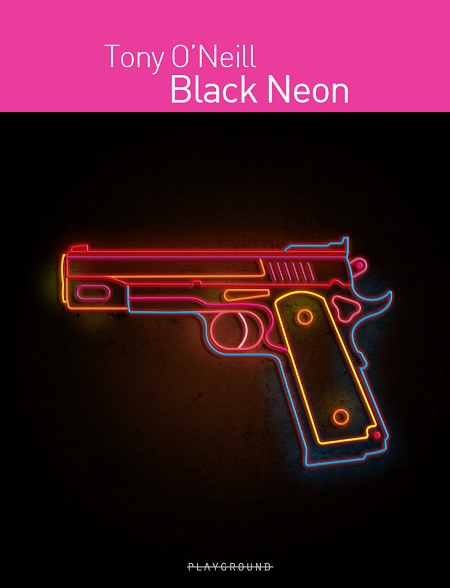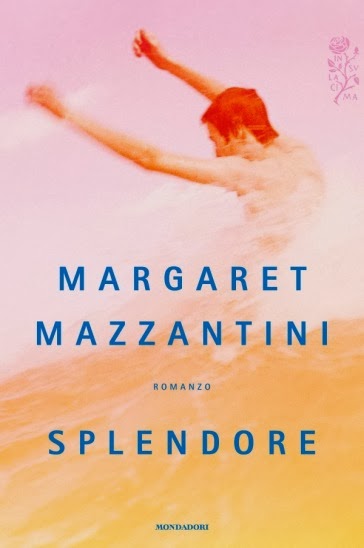Della mia età sono tipiche le tessere. Tessera Arci, Mondadori Card, CartaPiù Feltrinelli, tessera Einaudi, tutte le tessere delle biblioteche di Lettere e Filosofia di Bologna (per le fotocopie), la fidelity card della profumeria La Gardenia, la tessera socio Coop e socio Conad, la tessera per entrare al Covo, per entrare al Casale, per entrare al Locomotiv, la tessera della biblioteca del mio paese (naturalmente), la tessera zero-ventisette dei teatri dell’Emilia Romagna, la tessera sanitaria, la tessera di Media World e quella della Comet. Più tutte le tessere dei negozi, che ti fanno un timbro ogni dieci euro di spesa e che se arrivi a mille timbri in un anno ti scontano dal prossimo acquisto, appunto, i dieci famosi euro. Che ci sono arrivata solo una volta a completarne una, di queste tessere, e manco ho ancora sfruttato lo sconto. E penso che la promozione sia scaduta. Ma in genere tendo a buttare le raccolte-timbri, buone solo ad aumentare il volume del portafoglio. Le butto; come devo poi ricordarmi di buttare anche la tessera del Casale, che è un pessimo locale che ci ho sfatto il davanti della macchina finendo in una specie di fosso non illuminato nel parcheggio e che l’altro venerdì c’era un’auto col vetro rotto e delle ragazze piuttosto isteriche e incazzate intorno. È un pessimo locale anche per la musica che mettono, ovviamente. Sicché ci si va solo perché, fatta la tessera, cinque euro validità un anno, dopo non si paga più per entrare. Poi è vicino casa, il Casale. Comunque il bilancio resta negativo, perciò devo ricordarmi di buttare la tessera e fare largo nel portafoglio. Che con tutti ’sti cartoncini più o meno plastificati, a tenerci anche quelli che non si usano, aumenta il traffico e relativi ingorghi e casini e disfunzioni di tessere. Che per quanto cerchi di riordinarle e separare almeno quelle culturali, da quelle dello svago, da quelle dei servizi, eccetera, insomma… Dicevo: che per quanto cerchi di sistemarle, queste poi inevitabilmente si mischiano sempre. Che quando prendi le sigarette al distributore, per dire, fai in fretta e la tessera sanitaria la metti a caso, dentro uno scomparto comodo, che non è mai il suo. Idem col Bancomat, La Tessera (quella deve stare sempre davanti a tutte, inutile dilungarsi sui motivi).
Ecco, tutto questo preambolo che apparentemente non c’entra e invece sì (che l’apparenza inganna lo sappiamo tutti). Allora tutto questo preambolo per dire che oggi, di un appuntamento, mi è rimasta una tessera. I soliti cinque euro per entrare a tutte le manifestazioni di tale Associazione X. Una tessera che molto probabilmente non userò più che l’Associazione è di Milano. Una tessera inutile allora. Da buttare per fare largo nel portafoglio. Ma andiamo per ordine.
Presente quando fai un weekend al mare? Niente di estremo. Vai in Riviera con un paio di vecchie amiche, a zonzo per le vie e poi in spiaggia nei localini – presente? – quelli con la musica tunz e i cocktails a 8 € perché l’ingresso è free. Niente di estremo, un paio di birre che noi mica beviamo tanto, c’abbiamo pure una certa età. In tutta questa calma piatta ti capita pure che incontri dei tizi. E tra tutti magari ce n’è uno mezzo decente, no? Bene, stavolta c’era. Ma poi – siamo onesti – era decente intero, mica tanto mezzo. E questo è il motivo per cui dopo, più in là, mi si è ingrassato il portafoglio di una nuova tesserina. Però continuiamo a andare per ordine. Niente: con ’sto ragazzo all’apparenza (vedi sopra, apparenza inganna eccetera) un po’ timido poi ci siamo scambiati i contatti e ci siamo sentiti. E da cosa nasce cosa e il sole sorge la mattina a Est e tramonta la sera a Ovest e panta rei. Dunque questo ragazzo, che chiameremo Marco perché è un nome abbastanza diffuso e non è il suo (che a differenza di quel che dice un noto cantautore italiano, di cui non farò il nome – ma posso anche farlo: Manuel Agnelli –, a me piace invece cambiare le robe, mescolare le carte e inventare di sana pianta quando scrivo). Dicevo: con questo Marco ci sentiamo e ci vediamo un paio di volte. Ma lui sta a Milano, quindi arriva presto il giorno che ha un’idea all’apparenza (e non mi ripeterò più sulla sostanza dell’apparenza) dolce e carina. L’idea di invitarmi su da lui che poi si va insieme alla manifestazione della tale Associazione X di cui ho già detto. Ah sì, dunque, l’evento in questione si potrebbe chiamare lettura in musica, tipo. Allora io mi gaso moltissimo – capite? – perché dico che cazzo, questo mi invita a una roba culturale, dove tra l’altro c’è quello scrittore che legge e quell’altro cantautore che un po’ mi piace… dai, che carino, che dolce, che bello che bello che bello eccetera. Ovvio che accetto. Che prendo la mia macchina e vado. La domenica. A Milano.
Sappiate che il benvenuto, a Milano, ve lo dà la barriera in cui abortisce brutalmente l’A1. E se siete sprovvisti di Telepass, ve lo dico a mo’ di informazione gratuita, i minuti di coda sono direttamente proporzionali alla prossimità oraria della partita allo stadio (ricordo che è domenica) e del flusso di pendolari in rientro.
Io approdo nella city di primissimo pomeriggio, ho praticamente saltato il pranzo, per cui a Marco gli dico che si può andare a prendere un gelato, intanto. Non siamo proprio in centro, Lambrate credo, o qualcosa di vicino. Me mi sembra di girare in tondo, penso che in macchina sarei del tutto incapace di gestire la situazione viabilità-parcheggi. Progetto che andrò a vivere in città (no Milano, oppure anche Milano, comunque una città prima o poi sì) abbandonando l’auto in paese e portandomi solo una bicicletta. E un lucchetto. Di quelli massicci, in metallo. Mentre io penso tutto questo, Marco mi fa camminare fin davanti al portone di casa (il gelato lo abbiamo già mangiato seduti sulla panchina davanti alla gelateria siciliana e lui era ridicolo coi baffi e la barba impiastricciati di gelato; comunque sempre bello). «Ci beviamo un caffè intanto che aspettiamo le sei». «Ok!» (ma non sono molto tranquilla… Mi deve essere sfuggito qualcosa nel tragitto gelateria-appartamento). Casa vuota. Divano. Acqua. Nessun caffè in arrivo. L’avevo anche pensato che poteva succedere. Che uno mica ti invita a Milano, dove vive, solo per andare insieme il pomeriggio a una roba intellettuale. Dopo poi mi ero anche detta ma uno perché si deve sbattere così per farsi una scopata, che a Milano mica ci sarà penuria di sgallettate? (Ad ogni modo adesso, che di tempo ne è passato un po’ da quella domenica pomeriggio metropolitana, posso dire che le vie per arrivare alla scopata percorse dagli ometti sono infinite. Ce n’è alcuni che proprio ti adorano per settimane solo per farti aprire le gambe. Non è che sia un avvertimento, amiche. Vi faccio solo l’occhiolino, che tanto sapete già tutto). E niente, mentre mi do dell’idiota e da cosa nasce cosa, il bellimbusto è pronto a portarmi di là. Blocco tutto in una maniera bilanciata tra il tenero, il goffo e l’imbarazzato. Ed è a questo punto che il marco di turno vorrebbe rispedirmi a casa tipo col teletrasporto. Invece deve tenermi lì che il teletrasporto mica l’hanno ancora inventato. Mi offre altra acqua poi dice che forse si può uscire e «magari si va a bere qualcosa».
Come quando cerchi i biscotti spezzettati in fondo al pacco maxi (gran risparmio), presente? Che smisti e smazzi e scuoti ecc. e non li trovi che sono proprio in fondo in fondo e tu hai appena aperto la confezione però sono le 19 e tu mica puoi mangiarti biscotti interi che poi si cena e ti senti in colpa e allora meglio sarebbero solo pochi pezzetti (che poi alla fine se te ne mangiavi uno intero era più economico, parlando in termini di chilocalorie; comunque). Come quando agiti la busta dei biscotti e non trovi i pezzetti, dicevo, qui nessuno dei presenti, che poi siamo Marco e io, trova qualcosa da dire. E la macchina procede. Poi fortuna vuole che si arrivi al posto dell’evento per cui mi feci cotanta strada, che è un ex edificio industriale un tempo sede di un’azienda grafica, per cui dentro c’è pure una paleografica macchina tipografica uau! Si entra, lui incontra facce note che lo salutano, io mi metto in fila per la benedetta tessera. Pluf, nel portafoglio anche lei, assieme alle altre; fatto. Che poi mi dico che tra tutta quella gente e nessun controllo se anche non l’avessi fatta, la tessera… ma va bene, certe Associazioni che organizzano robe decenti vanno anche sostenute.
Allora entriamo, procediamo tra la folla. C’è pure un bancone adibito a bar che vende birre alla spina e prosecco&Crodino già versati nel bicchiere per fare presto che c’è gente. C’è pure un bambino steso per terra che gioca con un vecchio trenino di legno e che io mi stupisco che a Milano ci sia ancora un bambino che i genitori lo lasciano spalmarsi sul cemento col vestito della domenica. E sorvoliamo pure sul trenino di legno che era molto dolce e mi faceva pensare neanche alla mia infanzia, che io al massimo c’avevo un trenino elettrico che andava sulle rotaie, ma forse a quella di mio padre.
Dunque entriamo, ok. Prendiamo posto. Ci sono delle sedie, delle panche, dei gradoni a lato. Dei giornalisti pure. Gente che fotografa. Cominciano quasi subito. Uno legge dei suoi racconti, l’altro suona qualche pezzo tra una lettura e l’altra. «È la mia canzone preferita… la sua mia canzone preferita…» faccio a un certo punto. Marco si alza «Vado un attimo in bagno». Ahahahah (rido di me). Ma io ti dico che mi piace una canzone e tu ne approfitti per andare a pisciare? Ma vaffanculo. Comunque bene, ricomponiamoci, facciamo finire in fretta la giornata. Eccolo là di ritorno, alto e bello come il sole. Intanto lo spettacolo (se lo vogliamo chiamare così) è pure finito. Mi avvicino. «Hai fame?» (lui). «Un po’» (io). «Dai, ci prendiamo una pizza poi ti riaccompagno alla macchina!» Ma voglio morire, ma portami diretta al mio mezzo che piuttosto mi mangio una Rustichella in solitudo all’Autogrill. «OK!» (troppa enfasi ci metto; comunque: procediamo spediti). Il “ci mangiamo una pizza” di Marco significa pizza al taglio mangiata all’impiedi e alla svelta. Tanta gente e puzza di formaggio. E puzza di sudore. Ok, facciamola finita. Mi riporta (finalmente) alla macchina. Ciao-ciao ci sentiamo e solite robe. Non credo però sia giunta la tenera raccomandazione di guidare piano e con prudenza. Ma neanche tipo di avvisare una volta arrivata. E c’avevo ben più di cento chilometri da fare sotto pioggia torrenziale (sì, poi ha pure cominciato a piovere, quando si dice le disgrazie non vengono mai eccetera). Va be’ che l’educazione vagola raminga oramai da tempo. Niente, allora ci siamo. Questo mi fa pat-pat sulla testa (nel senso che mi dà due buffetti sulla zucca proprio pronunciando tale onomatopea, pat-pat, a me ignota; ora ditemi voi che significa se potete… pat-pat cooosaaa?) e si può salire in macchina, ciascuno sulla propria, e ripartire.
L’indomani al solito bar sei pronta a pagare il tuo solito caffè. Sei di fronte al solito barista e apri il tuo solito portafoglio. La vedi. La tesserina di cartoncino dell’Associazione di Milano. Cazzo, la butto. Prendo lo scontrino, esco e butto tutto assieme. E poi esci e butti solo lo scontrino. Decidi che la tesserina nuova la lasci nel portafoglio. Non la butto che la tengo come promemoria. Che uno pensa che da un appuntamento magari ci si possa ricavare delle parole, o delle idee, o un caffè, un bacio, forse un arrivederci. E invece ti ritrovi con una tessera. Che in sintesi ti dice che sei un po’ ingenuo ma ancora te stesso. Tu che vai fino a Milano per vedere una persona e andarci insieme a sentire una lettura musicata. Tu che finisci nell’appartamento di questa persona ma non ci scopi perché in fondo «pare brutto», «affrettato?» «eeh, sì». Tu che vai alla lettura, mangi al volo una pizza al taglio, sei riaccompagnata alla macchina, in fretta salutata, bacio a stampo e buffetto in testa. L’indomani ti ritrovi con una tessera in più nel portafoglio.