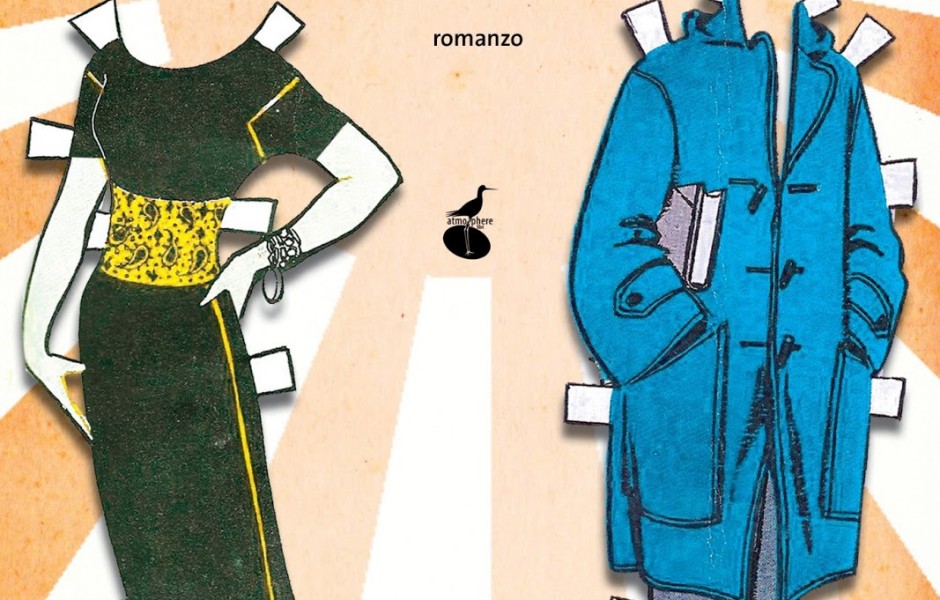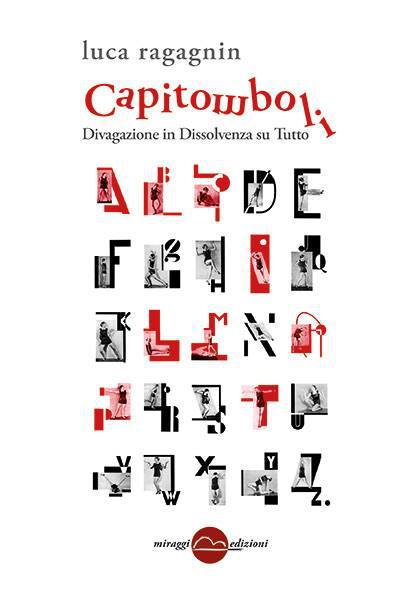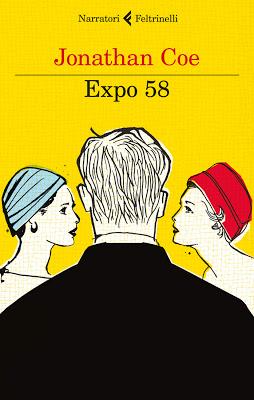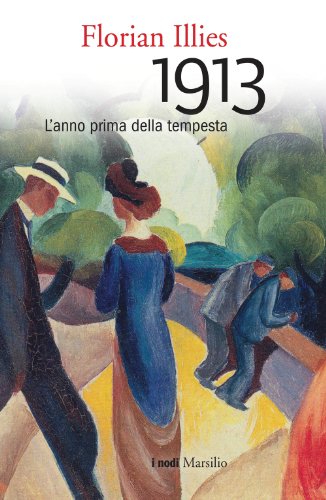siamo nel 2012 oggi lo so ma tanto tempo fa ma non mi chiedete quanto perché mica lo ricordo ero dentro un treno e non avevo voglia di dormire anzi stavo leggendo chissà quante volte l’avevo letto tante volte il mio racconto preferito un treno in cima al mondo di uno scrittore del sudamerica che non so dove si trova non ricordo bene non ho tanta memoria e poi che c’entra sapere chi è che ha scritto l’importante è leggere e che ti piaccia il racconto e quello mi piace e lo stavo leggendo anche quella volta lì perché come ho detto lo leggo spesso e leggendolo pensavo che avevo dormito anche troppo in quegli anni non dormito nel senso di chiudere gli occhi sognare e quelle cose lì no quello no anzi dormivo poco io c’erano volte che non riuscivo proprio a chiudere gli occhi che poi mi frizzavano e diventavano rossi insomma non dormito in quel senso ma dormito come dorme chi non si accorge che il mondo è cattivo e crede che invece sia buono e pensa che le persone siano tutte buone e invece nono no no è brutto e cattivo il mondo e allora avevo deciso via via via di lì via dalle persone che ce l’avevano con me ma non riuscivano a prendermi e a uccidermi pensavo dentro a quel vagone che dondolava e che saliva saliva saliva e io ero dentro a quel treno e non mi avevano preso eh no sono sempre vivo pensavo e se non fossi vivo come potrei scrivere questo che scrivo e raccontarvi quello che vi sto raccontando io grande scrittore anche se nessuno dice quando mi vede quello è un grande scrittore o compra i miei libri perché nessuno vuole pubblicarli perché sono tutti cattivi ma un giorno vedranno quelli cattivi che non si accorgono che sono un grande scrittore io ma per tornare al racconto se no poi mi perdo in cose inutili e a volte è quello che mi frega perdermi in cose inutili come mi diceva sempre il babbo non perderti in cose inutili combina qualcosa nella vita benedetto figliolo ma forse era maledetto figliolo perché poi partiva sempre qualche ceffone anche quando non ero più piccolo ma grande ormai poi il babbo è morto e sono rimasto in casa da solo e cercavo di non perdermi in cose inutili ma non c’era neanche più il babbo a dirmelo e non era facile fare cose utili che poi non ho mai capito cosa volesse dire se devo essere sincero ma insomma ora sto scrivendo questo racconto e non devo raccontarvi la mia vita che magari neanche ve ne frega qualcosa devo raccontarvi cosa mi è successo e perché sono qui ma dove sono non ve lo dico perché ve lo dico alla fine come fanno i grandi scrittori che il segreto lo svelano solo alla fine e anch’io lo farò con voi insomma ero su quel treno e leggevo quel racconto che parlava proprio di un treno ed era il mio racconto preferito come forse vi ho già detto e il treno dondolava perché era un trenino di campagna anzi di montagna perché saliva saliva saliva fra i boschi dove andava non lo so e neanche so da dove era partito perché io ho poca memoria e mi scordo sempre di tutto e non è una bella cosa lo so ma non è colpa mia e poi non è sempre così male non aver memoria perché quando fai una brutta cosa e a tutti capita di farla perché se dite che a voi non capita mai non ci credo e allora quando capita di fare una brutta cosa la si dimentica e va bene che l’hai fatta però non ci stai male perché non te lo ricordi e allora va meglio anche se hai sbagliato ma non lo sai e allora non dico che è giusto ma è meglio così anche se però senza memoria ti scordi anche le cose belle che però a me non capitano mai però non lo so di preciso perché non me le ricordo comunque devo raccontarvi cosa facevo su quel treno e allora ero su quel treno che dondolava e due ragazzetti mocciosetti mi guardavano e ridevano ma che ridete pensavo che avete da ridere non avete mai visto una persona che ridete pensavo non lo dicevo a voce alta lo pensavo e basta perché non sono poi abituato a parlare molto con le persone due ragazzetti mocciosetti poi figuratevi se parlo con loro i ragazzetti mocciosetti non mi sono mai piaciuti e anche quando ero giovane anch’io non mi piacevano e ai giardinetti a giocare non ci andavo mica e neanche a pallone o al bar a sentire la musica stavo a casa con mio padre e da piccolo piccolo anche con la mamma che poi è morta giovane povera donna ma non ha patito è morta all’improvviso e non ho mai capito perché e il babbo non me lo ha mai detto insomma ero su quel treno e quei due ragazzetti mocciosetti ridevano di me e allora ho preso dalla mia busta d i plastica il mio vecchio astuccio delle elementari che portavo sempre con me anche se un ragazzetto mocciosetto della mia scuola un giorno me lo aveva sciupato per dispetto facendomi un graffio con un temperino su quei bellissimi pesci azzurri e rossi che ci stavano sopra e io avevo pianto quando ero tornato a casa e avevo anche paura a dirlo al babbo perché me lo aveva comprato lui e ci teneva alle cose che mi regalava infatti quando lo vide rotto mi dette tanti ceffoni e io piansi tutta la notte e avevo paura insomma dentro il mio astuccio la mia piccola pistola e gli sparai pum pum come si faceva da piccoli che si giocava alla guerra e si faceva finta di morire ma non si moriva mica perché i ragazzetti mocciosetti non muoiono mica i vecchi muoiono e poi le pistole non sparavano mica sul serio e anche quei ragazzetti mocciosetti sembravano morti ma facevano apposta ed erano bravi perché sembravano morti davvero poi venne il capotreno e mi prese la pistola e mi buttò in terra e mi fece battere il capo e mi fece male e non capivo perché e poi vennero i carabinieri che erano più buoni del capotreno e non mi fecero male loro e mi portarono qui dove scrivo su questo bel tavolino con la carta che mi hanno dato degli uomini vestiti di bianco il tavolino è di legno marrone e io sto chiuso in una stanzetta da solo e ogni tanto mi portano qualcosa da mangiare anche se non sono persone gentili per niente quei signori vestiti di bianco e hanno gli occhi cattivi e io scrivo questo racconto anche per loro per vedere se li faccio sorridere un po’ perché mi piacerebbe che fossero gentili con me e venissero a farmi compagnia e lo faranno se capiscono che sono un grande scrittore in questa mia nuova cameretta dove sto bene tanto casa mia è vuota il babbo non c’è più e la mamma anche lei non c’è più e poi non mi ricorderei neanche più dove si trova casa mia insomma qui sto bene anche se non posso fare più i viaggi ma tanto sono anche un po’ stanco e mi piace stare a riposarmi qui e solo ora avete capito il mio segreto che come i grandi scrittori ho messo alla fine del racconto e ci siete cascati eh non l’avevate mica capito dov’ero scommetto di no
Questo racconto si è classificato terzo al concorso Memoracconti – Storie da ricordare (seconda edizione), organizzato da edizioni Memori, in collaborazione con Flanerí.