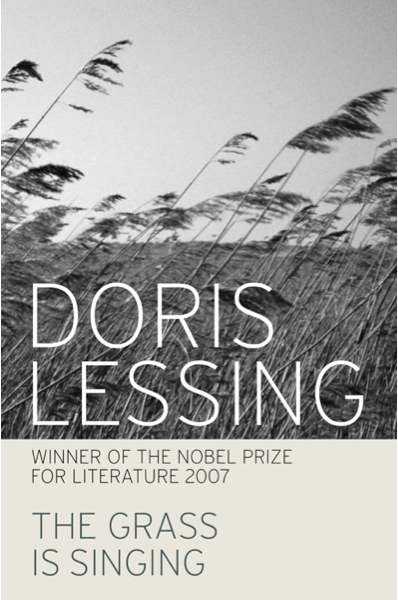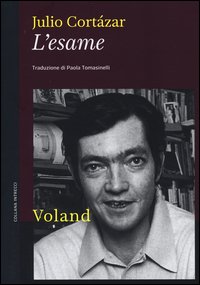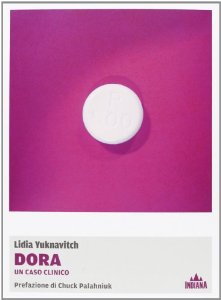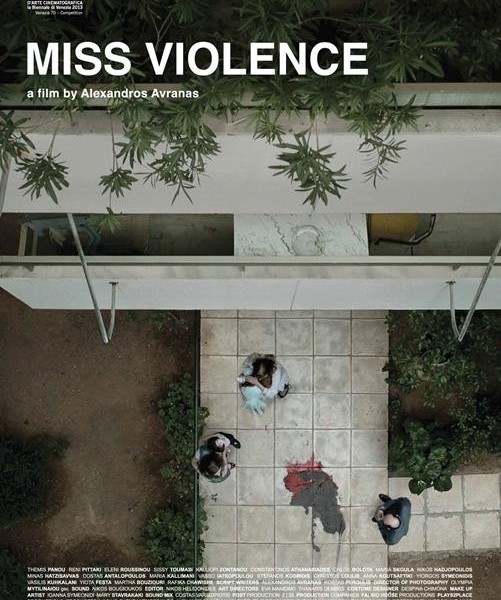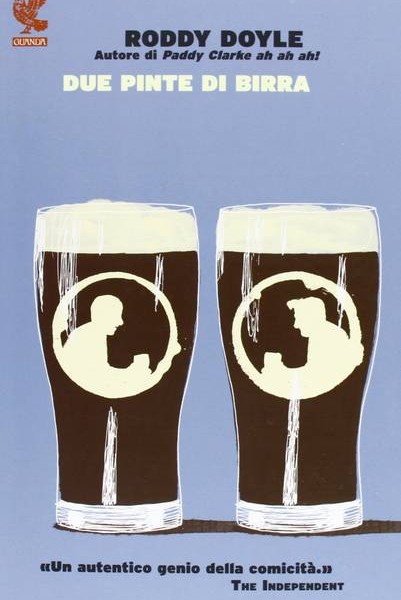V’è chi sostiene che David Byrne te lo ritrovi da troppe parti, che il suo universo musicale sia un po’ troppo esteso per essere tutto di prima qualità – Adorno ne avrebbe forse diffidato; di sicuro Byrne diffida di lui.
Ora, può essere che non tutto gli riesca al meglio (ricordiamo un concerto alcuni anni fa all’Auditorium romano in cui l’ex leader dei grandi Talking Heads riproponendone alcuni pezzi cercava di ballarli alla vecchia maniera nervosa degli esordi e il tutto suonava – è il caso di dire – un po’ forzato). In ogni caso, andrebbe rilevato che, per quanto vasti siano i suoi interessi, l’inventivo scozzese trapiantato negli Usa sa benissimo quanto e come elementi contingenti e per lo più molto materiali finiscano invece per contrassegnare e delimitare forme, modelli, stili del fatto musicale. E che trovare nel pop degli ultimi trent’anni (etichetta a sua volta, va da sé, tanto orientativa quanto limitante in casi come questo) un artista altrettanto capace di tenere insieme talento e intelligenza non è facile.
Bompiani ha appena tradotto un volume a suo nome (uscito dapprima con la benedizione di Dave Eggers, il noto scrittore americano responsabile anche della copertina). Il titolo italiano è Come funziona la musica. Byrnevi ragiona di musica in termini si sarebbe detto una volta antiromantici (ma non è affatto vero che sia un freddo), con concretezza e lucidità ignote alla nostrana cosiddetta critica rock, almeno qui da noi responsabile della prosa più stucchevole e dei contenuti più fumosi che sia dato leggere – per tacere degli italici, macchiettistici guru già improbabili come musici di oracolare ispirazione pop-rock-cantautoriale, ora anche sedicenti romanzieri…
Tutti sappiamo che il vinile suona meglio di un cd e che nell’mp3 va perduta molta della ricchezza timbrica e dinamica di un brano, o che le condizioni economiche non sono una variabile meschina del processo musicale, o ancora chetecnologia, formato, performance live o studi di registrazione, esecuzione e spazi di ricezione incidono sul linguaggio musicale – che una qualunque musica ha da fare insomma con il proprio contesto materiale (e sociale). Byrne non solo mette al bando definitivamente ogni chincaglieria idealistica ma mostra come ciò che più gli sta a cuore sia – assieme a questa consapevolezza – la libertà di aprirsi alla musica come possibilità: sperimentare direzioni, giocare con le differenze sapendo che la migliore libertà si situa «entro confini rigidi e ben definiti». Restrizioni fisiche (gli spazi della musica) e gabbie temporali (durata di un 45 giri), lungi dall’essere frustranti possono schiudere porte all’invenzione. Byrne farebbe propria la convinzione di Primo Levi secondo cui la rigida struttura formale del sonetto costituisce un’ottima via per liberare la creatività.Per parlare di tutto ciò, Byrne pesca dalla propria esperienza, cosa che dà al libro anche i tratti accattivanti di un racconto. Che incontra inizi e ascesa di una mirabile storia musicale, passando attraverso collaborazioni di altissimo livello, da Caetano Veloso a Robert Wilson (la danza, il cinema, le arti visive sono tutt’altro che tangenziali nel suo cammino di artista), da Fripp a David Sylvian a Brian Eno col quale Byrne lanciò quello strepitoso esempio di possible music dal titolo My Life in the Bush of Ghosts di cui qui si raccontano genesi e motivazioni. Dietro, l’ombra del più grande di tutti, Jon Hassell.
(David Byrne, Come funziona la musica, trad. di Andrea Silvestri, Bompiani, 2013, pp. 345, euro 28)