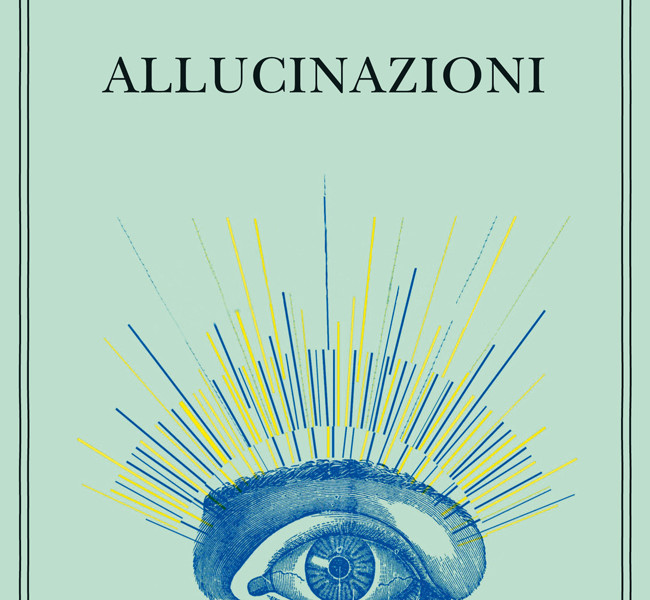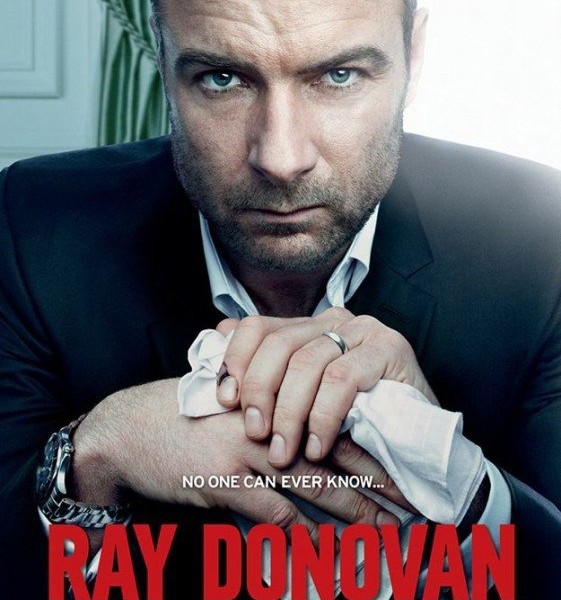Una strana presbiopia vuole che si ci accorga prima di ciò che è lontano. O forse, in questo caso, sarebbe meglio ammettere che malgrado sia padovana, avevo una conoscenza assai vaga di una realtà locale, ma molto viva anche al di fuori dalla provincia. Sto parlando dell’associazione ConAltriMezzi, un gruppo di intelligenze padovane, appunto, con una formazione nella maggior parte dei casi umanistica, che ho avuto la possibilità di conoscere lo scorso 17 agosto, durante la serata di premiazione di InciBricks, un piccolo contest letterario organizzato dalla redazione CAM in collaborazione con Scuola Twain.
All’interno della vostra webzine, offrite un ritratto dettagliato delle idee e degli obiettivi che vi proponete come associazione, riportando anche gli eventi ai quali, nei suoi primi tre anni di vita, CAM ha partecipato come promotore o ideatore. Nello specifico, mi hanno colpito positivamente le tue riflessioni sulla felice possibilità dei blog letterari di configurarsi come luoghi, sì virtuali, ma capaci di unire l’indipendenza del progetto alla pluralità di visioni della letteratura, discorsi sui libri e legami con la società che vi confluiscono. In poche parole, espressione eclettica e attiva del creare una cultura comune, favorendo un circolo di idee e narrazioni non come rilascio di informazione di consumo, ma filtrata per valorizzare i tempi vivi dei giovani.
Dopo questa bellissima introduzione, che altro aggiungere Anna? A proposito: grazie mille per queste parole e per l’opportunità che ci offri con questa intervista. Sì, rimango più o meno convinto di quello che dissi un po’ di tempo fa a proposito dei blog come opportunità e nuove creature del panorama culturale, un po’ arrembanti, un po’ brancaleoniche, un po’ inquietanti. Da questo punto di vista le sensazioni sono piuttosto contrastanti. Personalmente sul tema passo dall’euforia alla noia nel giro di qualche mese, tuttavia è innegabile una crescente popolarità di questa nuova e variegata fauna di “cavalieri senza terra” con annessa attenzione dei media, che tendono a guardarci con la pruriginosa curiosità di chi è affamato di contenuti e novità che in realtà non vogliono realmente approfondire e comprendere.
Quanto alla pluralità di visioni: ci sembra il minimo. I lettori sono sempre più polivalenti, la comunicazione sempre più transmediale e un esercito di nativi digitali è lì fuori pronto per assorbire input, informazioni, idee che condizioneranno il futuro. Credi che avrebbe ancora senso parlare di libri spalando la polvere della critica testuale, o incipriandosi il naso con le avvincenti e interessantissime dispute attorno al premio Strega?
Inoltre nel 2013 è difficile parlare di letteratura, magari quella con la L maiuscola, perché è semplicemente difficile capire cosa sia, al giorno d’oggi la letteratura. Figuriamoci quella con la L maiuscola. Invece è più interessante capire la lettura della gente, che vive esistenze sempre più precarie e quindi necessariamente eterogenee, sfuggenti e interdisciplinari. Essendo noi parte della gente non possiamo che condividere il medesimo punto di vista. Più che di eclettismo io parlerei di realismo. È fisiologico e realistico percorrere le tante strade che compie la cultura popolare, l’oggetto che più ci interessa, e le sue narrazioni. Ed è nello stesso tempo fisiologico e realistico farlo attraverso lo spazio sociale e ideativo predominante del nuovo millennio, l’unica piattaforma che potenzialmente ci può consentire tutto: il web 2.0. Detto questo un simile lavoro non potrà mai sbocciare del tutto se ci si limita alla pura esistenza/condivisione virtuale: per questo abbiamo creato l’associazione culturale, perché ci siamo accorti come fosse importante “fare cose” anziché “parlare di cose”.
Da questo punto di vista mi piace pensare a CAM come un progetto dal baricentro basso, culturalmente pop e mentalmente post. Siamo nati sotto la luce crepuscolare del nostro vate-mascotte Sergio Corazzini, poeta di inizio Novecento morto alla veneranda età di 21 anni. Quando abbiamo iniziato, la nostra più grande ambizione era quella non fare la sua stessa fine e di durare più di «Cronache Latine».
Per questo ci consideriamo già “postumi”: non siamo morti sotto i colpi dell’inedia, della malinconia e tisi. Questo per noi è già qualcosa. Ora guardiamo più avanti. Il nostro prossimo obiettivo da eguagliare non sono i TQ, defunti pure loro, o un Paolo Giordano, ma Mick Jagger, Iggy Pop, quella gente là.
Come nasce il desiderio di pensare a una produzione culturale, in un periodo storico nel quale la passione per la lettura è relegata ai margini, o declinata come intrattenimento esente da fini artistici? Quali sono stati i maggiori ostacoli sia di natura intellettuale che di ordine organizzativo nelle prime fasi di progetto?
La mancanza del know how, in primo luogo, e poi il disorientamento, comprendere che strada intraprendere, come farlo e con chi. Poi si tratta di passare del tempo, in questa sorta di palestra-limbo, per farsi le ossa e ingrossare le spalle.
Per quanto mi riguarda il desiderio nasce come amore per la sfida, la volontà di mettersi in gioco senza rimanere a guardare e credo che questo valga anche per gli altri membri della crew. Chiaro che per quanto tu possa sbatterti, e per quante soddisfazioni tu sia stato in grado di toglierti senza l’aiuto di nessuno, ci sarà sempre qualcuno che fatica a comprendere chi sei, cosa fai, cosa vuoi. Ma questo è nell’ordine naturale delle cose in un paese dove la maggior parte della gente che ricopre ruoli chiave è lì per bontà divina, o per il solo fatto di esistere. Mentre il tuo merito – oltre ai risultati che ti sei lasciato alle spalle e che devi lasciare al giudizio dei postumi – è il solo fatto di continuare a esserci. Questo per dire che la questione in realtà non è mai semplicemente anagrafico-generazionale (giovani contro i vecchi, i figli contro i padri), e nemmeno meritocratica – chi sa fare cosa meglio di chi – ma comprendere, una volta che hai cominciato a dare il massimo in quello che intendi fare, dove andare a sbattere la testa, come approdare nel tuo habitat ideale e incontrare persone che in mezzo al circo comprendono i tuoi sforzi, premiano le tue capacità e, insieme a loro, condividere prima delle esperienze e poi delle prospettive. Ecco, il difficile consiste sostanzialmente in questo: resistere mentre si tenta. E continuare a farlo, perché ho come l’impressione che poi, questa prova del fuoco che non so nemmeno chiamare per nome, non finirà mai.
Curare un progetto come CAM, credo significhi accordarsi il lusso di pensare nel lungo periodo; considerare la produzione di cultura né come un trofeo autocelebrativo, né come bisogno estemporaneo, quanto invece una costruzione che, nel restituire a sé stessi e ai lettori il proprio bagaglio di competenze e di sensibilità, arricchisce di contenuti, sfida le capacità personali e di gruppo, asseconda le possibilità della tecnica (internet).
CAM fa parte di un investimento esistenziale. Per me è stata e continua a essere un’esperienza di quotidiano esercizio fisico, psichico, intellettuale e creativo. Oltre che un divertimento, chiaro. Come gruppo abbiamo abbandonato da qualche tempo l’idea di “vivere alla giornata”, e ora ogni iniziativa si inserisce in un progetto di media-lunga gittata. Ho persino cominciato a parlare come un marketer e a usare a caso termini anglofili: il segno tangibile del non ritorno o del passaggio della linea d’ombra di Conrad.
Scherzi a parte, internet è un po’ come una giostra e fintanto che ci stai dentro sei costretto ad assimilare il suo linguaggio, le sue dinamiche, percorrendo quel binario come in un ottovolante. Percepisci la realtà alla velocità della luce, tra giri della morte e avvitamenti e alla fine devi avere lo stomaco di voler fare un altro giro, perché quello che hai colto da quello precedente non ti basta. E perché quello che hai colto dai libri che ti hanno fatto studiare, anche quello non ti può bastare. Questo significa che le opportunità si moltiplicano di giorno in giorno. Magari sono tanto interessanti quanto evanescenti ma tant’è. Comprendere e sfruttare cosa c’è di buono da questa escalation un po’ bulimica è l’aspetto più interessante delle nostre attività. Del resto la realtà si fa più fluida della società di Baumann, di conseguenza il tuo spirito si deve mantenere igneo e magmatico. E ora che nella stessa risposta ho citato due pesi massimi e pennellato due metafore evocative da un tanto al chilo, posso ritenermi soddisfatto.
Avete particolari punti di riferimento culturali, valori e modi di concepire la letteratura attinti da vostre esperienze o da realtà editoriali già esistenti? Quanto ha inciso l’esperienza universitaria come studenti di Lettere?
Per i riferimenti culturali non posso far altro che parlare a titolo personale, poiché la redazione di CAM è composta da teste pensanti di varia natura e fedina penale culturale. Personalmente credo che non potrei essere lo stesso senza Cioran, Palahniuk, Lolita, la musica punk e Twin Peaks. La fiera delle vanità dei blog e dei social network mi condiziona quotidianamente tanto quanto i film, i libri, i classici del passato e le serie tv. Invece, per quanto riguarda l’esperienza universitaria, beh, senza di quella non ci sarebbe CAM. L’università sia come entità fisica, che ci ha fatto incontrare, sia come trauma, che ci ha fatto cambiare. La Facoltà di Lettere di Padova è stata la scintilla che ha acceso la miccia. L’iter formativo di stampo umanista, i suoi vuoti, le sue lacune, il senso di voler riempire quei vuoti e quelle lacune, così come la volontà di creare qualcosa attraverso il quale prenderci quello che desideravamo. Un ruolo, una funzione, una compagine. Durante quel periodo ci siamo interfacciati con personaggi come Cesare De Michelis, presidente della Marsilio, Guido Baldassarri, che ha firmato la prefazione della nostra prima raccolta di narrativa emergente (Write not die), Andrea Molesini, prof istrionico, dal 30 facile, poi premio Campiello. Infine Emanuele Zinato, il prof con il quale abbiamo condiviso più visioni ed esperienze, nonché critico letterario attento al dibattito culturale in rete e redattore del blog Le Parole e le Cose. Questo per quanto riguarda le figure di riferimento del nostro ateneo. Poi so di membri di CAM che hanno avuto rivelazioni mistiche dopo aver seguito il corso di scrittura creativa tenuto da Roberto Ferrucci, che fortunatamente non ho frequentato. Forse da lì sono nati certi nostri “sentimenti sovversivi”. Ognuno ha il padre che si merita, prima o poi sfonderemo anche noi a Parigi.
E poi c’è Sergio Corazzini, di cui sopra, la cui rinfrancante presenza ha accompagnato i nostri primi passi. Isacco di CAM, un giorno, per rendergli omaggio, si è persino recato a Roma, al cimitero del Verano, alla ricerca della sua tomba, ma nemmeno il custode aveva mai sentito parlare dell’ex giovane poeta (true story). Ci piace pensare che le sue ossa non siano mai state tumulate nelle fosse comuni, e che lui sia ancora vivo, da qualche parte, proprio come è morto il vero Paul McCartney.
Quanta fatica si nasconde dietro la realtà della provincia? Si tratta, secondo voi, di un limite faticoso da sostenere o di una possibilità in più per sperimentare la dimensione dell’indipendenza? Trovate che sia semplice dialogare con altri progetti culturali limitrofi sia a livello di territori che di proposte?
Il brutto della provincia e che sei in provincia. Tutto il resto è da prendere e portare a casa. Perché se continui a dare il meglio delle tue possibilità, “con altri mezzi”, prima o poi chi di dovere deve fare i conti con te. Non ho nessun imbarazzo nell’ammettere che se CAM fosse nato a Roma, o a Milano, sarebbe finito per rappresentare l’ennesimo organismo pluricellulare pronto ad affollare un ecosistema autosufficiente, che di per sé è in grado di sostenere le proprie magiche isterie e ambiziose velleità. Padova da questo punto di vista è funzionale alla crescita di creature indipendenti come la nostra, malgrado il diserbante politico-culturale della classe dirigente e della collettività distratta e materialista. Hai praticamente la fortuna di avere uno spazio più o meno sgombro nel quale operare e intercettare possibili evoluzioni. In passato si sono spese molte parole sulla marginalità del Veneto e del Triveneto come «periferia culturale» d’Italia, attraversata da singole e sfavillanti firme o esperienze in realtà disinteressate o demotivate dal “fare rete”. Qualche mese fa abbiamo persino organizzato una tavola rotonda sul tema a Infrascritture – con il sociologo Stefano Allievi, lo scrittore Romolo Bugaro e Francesco Maino, fresco di premio Calvino – ma alla fine credo che il “bisogno di fare rete” sia diventato un luogo retorico stra-abusato e stantio, il sintomo di una patologia che scambia il fine con i mezzi. Alla volontà ecumenica del “stare e crescere assieme” personalmente preferisco l’evoluzione autonoma che porta necessariamente al dialogo con entità estranee, o più o meno collaterali, che possono in un secondo momento fiorire in relazioni positive. Da qui quello che dicevo prima, trovare degli interlocutori con i quali condividere delle esperienze e poi delle prospettive. La volontà di “fare rete”, sempre e comunque, mi suona come l’esigenza desaturata di chi, invece, vuole supplire la mancanza di prospettive attraverso un progetto privo di esperienze. È una questione di chimica. Non possiamo imporci delle affiliazioni in nome di chissà quale rivendicazione territoriale o sindacale. A maggior ragione noi che raggiungiamo le persone e concludiamo partnership e collaborazioni attraverso il web, a costo di doverci misurare con realtà molto lontane e diverse dalla nostra. Più che di semplici amici, nella vita, così come nelle nostre attività – sinceramente mi pesa doverlo definire “lavoro culturale”: dimostrerei automaticamente una volontà di sindacalizzare una “categoria” – abbiamo bisogno di “complici”. Rapporti umani più simili a relazioni alla Bonnie e Clyde che alla We Are the World, non so se ho reso l’idea.
Nella nostra esperienza abbiamo incrociato il cammino di molte entità e talvolta la scintilla è scattata nei contesti più improbabili, creando rapporti più fertili e duraturi di esperienze che al contrario si richiamavano ad appartenenze più stringenti ma evidentemente più di facciata.
Infine la domanda di rito: progetti futuri?
È da qualche giorno online il nuovo sito, con nuove rubriche, nuovi contenuti e nuove iniziative editoriali. In poche parole cominciamo a fare un po’ più sul serio per quanto riguarda l’area web, allo scopo di ritagliarci una nicchia come rivista online creativa, ironica e interdisciplinare. Da una parte la webzine, riveduta e riaggiornata, dall’altra le pubblicazioni digitali, vedi le raccolte di narrativa under 30 – Write not die –, di saggi e probabilmente anche di poesia.
Attraverso l’associazione continueremo a creare eventi e occasioni come Infrascritture e InciBricks, appuntamenti letterari e contest di scrittura creativa. Poi continueranno le nostre collaborazioni e partecipazioni con festival letterari più grossi. Inoltre, per il prossimo anno, abbiamo in cantiere una rassegna abbastanza particolare e ambiziosa che vorrebbe conciliare letteratura, arte digitale e il Grande Fratello. Quello di Orwell, naturalmente. Ma è ancora troppo presto per parlarne. Infine il progetto con il carcere di Padova: un’iniziativa molto appassionante e complessa. Quest’estate abbiamo inaugurato una serie di incontri e laboratori di scrittura con i detenuti del ramo protetti. L’intenzione è quella di creare una pubblicazione atipica, che si avvale delle tecnologie digitali ma non solo. Dopodiché ogni mese riceviamo richieste di collaborazione e inviti a partecipare a questo o a quel festival e la cosa ci fa estremamente piacere. Con CAM non c’è mai il rischio di annoiarsi.

Qui maggiori informazioni su CAM.