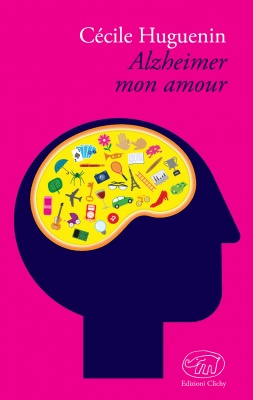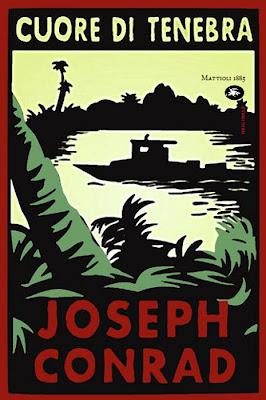Peter Maynard è un killer solitario che uccide la gente per soldi. Ma per uccidere, ha bisogno di una motivazione. Una motivazione che giustifichi il suo atto, rendendolo meno odioso per sé, per la sua coscienza. Un killer spietato e preciso, ma con una propria morale. Maynard deve sapere “perché” uccide, chi è l’uomo e quale il suo peccato. Non si accontenta di portare a termine nessun lavoro, seppur ben pagato, senza una valida ragione. E quando quella ragione arriva, senza fretta, allora e solo allora è pronto a elargire la sua, personale, estrema unzione.
Requiem per D. Chisciotte, è il secondo volume di una trilogia del crimine (La mano destra del diavolo, Requiem per D. Chisciotte e Mulher e Arma), scritta da Dinis Machado negli anni Sessanta in Portogallo, durante la dittatura di Alcazar. A causa dell’inesorabile censura in atto in quegli anni, lo scrittore si vide costretto a pubblicare l’opera con lo pseudonimo di Dennis McShade, e ad ambientare l’intera vicenda negli Stati Uniti, affinché fosse lontano il sospetto che il paese corrotto e spregiudicato di cui si parla potesse essere il Portogallo.
Un paese senza luce, dove le tenebre sembrano ricoprire tutto, e le poche ore del giorno sono intrise da una fitta pioggia carica di vapori densi e ciechi. Loschi figuri in impermeabile e borsalino si aggirano indisturbati, tessendo una guerra sotterranea tra oscure lotte di potere politico ed economico. La legalità, la morale, la comunanza, non appartengono a questo mondo: ciascuno è implacabile carnefice e, allo stesso tempo, vittima di un sistema ignoto, da cui è manovrato come una pedina in una scacchiera. In questa spettrale Gotham City, si muove Peter Maynard, ingaggiato dal Sindacato per far fuori un potente magnate della finanza.
Tuttavia, Maynard non si accontenta di uccidere qualcuno senza “conoscere” prima la sua vittima: quale sia la sua storia, quale la sua coscienza. Vuole sapere il “perché”, la conseguenza dei pensieri e delle azioni che hanno portato quell’uomo a collocarsi in una posizione scomoda rispetto a chi, con apparente liceità, è garante di un ordine: il Sindacato. I diritti di quale categoria, esattamente, il Sindacato, difenda, non viene mai detto, generando un forte senso d’inquietudine e di sinistro in chi legge la storia. Lo stesso Maynard, che è di fatto un killer, non sembra per niente edificato dall’allure del proprio datore di lavoro: al contrario lo repelle, e sebbene sia governato da un animo anarchico e poco incline al comando, non riesce che a essere soggiogato dal fosco potere che il Sindacato esercita. A nulla vale rifugiarsi nell’ascolto dei Dvorak, dei Cajkovskij, o dei Sibelius, o leggere Cervantes e Kafka; a nulla serve ingurgitare litri di latte nel tentativo di placare quel bruciore dato dall’ulcera, che è bruciore più intimo, bruciore dell’anima, di una coscienza che fatica a placarsi. Maynard è un assassino, al soldo di gente senza scrupoli. Questa è la sola verità.
Requiem per D. Chisciotte è un romanzo nero: con precisione chirurgica segue gli stilemi del perfetto noir, dalle atmosfere torbide e dei suoi angeli caduti senza via di ritorno. L’azione si apre in medias res, con un serrato dialogo tra il protagonista e Johnny, amico/mentore che fa da intermediario tra Maynard e il Sindacato. Senza dare il tempo di pensare, di capire il contesto e la materia, McShade catapulta il lettore in una semivuota e fumosa sala cinematografica degli anni Quaranta, ad assistere alle avventure di un Humprey Bogart stanco e un po’ invecchiato, fine pensatore sarcastico e romantico, poco incline al compromesso e al comando, ma che come tutti gli antieroi sa di dover pagare quel briciolo di ribellionea un prezzo ben più caro della sua stessa vita.
(Dennis McShade, Requiem per D. Chisciotte, trad. di Guia Boni, Voland, 2013, pp. 143, euro 13)