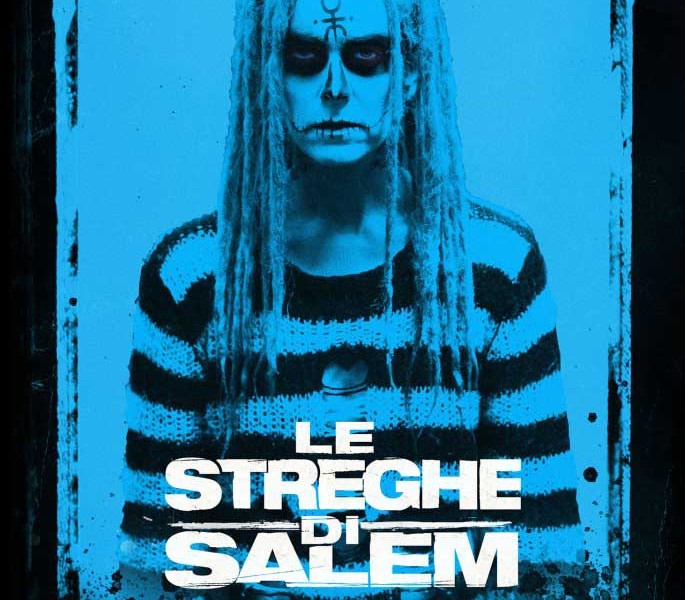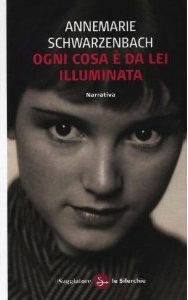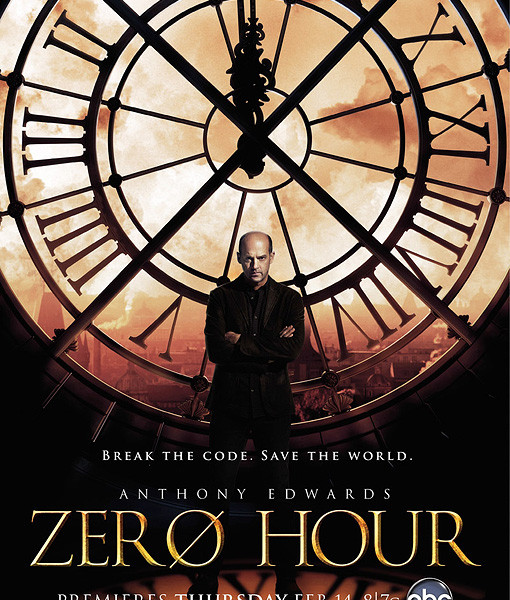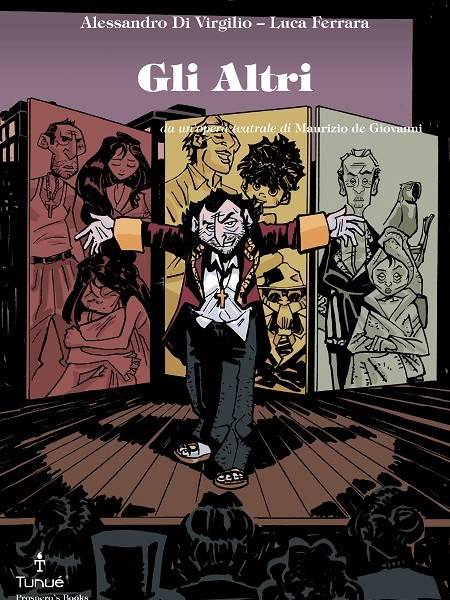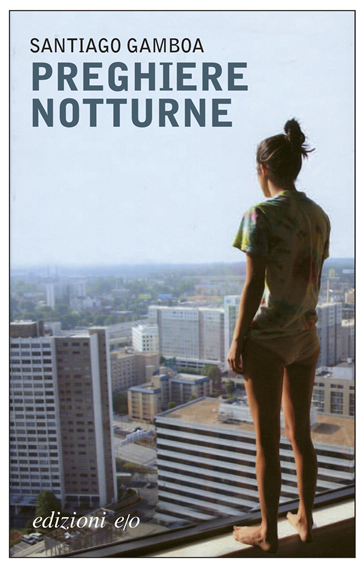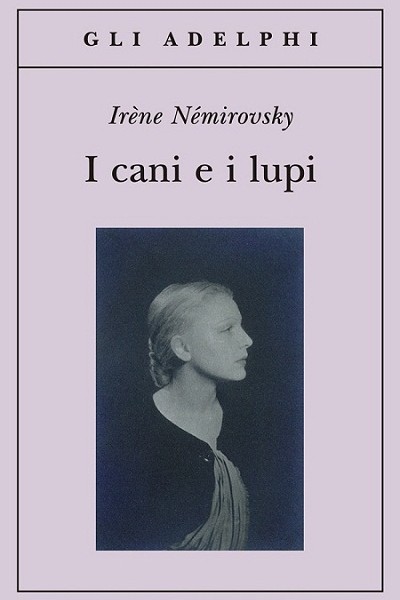«È assolutamente necessario», aveva biascicato Marco ingoiando l’ultimo boccone, mentre i resti di carbonara seccavano sul fondo della pentola. Faceva schifo, la carbonara. L’aveva cucinata Elena, mettendo la pancetta calda direttamente nell’uovo, mentre aspettavano che arrivasse Cane e che l’acqua bollisse. Sembrava un’omelette, la carbonara. Dopo averla finita Marco aveva detto che era assolutamente necessario, che dovevano percorrere in macchina il perimetro del paese e tornare a casa con mille maglie rosse, provenienti da ogni regione. Elena e Cane lo avevano guardato, in silenzio. «Garibaldi era un brav’uomo, aveva aggiunto lui», spostando lo sguardo dall’uno all’altra. Si era versato altro vino. «E poi?» aveva chiesto Cane. «E poi cosa?» «E poi con tutte quelle maglie rosse cosa ci facciamo?» «Una bandiera». «Una bandiera?» «Una bandiera rossa che sventoleremo giù verso la città dal tetto della Torre Velasca». «E perché mai?» «Perché fa cinema», aveva risposto Marco, le sopracciglia aggrottate per un attimo, poi subito distese. Aveva pronunciato il «fa» calcando la effe, alzando la voce. Come se fosse il «fa», la cosa importante, e non il cinema. Elena era rimasta zitta, disegnando dei cuori con gli spaghetti avanzati. Li allineava uno per uno lungo il bordo del piatto, con la parte panciuta rivolta verso l’esterno. Pensava fosse una pessima idea, andare a chiedere maglie rosse in giro per l’Italia. Pensava fosse una pessima idea anche salire sulla Torre Velasca.
Erano partiti due giorni dopo. Cane aveva una vecchia Polo con il muso quadrato e la vernice scrostata all’altezza dei fanali. L’impianto stereo era l’unica cosa che avesse meno di quindici anni, il display lucido brillava incastonato nel cruscotto. «Sabato la porto dallo sfasciacarrozze», ripeteva ogni settimana suo padre. La osservava dalla finestra della cucina facendo colazione. Poi apriva il giornale che la moglie gli lasciava sul tavolo accanto al caffè e scuoteva la testa, ogni tanto sbuffava, si dimenticava dello sfasciacarrozze. Marco aveva aspettato Cane accanto alla macchina, seduto sul marciapiede. «Ma la sessione?», aveva urlato la madre di Elena dal pianerottolo. «La sessione boh». Uscendo in strada Elena si era fatta due erogazioni di Ventolin e aveva lanciato lo zaino sui sedili posteriori. Erano le quattro di pomeriggio del quindici di maggio.
A Torino si erano persi tre volte perché sembrava tutto quadrato, alla fine Cane aveva chiamato Tancredi. «Qui non si capisce un cazzo di niente», gli aveva detto. Tancredi era di Bologna, studiava filosofia a Torino e scriveva per una rivista letteraria di cui era redattore, direttore e ufficio stampa e che finanziava con lo stipendio del turno pomeridiano in una lavanderia dietro la stazione. Stava con una ragazza bionda, Clara, che faceva dei disegni carini con cui abbellivano il sommario della rivista. Ogni tanto la ragazza bionda si occupava anche della copertina e delle illustrazioni per i racconti. Tancredi, quando gli avevano raccontato la storia delle maglie rosse, aveva cominciato a ridacchiare. Ridacchiava tenendo le mani in tasca e piegando le ginocchia. «Geniale, geniale», continuava a ripetere. Aveva telefonato a un amico che faceva le gare con i fuoristrada, ad alcuni compagni di facoltà e alle amiche di Clara. Tancredi aveva detto a tutti di portare una maglietta rossa che non usavano più. Erano andati a mangiare un kebab dietro la stazione e vicino alla lavanderia. Per l’esattezza dalla stazione si girava a sinistra, poi a destra, poi a sinistra, poi ancora a destra. La donna che li aveva serviti poteva avere quaranta o cinquant’anni, Marco pensava cinquanta, per via delle rughe, che erano molte. «Scusi posso chiederle di regalarmi il suo golf?» le aveva chiesto. La donna gli aveva passato degli involtini fritti ripieni di verdure, senza rispondere. Era la prima sera: Marco, Elena e Cane avevano ricevuto tredici magliette. Elena aveva anche baciato più volte uno studente di lettere che le aveva offerto una birra.
La mattina seguente erano andati in Liguria. «La facciamo tutta in un giorno», si erano ripetuti salendo in macchina. Lo avevano detto almeno una volta ciascuno, sembrava fosse della massima importanza, non restare in Liguria più di ventiquattro ore. Avevano percorso l’Aurelia fermandosi a ogni paese, scendevano dalla macchina e spiegavano ai passanti quello che stavano facendo. Lo spiegavano confusamente. Ripetevano «governo», «azione», «coscienza», «opposizione», spesso nella stessa frase. Faticavano a dare un senso alle loro parole. La maggior parte delle donne si allontanava prima che aprissero bocca, nascondendo la testa tra le spalle e camminando veloce, come facevano quando incontravano un venditore ambulante. I liceali invece si fermavano qualche minuto. «Buona fortuna», dicevano, magari con una pacca sulla spalla, sempre con molti sorrisi, senza dar segno di voler dire addio a un qualunque capo di vestiario. Solo alcuni uomini avevano contribuito alla causa. «Gente che ha fatto il ’77», sosteneva Marco arricciando le labbra e annuendo vistosamente. Li avevano ascoltati senza prenderli troppo sul serio, con più riso che interesse, ma si erano fatti accompagnare a casa a prendere una vecchia maglietta sformata da sventolare dalla cima della Torre Velasca.
A Noli, quinta Repubblica marinara d’Italia, erano successe due cose degne di nota. La prima: Cane aveva scommesso che sarebbe riuscito a mangiare una coppetta di gelato al cioccolato in meno di sessanta secondi. Ci era riuscito. Poi il contenuto della coppetta era stato riversato pochi passi dopo dal suo stomaco, al centro della rosa dei venti, davanti all’arco di ingresso al paese. La seconda: Elena aveva sedotto il proprietario di una bancarella di libri sul viale a mare. Si chiamava Marco, e indossava una maglietta rossa sotto una felpa nera con due strisce bianche sulle braccia. A Marco il libraio non era piaciuto, sia perché portava il suo stesso nome, sia perché non riusciva a capire che età avesse. Quando si erano allontanati aveva detto che non ci si può fidare di uno con i capelli brizzolati e la pelle di un bambino. Elena comunque aveva ottenuto la maglietta, una novella di Henry James e una copia con la copertina rigida di Frankenstein. La maglietta del libraio Marco era stato l’unico indumento che avevano portato via da Noli.
Avevano cenato a Bonassola, in un ristorante tra la scogliera e il paese. Elena aveva ordinato della focaccia al formaggio, Cane e Marco tortelli al ragù. Il loro tavolo guardava verso il mare. La sedia di Marco poggiava contro un oleandro dai fiori color rosa carico e bianco. Forse erano due oleandri vicini vicini. «Sono troppo poche», avevano detto Elena e Cane, riferendosi alle maglie rosse, «tredici in Piemonte e solo otto in Liguria». Marco non era d’accordo, pensava che fosse normale, all’inizio. Dovevano ancora rodare l’approccio con le persone, stavano sperimentando, sosteneva. E poi a Roma si sarebbero fermati quattro giorni. «Avete idea di cosa si può fare a Roma in quattro giorni?», aveva chiesto, aprendo le braccia come un sacerdote che benedice i suoi fedeli. Poi una foglia di oleandro gli era caduta nel piatto. Marco lo aveva allontanato, spingendolo con l’indice verso il centro del tavolo. «Io basta», aveva detto, e si era allontanato. Cane aveva pagato il conto per tutti.
Nessuno era riuscito a dormire quella notte. Erano rimasti in un parcheggio la cui funzione originaria doveva essere quella di campo da calcio. C’erano altre due macchine, oltre alla loro. Una Lancia Y nera e un Suv verde militare, con un adesivo giallo incollato sulla portiera di sinistra: Mad for mud. Elena si era stesa lungo il sedile posteriore, le gambe ripiegate contro il petto in posizione fetale. Ogni volta che chiudeva gli occhi sentiva Marco russare. Russava forte, come se ogni respiro fosse l’ultimo disperato sforzo del suo naso. Allora Elena si sollevava e lo strattonava prendendolo per una spalla. Marco si svegliava, poi richiudeva gli occhi e cominciava di nuovo, Elena lo risvegliava. Il sedile di Cane, al posto del guidatore, era bloccato. Avevano provato a reclinarlo in tre. Alla fine Cane era rimasto con il volante tra le ginocchia, a guardare la rete metallica che separava il campo da calcio dalla strada. Non passava nessuno.
All’alba Cane si era stufato di guardare la rete metallica e aveva messo in moto. Erano arrivati a Pietrasanta durante il più grande black-out del paese. Le campane del Duomo non avevano suonato alle otto, non avevano suonato alle nove, e neanche alle dieci, alle undici e alle dodici. La metà dei negozi era chiusa, con le nuove, innovative, saracinesche elettriche irrimediabilmente abbassate. Mentre facevano colazione in un bar nella piazza centrale, Cavallo li aveva osservati dall’esterno del perimetro dei tavoli. Guardava la cioccolata calda di Elena con degli occhi che sembravano lì lì per schizzare fuori dalle orbite e fare plof dentro la tazza. La cioccolata non era fatta in casa. Era della marca Ciobar, Elena l’aveva riconosciuta perché era la stessa che le preparava sua madre quando era piccola. Comunque era buona. Anche Cavallo aveva una madre, chiamata Tosca perché urlava tutto il giorno. A volte cantava. Cavallo prevedeva il tempo, riusciva a captare l’arrivo di un temporale con mezza giornata di anticipo. In quei casi si metteva a correre per le strade nitrendo e sbattendo le mani sulle cosce. Le mani contro le cosce facevano il rumore degli zoccoli di un cavallo al galoppo. Queste cose le aveva raccontate un vecchio signore seduto al tavolo accanto. Beveva un caffè macchiato e mangiava una brioche alla crema, era sporco di zucchero a velo sul mento e agli angoli della bocca. Aveva raccontato anche che lì ci andava a fare la colazione Botero. Elena e Cane non avevano idea di chi fosse, Botero. Marco sì. «Uau!», aveva esclamato Marco, ma non sembrava particolarmente interessato.
A Pietrasanta erano riusciti a prendere diciotto magliette e due felpe. Avevano girato tutto il paese e le località limitrofe, dall’Africa al Pollino. Marco teneva banco in ogni bar. Ripeteva le stesse cose che aveva detto in Liguria. Ripeteva «governo», «azione», «coscienza», «opposizione». Questa volta lo faceva a voce alta, guardando un punto vuoto, fisso davanti a sé, quasi consapevole di ciò che sosteneva. Il ristorante dove avevano deciso di mangiare, alle tredici e trenta, era occupato da un pranzo di laurea. «Quarantuno», aveva detto affranto Marco alla laureata. Si sentiva molto solo, quell’uno, e lei era vestita tutta di rosso perché portava fortuna. Avrebbe dovuto lasciare il suo golfino a loro. Doveva aiutarli a raggiungere il quarantadue. «A nessuno piacciono i numeri dispari», le aveva spiegato Marco. La laureata non aveva voluto cedere il golf. Il gestore del ristorante, un ometto basso e per niente simpatico, li aveva fatti uscire. Uno dopo l’altro, che la porta era stretta. Dopo le diciotto magliette e due felpe erano andati al mare. Faceva freddo ed Elena aveva disegnato con l’alluce la sagoma dell’Italia sulla sabbia. Poi aveva cercato di tracciare all’interno i confini delle regioni. Come una cartina politica. Si era dimenticata il Molise e la Basilicata. Marco e Cane avevano parlato di una ragazza dell’università che aveva il naso alla francese e un seno enorme. Aveva anche le lentiggini, la ragazza dell’università, e questo le faceva acquistare molti punti.
La sera le campane del Duomo continuavano a essere mute. I negozi erano tutti chiusi, e anche i ristoranti erano tutti chiusi. La rocca non aveva fari ad illuminarla, sprofondava nella collina. Le uniche luci visibili erano i puntini luminosi dei paesi sparsi sulle Apuane. Cane aveva spiegato a Elena che l’alone che vedeva attorno a ogni punto luminoso era effetto dell’astigmatismo. Altrimenti li avrebbe visti perfettamente definiti. «È la stessa cosa che succede con le stelle», le aveva detto, «con i lampioni no, perché sono troppo vicini». In piazza, la stessa piazza del Duomo e del bar di Botero, un gruppo di artisti di strada stava allestendo uno spettacolo. Erano illuminati da cinque candele di quelle con il fondo di terracotta, grandi e gialle, alla citronella. A guardarli non c’era nessuno a parte una famiglia di turisti biondi e nordici, forse tedeschi. Elena, Marco e Cane avevano assistito agli ultimi minuti dello spettacolo, una storia complicatissima che, infatti, non avevano capito. In ogni caso la storia finiva bene, i due con i trampoli si abbracciavano e quello con il cappello da giullare faceva delle smorfie incrociando le braccia. Cane era andato a parlarci. Dopo poco gli aveva dato cinque euro, e loro in cambio una tunica senza maniche ricoperta di paillettes rosse. Era la ventunesima maglia di Pietrasanta.
Elena, Marco e Cane si erano messi a passeggiare, malgrado fosse tutto molto buio. Cane teneva la tunica di paillettes appoggiata alla spalla destra. Sotto a un centauro di bronzo con la testa tagliata all’altezza della fronte Marco aveva preso la tunica. Ci aveva giocherellato per un po’. La passava da una mano all’altra, palleggiando con se stesso. «Forse non ha molto senso», aveva detto. Elena e Cane lo avevano guardato, in silenzio. «Poi a nessuno frega un cazzo, di Garibaldi». Elena e Cane questa volta si erano guardati tra di loro. Si erano guardati come due persone incredibilmente tristi. Avrebbero voluto guardarsi come due persone incredibilmente esasperate, però gli occhi si erano sbagliati. «Torniamo a casa», Marco si era allontanato dal centauro, camminando verso la piazza con la tunica stretta in mano che ogni tanto strisciava per terra. Elena pensava che fosse una pessima idea, tornare a Milano.