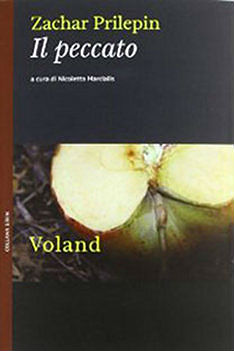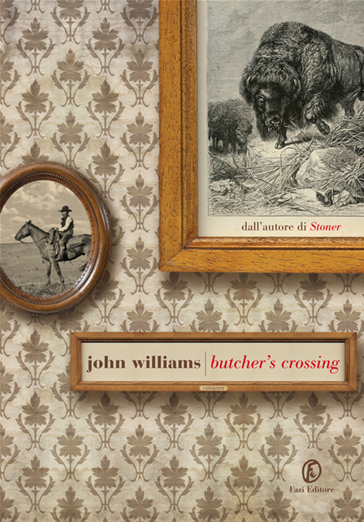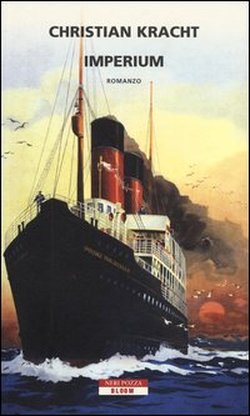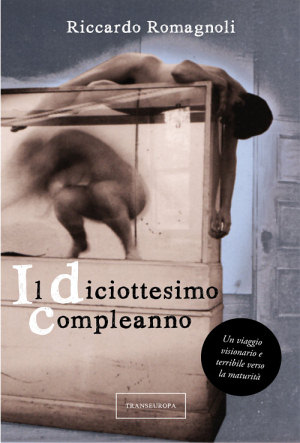Il diciottesimo compleanno (Transeuropa, 2012) è il romanzo d’esordio di Riccardo Romagnoli. Attraverso una scrittura visionaria e terribile, l’autore racconta la vita, breve, di un adolescente «famelico», in una Roma sospesa nel tempo. Una straziante allegoria dell’esistenza, un tentativo di stracciare quel “velo” che tiene imprigionato l’individuo nel ciclo continuo della vita e della morte.
Il diciottesimo compleanno racconta la storia di Matteo, adolescente disperatamente assetato di vita che ripercorre la sua esistenza di «animale famelico» [come lo ha definito Giorgio Vasta, ndr], dalla nascita al suo diciottesimo compleanno. Una specie di catabasi moderna senza possibilità di risalita. La domanda consueta è più che mai necessaria in questo caso: da dove trae origine una storia così viva e pulsante, inquietante per larghi tratti?
Matteo vuole sperimentare ogni aspetto della vita, consapevole come lui è che la vita è nel suo consumo “famelico” e ingordo. Matteo sono io? È qualcun altro? Chi è?
Il romanzo nasce dal dolore e dalla sofferenza del vivere. La scrittura (la mia) è l’unico modo che ho per dipanare i nodi e gli intrecci che le esperienze hanno generato in me. Nello stesso tempo la scrittura si arroga il diritto di essere strumento di conoscenza, da affiancarsi alla riflessione filosofica, teologica, sociologica, politica, storica.
Il mio Matteo è della stirpe di Törless, di Von Aschenbach, di Marcel, di Ferdinand, di Castorp e di molti altri, di personaggi che, vivendo la loro vita “finta”, pretendono di svelare cos’è la vita “vera.”
Al di là e al di sotto di una glassa con cui si vuole ricoprire la vita e il nostro mondo, Il 18esimo nasce dalla rabbia e dalla mancanza di consolazione, dall’amore e dall’odio, dalla fiducia e dalla paura.
Il protagonista attende la maggiore età come un’apocalisse inesorabile e senza ritorno. In realtà l’apocalisse vera e propria, intesa come rivelazione, è costituita dalla narrazione stessa: attraverso immagini oniriche, allucinazioni ed epifanie descrivi una sorta di iniziazione di Matteo alla vita prima, e alla morte poi. Quale significato cela questa enorme allegoria della realtà?
Mi è capitato di sentir parlare del 18esimo descrivendolo come una discesa agli inferi o come un viaggio iniziatico. Il 18esimo, in realtà, non prevede un’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte di Matteo. Matteo, per usare un’espressione che mi diverte e che mi piace, “nasce imparato”, sa fin dal momento in cui viene partorito, e la sua sapienza ha le stesse carattersitiche “magiche” che vengono descritte a proposito di Siddharta e del suo venire al mondo già adulto.
Tutto il romanzo ha una forte venatura antinaturalistica. Qualcuno mi ha chiesto: ma come fa un ragazzo di 15 anni a leggere una mole così smisurata di libri? Come fa ad avere un numero così alto di incontri sessuali? Come fa a masturbarsi così tante volte? Come fa ad avere una consapevolezza così profonda? Io rispondo con una frase che Matteo dice nel capitolo degli 8 anni: «Stabilivo così la misura del mio tempo, in cui avrei vissuto ogni secondo come fosse un mese altrui, accumulando esperienze».
Matteo sa da sempre che i suoi sogni e la libertà del suo diventare maggiorenne sono apparenze e inganni. Lo sa lui e lo sanno i suoi amici che vivono in una specie di eterno presente in cui la vita e la morte sono unite e inscindibili.
Il romanzo (e questo è uno dei suoi significati, o almeno quello che io ho avuto dentro di me scrivendo perché, poi, è noto che le opere siano sempre molto di più di quanto i loro autori consapevolmente ci pongono) vuole rivelare la sostanza dolorosa del vivere. Non a caso, Ivan (nel capitolo dei 15 anni) termina se stesso terminando la lettura del “Cantico del gallo silvestre” di Leopardi. Il male di vivere è nelle righe del 18esimo, un male incontrovertibile e ineliminabile. Nietzsche ne La nascita della tragedia racconta il mito di Mida e del Sileno. Quando Mida cattura il Sileno e gli chiede qual è la cosa migliore per l’uomo. Sileno risponde: «La cosa migliore è per te totalmente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente».
Tale è la natura paradossale del vivere che ho cercato di rendere nelle esperienze di Matteo, della sua famiglia e dei suoi amiciamanti. L’uomo nasce, senza che l’abbia voluto o chiesto. L’uomo vuole vivere, perché oltre la vita non sa cosa ci sia e cosa egli sia, in quanto lui è vivo e solo sa di ciò che è. Neppure la morte (benché voluta e programmata) può arrestare il terribile rovello in cui si dibatte l’uomo.
Così come (io ritengo) è traumatica all’ennesima potenza la vita pur nella sua negazione, così ho voluto rendere traumatica la vita di Matteo e ho voluto trasmettere tali traumi al lettore, prima ignaro e poi, dopo aver scorso le pagine del romanzo, forse inorridito ma (spero) più vicino al fondo oscuro dell’essere la cui comprensione, comunque, non fornisce lenimento o liberazione (quasi che una razionalizzazione del rimosso, seguendo Freud, possa annullare il potere e il dominio del rimosso.)
Il 18esimo, quindi, è un violento rifiuto di ogni consolatoria visione della vita e, nello stesso tempo, vuole negare ogni possibile fuoriuscita da tale vita. L’esito finale del romanzo, l’apocalittica festa con cui il libro si apre e si chiude, non risolve niente. Il tempo è quello circolare, per cui, appena la storia è terminata può ricominciare perfettamente uguale alla precedente. L’incubo non si conclude mai, inizia sempre.
Uno degli aspetti più caratteristici del romanzo è la commistione di generi e di modelli, con un trionfo finale su tutti della tragedia classicamente intesa – non credo siano casuali i riferimenti a Tieste, Edipo e Medea. Solo un’impressione o c’è del vero?
Il capitolo dei 15 anni è una grande, onnivora, tentacolare genealogia letteraria. Ci sono i libri che generano libri come se fossero (i libri) padri e madri che partoriscono. E non a caso questo capitolo precede il capitolo dei 16 anni dove le genealogie sembrano interessare gli incontri e le relazioni, con uomini e donne che vivono in parti vicine o lontane di mondo.
C’è una specularità, che è presente nell’intero romanzo, tra libri, persone e vita. Nei ricordi di Matteo la prima sua eiaculazione autoerotica è connessa all’Iliade.
La tragedia e l’epica segnano le vicende di Matteo e fanno da controcanto alla narrazione, dispiegandola entro le coordinate di gesta che non sono tanto e solo di Matteo Solmi, ma che aspirano a una universalità essenziale.
Matteo sono io, vorrei che dicesse il lettore del 18esimo. Luisa sono io. Leo sono io. Anna sono io. Luciano sono io.
E vorrei anche che dicesse: Matteo, Luisa, Anna, Leo, Luciano sei tu, è luilei, siamo noi, siete voi, sono loro.
Proiettare il singolare sull’universale credo che serva anche a stemperare la ferocia delle gesta narrate, proprio perché non riferibile alla responsabilità di un individuo ma collocabile in quel fondo oscuro e irrazionale che è il nucleo pauroso della vita.
L’impressione, quindi, di cui mi parli a proposito dell’epos e del tragos, è perfettamente plausibile, e voluta da me in quanto autore. Anzi, direi andando oltre, solo la cornice epico-tragica rende “sopportabile” il mio romanzo.
Roma è la città in cui si svolge la storia di Matteo, il suo graduale appropriarsi della vita. Un luogo a tratti infernale, che ricorda la Babele veterotestamentaria, capace di offrire al protagonista numerose vie di accesso verso l’altro, l’ignoto, la morte. Perché questa scelta e che legame hai con questa città?
Roma è stata la prima città che ho visitato (dopo Firenze mio luogo natale). Avevo circa otto anni e ricordo, di Roma, la gioia del viaggio, e l’insonnia della notte precedente, poi l’ascensore dell’hotel e lo zoo. Da quel primo viaggio, però, Roma è rimasta la Città, e non per niente ci sono tornato quando avevo 23 anni e sono partito per fare il servizio civile (allora, eravamo nel 1978, il servizio civile durava 20 mesi. Io scelsi di farlo presso l’Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare di Roma).
Roma, quindi, ha rappresentato, per me, la libertà e l’indipendenza, l’età adulta, l’uscita dal nido familiare, l’incontro col mondo del lavoro.
Spesso, quando ero libero, di giorno, mi dedicavo a scoprire musei e chiese, palazzi e quartieri. Di notte, vagavo in lunghe passeggiate solitarie che andavano dalla Stazione Termini fino a Piazza San Pietro, perso nei miei pensieri e nei miei sogni.
Amavo, e amo, i numerosi ponti che a Roma attraversano il Tevere. Mi piaceva fermarmi a metà, guardando a lungo la corrente del fiume che andava.
Ci fu un periodo, anche, in cui avevo deciso di costruirmi un cartellone doppio a sandwich e di andare per le vie della città a distribuire dei volantini che invitavano a una qualche laica conversione per creare una nuova comunità di vita e di conoscenza. Ero un po’ matto, lo riconosco, in questa spinta millenaristica che raccoglieva intorno a me altrettanti folli e disadattati.
Roma, la Città. Da allora, cioè dai miei otto anni, ho viaggiato molto, in Europa e nel mondo. Ho conosciuto tante metropoli, da Parigi e Londra a New York e San Francisco, da Shangai e Bombay a Sidney e Buenos Aires. Ho trovato città magnifiche, in alcune di queste ci vorrei vivere a lungo. Ma non ho mai, e dico mai, trovato una città che, ai miei occhi, fosse tanto ricca come Roma. Parlo di ricchezza artistica e di ricchezza storica e culturale e di ricchezza umana. A volte una sola chiesa romana è più magnifica e piena di tesori e di emozioni di un’intera Amsterdam!
La storia di Matteo non poteva che svolgersi a Roma, la Città. E, almeno nelle mie intenzioni, Il 18esimo vuole essere una celebrazione di Roma, un invito ad andarci, una baedeker da seguire per scoprirne o riscoprirne le immani magnificenze.
Non direi una Roma infernale, direi piuttosto una Roma dove monumenti e opere d’arte stimolano a uscire da noi stessi e a vivere a piene mani, per tentare di cogliere e di creare, nella propria esistenza, lo stesso sublime che la città contiene e che millenni di sovrapposizioni storiche hanno depositato qua e là.
Se, nel 18esimo, il tempo è il tempo astratto in quanto del singolo individuo e non contestualizzato storicamente, lo spazio, invece, è lo spazio concreto delimitato in nomi luoghi situazioni.
La atemporalità (che non significa assenza di sviluppo narrativo) è caratteristica del 18esimo. Se si domandasse in quali anni il romanzo è ambientato ci sarebbero notevoli difficoltà a fornire una risposta univoca. Non vengono citati fatti o situazioni caratterizzanti. Ciò in relazione al mio tentativo di inscrivere le vicende di Matteo nel quadro del raccontare epico-tragico.
Ma la relazione con lo spazio – con l’estensione della materia in forme, dimensioni, strutture, la topografia e la toponomostica di Roma – queste sono analizzate con la cura di un entomologo e di un anatomista. Mi piace (per i luoghi) l’accuratezza verista alla Zola. Vorrei, come dicevo poco sopra, che il mio romanzo potesse servire come guida turistica di Roma, della Roma che ha attraversato Matteo (i grandi antichi acquedotti, il Colosseo, piazza Vittorio, il quartiere Salario, il planetario e Santa Maria degli Angeli, San Pietro, le spiagge di Ostia, ecc.).
Terminando con una battuta, sarei felice che il mio romanzo facesse venire voglia di andare a Roma, sia a coloro che già la conoscono, sia a coloro che ancora non ci sono stati! A questo punto credo che avrei diritto a un vitalizio da parte dell’amministrazione comunale di Roma! Ahahahhahah…
L’intervista continua qui.