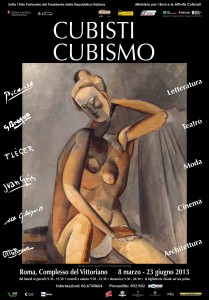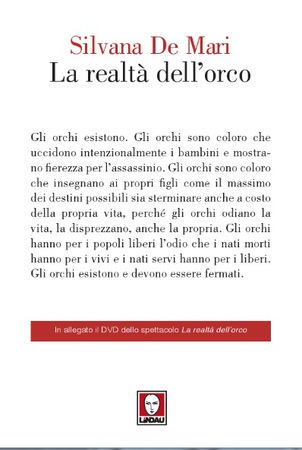La realtà dell’orco è un saggio di Silvana De Mari, scrittrice di romanzi fantasy (tra cui L’ultima profezia del mondo degli uomini, di cui vi avevamo parlato qui), pubblicato da Lindau, casa editrice torinese, lo scorso ottobre. Esso intende mostrare quanto sia reale la figura dell’orco, analizzando le fiabe tradizionali e i più conosciuti romanzi fantasy: infatti, fuor di metafora, l’orco corrisponde, nella lettura della De Mari, alle declinazioni concrete di un principio, quasi sostanza originaria che, nel solco del più genuino dualismo platonico, siamo soliti contrapporre al bene, e che genericamente definiamo il male.
Il libro non sopporta i vincoli del saggio tradizionale: «Se non sapete che cos’è la Vandea, magari avete fatto le scuole all’epoca del sei politico o con un professore che le aveva fatte lui all’epoca del sei politico; in ogni caso c’è Wikipedia, che è senz’altro pensiero unico ma è veloce ed è meglio di niente, e io mi risparmio le note che sono una cosa che odio»; si presenta infatti non tanto come un saggio vero e proprio, quanto come una riflessione dell’autrice su temi a lei cari, in un rapporto che non intimidisce il lettore, ma anzi, intende avvicinarlo con un linguaggio colloquiale, caratterizzato da ripetizioni a volte insistite, dall’uso oratorio della punteggiatura, dall’immediatezza propria di una chiacchierata tra amici. Il libro ha, in definitiva, una forte aspirazione divulgativa.
In apertura leggiamo una famosa epigrafe di George Orwell: «Nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario»; si tratta di un’idea a cui la De Mari è molto legata. Il libro sostiene, fin dal primo capitolo, di essere depositario di una verità trascurata dai più, di voler, insomma, dare un’idea di come stanno veramente le cose in questa porzione di universo; «Tutto quello che sull’Illuminismo non avete mai letto»: questa la promessa che apre il primo capitolo, dove l’autrice traccia una storia alternativa rispetto a quella solitamente presentata dai libri scolastici: «l’Illuminismo contiene lo splendore, ma anche l’orrore. Impariamo a vedere entrambi»; «l’Illuminismo ha inaugurato la fase “razionale” e “scientifica” del razzismo»; «l’Illuminismo è stato anche la Dichiarazione dei diritti dell’Uomo […], che è stata scritta da persone che erano laiche, certo, ma che contiene i valori del cristianesimo».
Dietro alle figure fiabesche della strega, dell’orco, dello stregone, si ritrovano travasate le paure non solo del bambino, ma anche degli adulti; l’autrice mette infatti in evidenza come molte fiabe, antecedenti del romanzo fantasy, insieme al poema epico, trattino argomenti assai delicati e scottanti per il mondo degli adulti: in Pelle d’asino si ritrovano l’abuso sessuale, la pedofilia e l’incesto; in Hansel e Gretel e in Pollicino il cannibalismo; in Biancaneve il dramma di un bambino ucciso dalla madre e la figura del «perdente radicale», individuata nella regina, che, avendo un io sofferente, deve ricostruire la sua coerenza interna, imponendosi sugli altri, ma, pur di vincere, arriva a distruggere gli altri e se stessa («Adolf Hitler è un perdente radicale. Il terrorista suicida è un perdente radicale»); in Cenerentola, fiaba nata in Cina, il dramma dei piedi storpiati; in I vestiti nuovi dell’imperatore il consenso vile a un regime totalitaristico.
Tuttavia le paure si evolvono e nei romanzi fantasy gli eroi travestiti da persone normali sono ancora degli orfani o, più modernamente, figli di genitori assenti; a questa mancanza corrisponde non più la paura della morte per inedia, del lavoro forzato, ma la paura ossessiva del fallimento e quella del rifiuto, mali genuinamente contemporanei. Come ci tiene a specificare la De Mari, per professione, medico che si occupa di psicoterapia, dal tipo di amore che i genitori nutrono nei nostri confronti, quando siamo piccoli, scaturirà il tipo di amore che proviamo verso noi stessi: condizionato, incondizionato, carente. Da questo il grado di fiducia verso di noi e il nostro futuro. Da questo la qualità dell’aria che respiriamo.
La lettura della De Mari non si ferma alle fiabe antiche e arriva agli archetipi di Frankenstein, di Dracula, di dottor Jekyll e mister Hyde, di Peter Pan («Peter Pan è l’angelo della morte. Lui e i bambini perduti sono morti. Sono morti in ospedale»), fino a toccare alcuni scrittori (Wilde, Kafka, Orwell) e approdando, finalmente, al Signore degli Anelli di Tolkien, in cui si parla di terrorismo islamico e si critica la tolleranza dell’intolleranza: «Grazie alla follia del rispetto delle civiltà altrui, civiltà gravemente disfunzionali già nei loro paesi d’origine, sono avvallati il disprezzo più totale per le donne, la loro schiavizzazione, l’omofobia più totale, l’antisemitismo più mortale. Il nostro compito è rispettare l’individuo. Le civiltà e le religioni che non rispettano l’individuo non meritano né rispetto né comprensione, altrimenti si diventa complici […]. La nostra non è una civiltà perfetta, e a una civiltà perfetta non somiglia nemmeno, ma è la civiltà che nel bene e nel male ha prodotto la Dichiarazione dei diritti dell’Uomo, e se permettiamo a tutti di sputare addosso al nostro passato, quella dichiarazione la perderemo».
Nella saga di Harry Potter, la De Mari individua diversi riferimenti più o meno diretti alla religione ebraico-cristiana: sono presenti echi del Vangelo di san Giovanni, i temi del sacrificio di sé fatto per amore degli altri, del pentimento, del libero arbitrio, l’etica della fratellanza: «Anche se la saga è cominciata prima dell’11 settembre, a mano a mano che prosegue la visione politica diviene evidente. I difensori devono battersi su due fronti, la cultura di morte che li fronteggia e alle spalle lo sterminato esercito di vili». Ma in Harry Potter è cantata, soprattutto, «la magia dell’uomo», cioè la resilienza. Usata per la prima volta dallo psicologo francese Boris Cyrulnik, la parola identifica la capacità dell’essere umano di resistere e sopravvivere, nonostante i traumi più o meno grandi, continuando ad amare la sua vita e a conservare la fiducia verso di essa, perché nessun trauma è irrisolvibile. Come si attua questo magico processo di autoguarigione? Attraverso l’antidoto della bellezza: «Cerca l’affetto di un animaletto domestico: le persone sole che hanno un micio o un cagnolino vicino a sé se la sfangano molto meglio di quelle che riempiono il silenzio solo con il televisore».
In La realtà dell’orco ogni figura dell’immaginario fiabesco, ogni romanzo fantasy fornisce una chiave di lettura del contemporaneo, costituisce il pretesto per parlare di tutt’altro, in una visione radicalmente allegorica del genere narrativo. Il libro è un percorso che, attraverso il racconto del male intessuto dalle fiabe e dai romanzi fantasy, basati sulla trasfigurazione metaforica, vuole fornirci un’interpretazione degli eventi che hanno sconvolto la storia dell’Occidente e che su di essa hanno incidenza.
Di fronte alla cultura della morte, agli orchi, il romanzo fantasy è visto come il baluardo dell’etica e dei valori civili: «Che i nemici della vita, della libertà, che i nemici della felicità […] non si facciano illusioni. Gli orchi esistono e devono essere fermati […] E senza follie di odio, perché gli orchi devono essere fermati per essere salvati, perché sono fratelli».
In La realtà dell’orco si ritrova tutto l’amore (una passione genuina, immediata, a volte dirompente) di Silvana De Mari per il genere fantasy, che la porta alla domanda finale, non tradendo le attese del lettore: «Perché scrivo fantasy? Perché solamente nel fantasy potevo mettere quello che penso di Dio. Noi siamo lo specchio di Dio. O forse non siamo lo specchio di Dio, ne siamo i figli, ognuno di noi è un suo frammento. Ognuno di noi con potenzialità infinita, quello che si chiama magia».
(Silvana De Mari,La realtà dell’orco, Lindau, Torino 2012, pp. 201, euro 21)