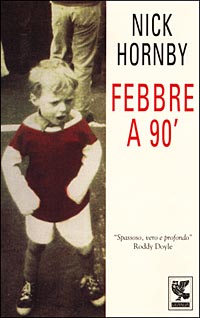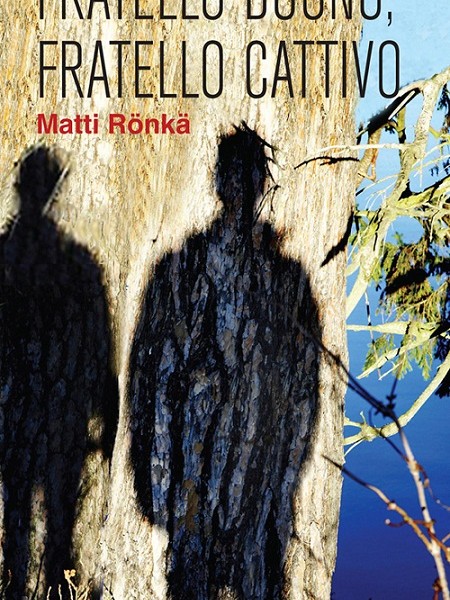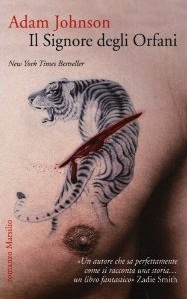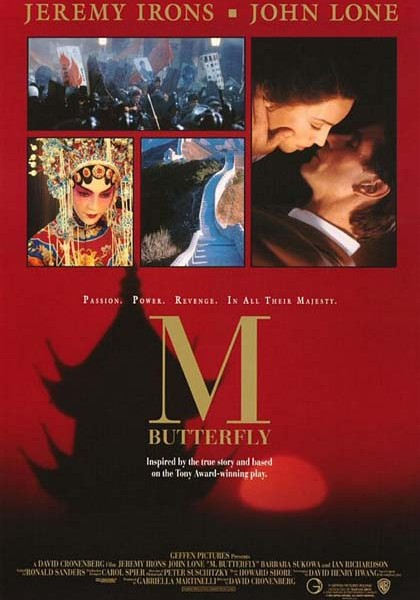La mostra Arte in Giappone. 1868-1945, curata da Masaaki Ozaki e Ryuichi Matsubara, è ospitata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, dal 26 febbraio al 5 maggio 2013. L’evento, organizzato per celebrare il cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma, nasce dalla collaborazione della Galleria romana con il Museo d’arte moderna di Kyoto, dal quale provengono quasi tutte le opere esposte, e consta di 111 dipinti e 59 oggetti d’arte applicata. L’offerta espositiva varierà però ai primi giorni del mese di aprile, quando gli esemplari artistici in mostra verranno quasi tutti sostituiti da altri per ragioni legate alla delicatezza dei materiali, in particolare dei tessuti dipinti. C’è da osservare che tale scelta organizzativa, sebbene dovuta in primis alle necessità conservative delle opere, permette anche l’alternarsi in due fasi di dipinti e manufatti, e quindi l’esposizione di un numero totale molto consistente di pezzi. Un’occasione di grande importanza quindi, se si considera che l’evento si propone di offrire uno spaccato della produzione artistica giapponese legata a un periodo storico molto rilevante, ma soprattutto molto ampio e artisticamente fecondo, che va dalla metà del XIX secolo al tragico epilogo del secondo conflitto mondiale.

Con la Convenzione di Kanagawa, siglata nel 1854 e pressoché imposta dagli Stati Uniti, il Giappone apre il commercio con la potenza occidentale, ponendo fine all’isolazionismo del periodo Edo; dodici anni dopo l’imperatore Meiji abolisce il regime feudale dell’epoca Togukawa, introduce un sistema politico che lo vede affiancato da un Parlamento e conduce lo Stato a una rapida industrializzazione. Nel frattempo, mentre il “giapponismo” si insinua in Europa, l’arte dell’isola imbocca contemporaneamente due vie opposte: quella dell’apertura a soggetti e tecniche propri dell’arte europea – si pensi all’introduzione della pittura a olio – e quella del recupero di modelli espressivi, tematiche e linguaggi legati all’antica tradizione giapponese, che a ogni modo non si manterrà impermeabile alle influenze occidentali. A quest’ultima corrente è dedicata l’evento in corso alla GNAM, che ha visto la luce nei giorni in cui a Roma si guardava a Est già con un’altra mostra dal titolo Sulla Via della Seta. Antichi sentieri tra Oriente e Occidente, allestita presso Palazzo delle Esposizioni e conclusasi il 10 marzo.

L’esposizione della Galleria è suddivisa in tre sezioni corrispondenti ai periodi di reggenza dei tre imperatori, Meiji (1868-1912), Taisho (1912-1926) e Showa (1926-1989), e offre all’osservazione degli spettatori splendidi kimono, paraventi decorati a pittura, vasi, preziosissimi oggetti d’arredamento e numerosi kakemono (rotoli di seta o carta dipinti).
Le linee, i colori e i motivi ornamentali, probabilmente non risulteranno inconsueti anche a chi, sebbene privo di una solida conoscenza dell’arte nipponica, appartiene a una cultura che ha abbondantemente attinto da questo ricco e affascinante serbatoio figurativo. Tuttavia, un percorso espositivo popolato da una natura immensa e sovrastante in cui l’uomo scompare, da lunari sagome femminili e da prorompenti ritratti di divinità, ha il merito di costituire uno stimolo potente per un più approfondito accostamento a questa realtà e alla sua sensibilità.

Arte in Giappone. 1868-1945
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Viale delle Belle Arti, 131, Roma
Prima esposizione: 26 febbraio – 1 aprile
Seconda esposizione: 4 aprile – 5 maggio
Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.gnam.beniculturali.it