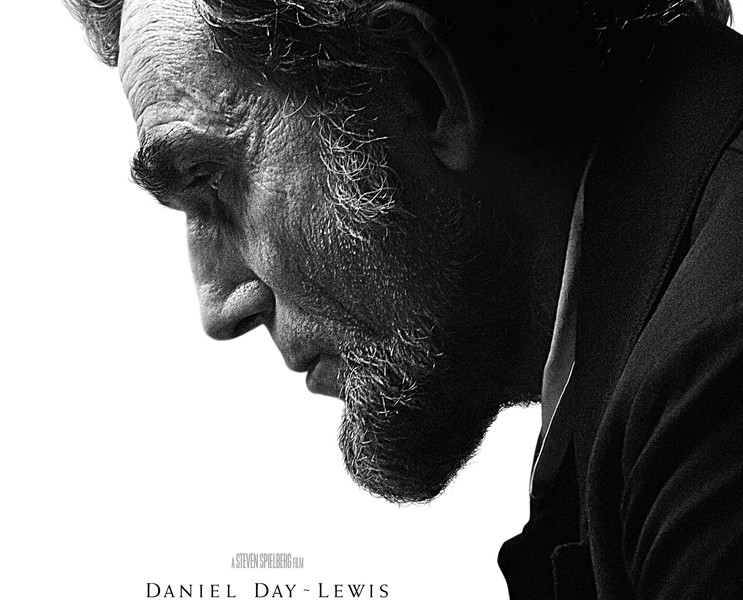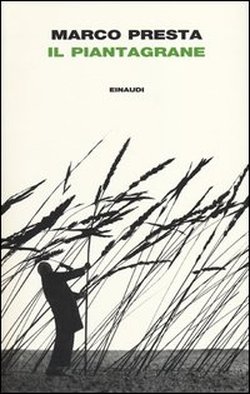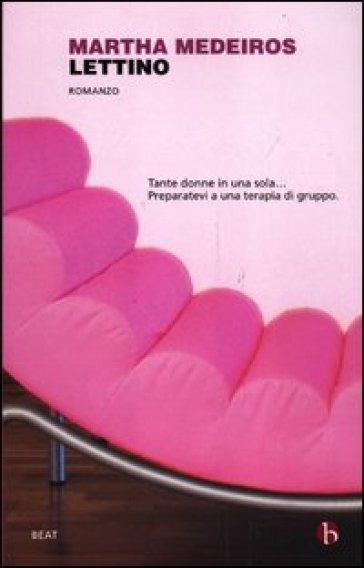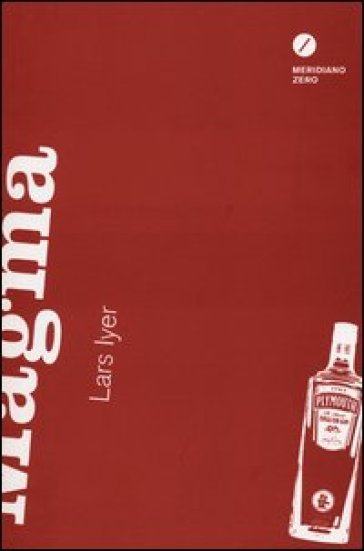«Pablo».
C’è rosso, qualcosa di rosso che spezza il buio. E silenzio.
«Pablo…»
Un odore acre mi afferra alla gola. Tossisco violentemente e non riesco a fermarmi. Butto fuori ancora sangue e saliva. Ho la vista annebbiata e nuovi conati di vomito mi scuotono. Non ho dolore, solo freddo. Molto, molto freddo.
«Pablo», dico, «per la terza volta».
Non so se sono morta, sembra uno strano sogno. Un sogno silenzioso, calmo e soffocante.
Io Pablo l’ho conosciuto al mare. Una di quelle cose che succedono per caso, sembra, e poi ti rivoltano la vita. Lui era accoccolato su una roccia massiccia, bruna e porosa, protesa sul cobalto del mare. Le dita scure si chiudevano su un canna lunga, rudimentale, dalla quale pendeva un filo invisibile, a perpendicolo sull’acqua. Il suo sguardo antico fissava calmo e immobile il punto preciso in cui il filo sottilissimo bucava l’acqua scura e spariva. Sembrava fosse lì da secoli, che dovesse essere lì e in nessun altro posto. Il sole calava piano nella baia. Ma c’era caldo, quel giorno, un caldo insopportabile. Io misi a fuoco l’obbiettivo e mi avvicinai a lui. Lentamente. Quando entrai nel suo campo visivo non fece minimamente cenno d’avermi visto. Si mosse appena, come per trovare meglio il punto d’appoggio.
Continuava a guardare quel punto fisso sul mare, come fosse l’unica cosa esistente al mondo.
Io scattai.
Poi lui aveva riposto la canna nella capanna e arrostito il pesce. Mi avvicinai, allora. Avevo scattato una ventina di foto fantastiche per il mio magazine, ero eccitata e avevo fame.
«Puedo assagiar?», gli chiesi nel mio spagnolo rabberciato.
Lui si voltò e mi guardò per la prima volta con quei suoi occhi antichi, calmi e distanti.
«Prego, mucacha, prego…», mi disse sorridendo. «Italiana?»
Anch’io sorrisi, e annuii.
Ci sedemmo uno di fronte all’altra, e ancora fui colpita dal suo sguardo. Mangiammo in silenzio, nella sera calma di Valencia, e poi parlammo. Parlammo molto, io lo guardavo, lui si passava le dita scure e nervose tra i capelli. Non so come dire, penso che queste cose non accadano sempre, non a tutti. Penso anche che quando due persone hanno tante cose da dirsi, è bello dirsele un po’ alla volta, magari ogni tanto o tutti i giorni, ma per sempre. Alla. fine mi ha accompagnato in albergo. Ci sono molti modi di stringersi le mani, e quella notte lui l’ha fatto con me nell’unico modo in cui io avrei voluto lo facesse. Mi ha detto: «No lasciarme, muchacha…»
Questo è successo dodici anni fa, e io e Pablo non ci siamo più lasciati.
Così ero con lui, quel giorno. O quella notte.
Dissi: «Pablo, ho paura. Tu dici che è vero?»
«Cosa?»
«Che finisce tutto, stanotte…»
«Stai calma, muchacha, calma, no te preocupe…»
«Non ci riesco, Pablo. E tu? Tu non hai paura?»
«No».
«Perché, dimmi perché…»
«Es una favola, muchacha, seguro…»
«Guardami, Pablo, guardami…»
È l’alba e siamo sulla spiaggia: hanno detto che sarà una cosa rapida, solo una gran luce. Senza cose trascendentali, senza dolore. Saremo avvolti da una gran luce. Mi sembra un buon modo di morire – penso – mi dispiace solo per Pablo. Io la mia vita l’ho presa sempre con filosofia, ma mi dispiace lasciarlo, ecco, mi dispiace molto. Comunque l’abbiamo deciso insieme, di aspettare sulla spiaggia dove ci siamo conosciuti. Come se in qualche modo ci concedessimo l’arbitrio di dare un senso alla nostra storia, un inizio e una fine che ci appartenesse.
È per questo che siamo qui, io e Pablo, stanotte.
Un vento leggero si è alzato da poco. L’acqua è scura, più del solito. Nuvole piene e morbide veleggiano all’orizzonte, quasi a ridosso del mare. L’aria è calda e pesante. Vedo uno stormo di gabbiani che sfrecciano tra cielo e acqua, ma non in cerca di cibo.
Non ho mai visto gabbiani all’alba. E muti.
Il sole sta salendo.
Che si pensa prima di morire? Sono confusa, la testa mi gira. Morire non è poi così difficile, penso. Forse è tutta una storia inventata. È la paura che ci frega, solo la paura. Basta amarla, la morte, e lei ti ama. Com’è che ci penso solo adesso? Già, sto morendo. Però, allora, quante cose non ho pensato? Ma, allora…
«Sono stata cattiva, Pablo?», dico improvvisamente, scuotendolo.
«No, muchacha».
Si passa le dita scure tra i capelli. «Tu mi hai amato, este es importante, muy importante… il bene e il male non esistono… sono la stessa cosa…»
Si alza in fretta, scrollandosi la sabbia di dosso. All’orizzonte spuntano altri gabbiani che tagliano in ogni direzione, come impazziti, il cielo chiaro. Mi alzo lentamente. Lui scruta il cielo e le traiettorie impazzite dei gabbiani sul mare.
I gabbiani, avevano detto, i gabbiani sono i primi a sentire.
Le nuvole si sono trasformate in piccoli sbuffi pallidi e sfilacciati che continuano a veleggiare all’orizzonte.
Eravamo così, fermi. Lui mi stringeva la mano e il suo calore mi placava, in qualche modo.
Dev’essere stato allora che è successo.
I gabbiani garriscono con un fragore innaturale, come se l’audio del mondo fosse stato attivato all’improvviso sul silenzio sepolcrale dell’alba.
Garriscono così forte che urlo ma non riesco a farmi udire da Pablo. Lui infatti non si gira, non mi guarda. È fermo e immobile a guardare l’orizzonte, Forse allora sto solo pensando di urlare – mi dico – perché la voce non esce, mi rimane strozzata in gola. Lo scuoto con violenza. Pablo si gira, finalmente. Ha il terrore negli occhi e io non avrei mai pensato che i suoi occhi potessero essere così, con dentro quello che vidi in quel momento.
Non sono i suoi occhi, non sono gli occhi di Pablo.
Guardo anch’io. La mia testa ruota lentamente di novanta gradi, per ogni grado un frammento di vita. E piazza gli occhi sull’orizzonte. Sembra che il mare si gonfi leggermente, con moto regolare. Sale piano, l’acqua immobile. Il sole è alto, arde e brucia le sabbia.
Una luce accecante inonda il cielo e me, e credo che qui sia finito tutto.
Dico: «Pablo… questo caldo, io non l’ho mai sentito… devo essere morta… sì, sono morta…»
E poi non ho più nella mia la mano di Pablo.
Ho caldo, molto caldo, questo mi ricordo.
È solo, Pablo, sdraiato alla luce della luna. Gli occhi guardano fissi in su, con terrore ostinato, quell’ultimo terrore ostinato che gli è rimasto stampato dentro.
Fa un freddo dannato, adesso. Mi tocco, mi guardo intorno. Non vedo Pablo. Cerco di alzarmi ma le gambe non reggono. Tossisco. Sento in bocca il sapore del sangue, molto sangue. Lo vomito e lo vedo cadere scuro sulla sabbia. Respiro a mala pena, come se avessi i polmoni intasati da qualcosa. Giro lo sguardo intorno e verso il mare. C’è buio fitto e una distesa infinita di qualcosa, e in fondo luce.
Dov’è Pablo? Dio, che freddo. Sangue. Scuro, sulla sabbia… E i gabbiani?… Si, c’erano i gabbiani… mi ricordo bene… dove sono finiti? La luce…
La luce è lì. E tutto quel nero, dovrebbe essere il mare. Arranco carponi alla rinfusa, la sabbia è fredda, asciutta, e mi punge le ginocchia nude e le mani. Vedo qualcosa, alla luce della luna che taglia il cielo nero come un bisturi affilato. Sembra un corpo disteso rivolto in su.
Arrivo lì, dove c’era il mare. Si, il mare, mi ricordo.
«Pablo».
C’è rosso, qualcosa di rosso che spezza il buio. E silenzio.
«Pablo…»
Un odore acre mi afferra alla gola. Tossisco ancora violentemente, e non riesco a fermarmi. Butto fuori ancora sangue e saliva. Ho la vista annebbiata e nuovi conati di vomito mi scuotono. Non ho dolore, solo freddo. Molto, molto freddo.
«Pablo», dico per la terza volta.
Non so se sono morta, sembra uno strano sogno. Un sogno silenzioso, calmo e soffocante.
Questo racconto si è classificato secondo al concorso Flan-Natale Story 2.