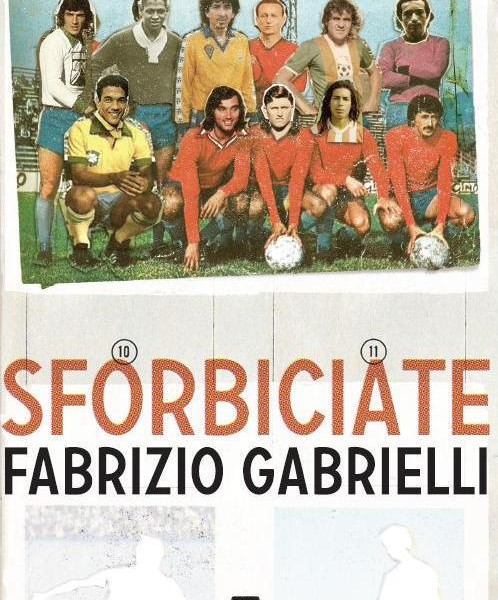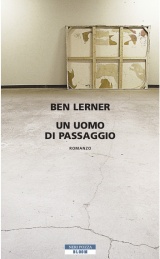Il dolce sollievo della scomparsa, edito da 66thand2nd, è il romanzo d’esordio di Sarah Braunstein, la prima mostra di una scrittura affascinante che avvolge e coinvolge in un insieme di storie abitate da personaggi straordinariamente umani e, come tali, deboli, imperfetti, fallaci.
Leonora è una ragazzina di dodici anni, figlia e bambina modello, è il contrario della trasgressione, eppure, un giorno, scompare. Dalla sua storia si propagano altri episodi, altre vite, altre sparizioni che – oltre a ipnotizzare il lettore – inquietano, distruggono e forse liberano chi resta.
Abbiamo incontrato Sarah Braunstein in occasione di Più Libri Più Liberi.
Una delle prime impressioni nette che si hanno leggendo il libro è la sensazione di guardare un film, data forse dalla struttura frammentata, dai close-up su ogni personaggio. Oltre alle possibili influenze letterarie, senti di esser stata influenzata o ispirata da un film o un regista in particolare?
Adoro i film che riescono a disorientare un po’ lo spettatore, a confonderlo. Quelli in cui si prende una direzione, poi si cambia bruscamente, e si incontrano tanti personaggi diversi lungo la strada ma solo alla fine si scopre come sono collegati tra loro. C’è un film intitolato Magnolia che posso senz’altro dire mi abbia ispirato. E poi, da adolescente adoravo David Lynch e Twin Peaks, ma è stato solo dopo aver scritto il libro che mi sono resa conto dell’enorme eco di Twin Peaks in tutto il romanzo.
Le sparizioni sono qualcosa che mi ha sempre interessato molto, e come la comunità rispondesse alla scomparsa di bambini o adulti. Semplicemente, hanno iniziato ad attrarmi le storie di persone scomparse, ma anche ogni tipo di storia che non si svolga in modo prevedibile.
La struttura del romanzo è molto complessa, perché questa scelta? È stato un modo di trasmettere, già dalla forma stessa del libro, la situazione problematica in cui i personaggi si trovano?
Credo che si possa raccontare una storia dalla A alla Z, in ordine cronologico, e in qualche modo questo riflette una sorta di coesione, una specie di coesione psicologica. Invece questi personaggi sono frammentati, scissi, in difficoltà, e credo abbia senso che il testo, la struttura del romanzo, sia complicato quanto la loro situazione. Sì, credo che in qualche modo rifletta lo stato interiore dei personaggi.
Il titolo che inizialmente avevo pensato per il libro, prima che uscisse, era Split, qualcosa di rotto, una persona psichicamente scissa. In inglese c’è anche un’espressione idiomatica per dire «andiamo via», si dice: «We’re going to split», «andiamocene», «scappiamo». Quindi in qualche modo avrebbe ricalcato anche la trama stessa.
E poi perché hai deciso di cambiare il titolo? È stato per ragioni commerciali?
Be’, sì, un giorno, quando il mio agente stava per mandare il libro ai vari editori, mi disse: «Questo libro è così unico che ha bisogno di un titolo altrettanto unico», e abbiamo cercato di trovare un titolo che fosse più originale e spaventoso allo stesso tempo, in qualche modo più sconvolgente. Alla fine abbiamo deciso per The Sweet Relief of Missing Children, che si può leggere in tanti modi diversi, ed è frammentato come la struttura stessa del libro. Penso che anche la traduzione italiana del titolo sia ottima, mi piace moltissimo anche come suona, funziona.
Suggerisce anche che ci sia una sorta di piacere nel fatto di scomparire…
Esatto, e volevo che le persone sapessero che questo è un altro aspetto che il libro esplora, non si tratta solo di orrore, ma di quella specie di strano e inaspettato sollievo, piacere o gioia che c’è nel fuggire, ma anche nell’essere lasciato, abbandonato. Nel libro ci sono figure materne che si sentono liberate dal loro ruolo quando i loro figli scappano di casa. E volevo che tutte queste possibilità rientrassero anche nel titolo stesso, perché fosse chiaro che il romanzo non propone una versione soltanto, ma tratta una realtà più nebulosa e sfaccettata.
Leggendo, a poco a poco risulta chiaro che tutti questi personaggi non sono legati solo dal tema della scomparsa e, in seguito, dalla trama stessa, ma sono anche accomunati da alcune ossessioni che nella maggior parte dei casi hanno a che fare con il sesso.
Volevo guardare da vicino tutte quelle cose di cui le persone non vogliono mai parlare, perché penso che il libro abbia a che fare con ciò che accade quando si abbatte il livello di socializzazione, che cosa c’è sotto. Volevo scrivere delle difese delle persone, che spesso sono nascoste, e credo che il sesso sia in certi casi una metafora di tutto questo, un modo di guardare alle difese nascoste. Il modo in cui gestiamo il sesso può rivelare molto di ciò che temiamo, e credo anche che sia diventato un modo per concretizzare i nostri stati d’animo. E poi, il sesso può essere un modo di scappare senza in realtà andare da nessuna parte. Fare sesso con qualcuno con cui non si dovrebbe, con la persona sbagliata, è una specie di trasgressione che ciascuno commette, e credo sia un modo di fuggire, di scappare da sé stessi. Ognuno ha un rapporto diverso con il sesso, ma sono convinta che faccia luce sulle paure e le ansie di ognuno di noi, sul nostro io nascosto.
Era la miglior metafora che potevo usare, ma allo stesso tempo era significativo anche a livello letterale, come il modo migliore per arrivare a qualcuno nel profondo, nell’intimo. Mentre scrivevo, ho letto molto Freud, e ho voluto riflettere su cosa ci trattiene dall’essere violenti, cosa ci impedisce di essere dei veri mostri. Nel romanzo ho voluto mostrare delle persone che fossero in qualche modo attratte da quella parte di sé che di solito tengono nascosta. E il sesso mi sembrava in miglior modo per esprimerlo.
Ovviamente, il romanzo tratta molto il tema delle relazioni familiari, del rapporto con i genitori. Le difficoltà di tutti i personaggi, compresi gli adulti, hanno a che fare che l’infanzia. Pensi che viviamo nella costante impossibilità di proteggere i nostri figli, e in generale i nostri cari? Il personaggio di Leonora ne è forse un esempio, la sua vita è tutta regole, protezione assoluta, eppure…
Be’, diciamo che è qualcosa che mi fa paura, io stessa ho un figlio piccolo e ho scritto questo romanzo mentre ero incinta. Vorrei credere che possiamo, che siamo in grado di proteggere i nostri figli, ma non lo so. Credo che tu abbia ragione, e che tutti i problemi dei personaggi derivino da un pessimo rapporto con i genitori. Paul, per esempio, con sua madre: lei fa del suo meglio, cerca in ogni modo di dargli un padre, e una vita, di dargli sicurezza, ma sbaglia completamente e finisce praticamente per abbandonarlo. Per lei, il sesso è un modo, una sorta di metodo in realtà, per trovare chi possa darle sicurezza. Ma il risultato è che suo figlio è lasciato molto a sé stesso.
Sam, per fare un altro esempio, è rimasto orfano dopo che la madre si è praticamente gettata in un incidente che ha ucciso il resto della famiglia. Lui viene allevato da due classiche brave persone, gli zii, ma sente di avere in eredità una sorta di cattiveria, come se fosse destinato a essere cattivo, ed è questo che lo fa entrare in contatto così disperatamente con Judith, perché la vede in qualche modo come pericolosa e instabile.
Quindi, qualunque sia la nostra situazione familiare, credo che le nostre fantasie riguardo noi stessi e i nostri genitori siano potenti ed efficaci almeno quanto la realtà stessa. Per esempio, nel caso di Leonora: ha genitori molto più attenti, forse fin troppo, ma questo non riesce comunque a salvarla. La sua bontà è la sua curiosità nei confronti del mondo, ed è per questo che si metterà nei guai e si lascerà rapire. Il messaggio che riceve da sua madre è che bisogna essere socialmente attivi, che bisogna rendersi utili, e un’altra cosa che la madre le ha insegnato è di non giudicare mai nessuno solo dall’aspetto. Quindi quando quei due tizi un po’ inquietanti le si avvicinano, lei segue la lezione di sua madre, e non vuole fare l’ipocrita, quindi la segue alla lettera, e si trova in pericolo.
Nel libro ci sono tanti tipi di genitori, e nessuno è davvero in salvo. Ma credo che il romanzo abbia anche molto a che fare con la realtà della maternità, la vera angoscia che una madre prova quando la sua identità viene quasi inglobata dal figlio. Nel caso di Grace, per esempio, ha questa bimba, la adora, la cresce meglio che può, ed è sempre molto preoccupata per lei, Judith. E tuttavia, quando Judith scappa di casa la madre prova una sorta di liberazione, sente che finalmente può forse vivere la sua vita e scappare a sua volta.
Quindi non lo so, forse è solo una serie di riflessioni che inevitabilmente mi sono trovata a fare durante la gravidanza. In ogni caso, ho l’impressione che sempre più donne, almeno negli Stati Uniti, e ancor più negli ultimi cinque anni, sentano l’esigenza di parlare della maternità, anche in modi in cui le persone di solito non amano parlarne: dell’ambivalenza e della complessità di un’esperienza del genere, senza romanzarla più di tanto.
Parlando invece di scrittura in sé e per sé: nel romanzo ci sono molti personaggi diversi, adulti e bambini, e ognuno è trattato con incredibile precisione e cura. In che modo sei riuscita a calarti nei panni di personalità tanto diverse? È stato difficile gestire il punto di vista dei bambini?
Dunque, tra tutti, la voce di Leonora è quella che mi è riuscita più facile, naturalmente. Non appena l’ho focalizzata, è stata la sua voce a riempirmi, non è stato difficile, mi è bastato incanalarla: era come se mi riempisse la mente e io non dovessi far altro che metterla sulla pagina. Non so perché, forse perché è la figura più vicina alla mia, ma il suo punto di vista è stato chiaro fin da subito.
Per quanto riguarda le altre voci, ho cercato di svilupparle mantenendomi molto vicino a ogni personaggio mentre ci lavoravo: scrivevo cinquanta o sessanta pagine utilizzando la stessa focalizzazione, cercando di arrivare a conoscere davvero ogni singolo personaggio prima di andare avanti. Ho scritto il libro in queste grandi sezioni, e poi le ho divise e mischiate solo in seguito.
La chiave per scrivere il libro è stata avvicinarmi pian piano a ogni voce, specialmente al punto di vista dei bambini. Quando ho sentito la voce di Paul, per esempio, e mi sono addentrata nel suo modo di ragionare, ho percepito la trama dei suoi pensieri, è stato allora che ho realizzato che sarei riuscita a scrivere il romanzo. Ci è voluto moltissimo tempo: lavorare ogni personaggio, arrivare a sentire la voce, la consapevolezza di ognuno. Ci metto molto, ma quando ci riesco, quando riesco ad arrivare al cuore di un personaggio, è allora che amo scrivere, ed è stato allora che mi sono resa conto che davvero avrei potuto mettere insieme il libro.
Quanto tempo hai lavorato al romanzo?
Moltissimo, perché quando ho iniziato non sapevo come strutturarlo. Ci sono voluti quasi dieci anni, è stato anche un modo per insegnare a me stessa a scrivere. Si trattava del mio primo libro, e quando sono arrivata in fondo mi sono resa conto di aver imparato tantissimo sulla scrittura, su come mettere insieme le frasi, su come scegliere le immagini. Quindi sono stata costretta a tornare indietro e ricominciare da capo, non tanto per modificare i personaggi o la storia, ma perché tecnicamente avevo acquistato un maggiore controllo sulla frase, sulle parole. L’ho ripreso dall’inizio o e ho lavorato e lavorato il tutto un’altra volta. Sì, ci ho messo moltissimo, ma ero molto giovane quando ho iniziato.
Sembra banale, ma credo che chiunque abbia letto il libro avrebbe voglia di chiedertelo: c’è un personaggio al quale sei più legata, uno che consideri il tuo preferito?
Guarda, non avrei proprio voluto arrivare a questo. Mentre ci lavoravo avevo gli stessi sentimenti nei confronti di ogni personaggio, ma poi, alla fine, quando ho guardato al libro finito, mi sono sentita fortemente legata a Leonora. Scrivere la sua storia è stata una sofferenza immensa. Sono convinta che fosse necessario farle ciò che le ho fatto, ma mi ha spezzato il cuore, è qualcosa che non avevo mai provato prima. Credo di essere sempre riuscita a mantenere una certa distanza tra me e i miei personaggi, ma con Leonora è stato diversi, la sentivo profondamente vicina, e alla fine volevo salvarla, proteggerla da tutte quelle cose terribili. Poi però mi è tornata in mente la lezione di uno dei miei insegnanti di scrittura, che diceva che non possiamo proteggere i nostri personaggi, ma anzi dobbiamo imporci di fare loro ciò che deve accadere a servizio del libro. E parte delle ragioni per cui ho scritto questo romanzo era esplorare in profondità l’esperienza di un bambino che è stato rapito. È qualcosa che vediamo sempre in televisione o nei film, ma la vittima è sempre una sorta di oggetto di scena, una bella bambina, e niente di più, non arriviamo mai ai suoi pensieri, non così nel dettaglio, comunque. E volevo vedere che cosa sarebbe successo andando a scavare in profondità, ma sempre lasciando filtrare la realtà nel libro, per quanto pericolosa. Doveva accadere, e volevo arrivarci, e rendere omaggio al personaggio testimoniando la sua esperienza. Quindi sì, senz’altro Leonora.
E poi, l’altro personaggio che amo particolarmente è Paul, perché credo che il romanzo sia in parte suo. Non avrei mai immaginato di sentirmi così legata a lui, ma nel momento in cui decide di cambiare nome e cerca di confessare, be’, credo che quello sia un gesto davvero incredibile da parte sua. È così buono e generoso quando prova a confessare, ed è davvero convinto di fare qualcosa, finalmente, di agire: non è più passivo, cerca di rendersi utile, proprio come Leonora con la sua famiglia. Ed è una cosa folle, ovviamente non funziona. Ma credo che lui sia convinto di potersi liberare dal suo passato con quel gesto, e davvero mi sembra una specie di eroe. E poi c’è la questione della sua omosessualità, che ha sempre represso, convinto che non potesse neanche lontanamente far parte della sua vita, ma alla fine riesce a superare anche questo, quindi… non l’ho mai definito in questo modo prima d’ora, ma sì, credo proprio che sia un eroe.
Sono convinta che la colonna portante del romanzo siano loro due.
A proposito della figura di Paul, c’è un capitolo del libro in cui è poco più di un bambino, e ha davanti agli occhi questa torta di compleanno, e ha una voglia terribile di assaggiarla, mentre la madre glielo impedisce perché aspetta l’ennesimo ospite. È una scena molto forte, indelebile, e così equilibrata in sé che potrebbe funzionare come racconto. Hai mai pensato di dedicarti a racconti brevi?
È vero, anzi credo di averlo davvero pubblicato come racconto, come estratto, prima dell’uscita del libro. È la giusta domanda, perché dopo il romanzo ho pubblicato un paio di saggi brevi, ma adesso mi sto dedicando ai racconti, ne ho due pronti che sto cercando di far uscire proprio ora su qualche rivista. Il racconto richiede una scrittura in certo modo più difficile, occorre misurare ogni singola parola, tutto ha la sua importanza, ci vogliono economia e precisione. Voglio dire, anche un romanzo è difficile da scrivere, ma c’è comunque lo spazio per lasciare che la scrittura esploda. Invece un racconto deve essere netto, preciso; è difficile. Però ci sto provando proprio in questo periodo, e sono ottimista: credo di aver finalmente imparato che cosa non dire, non l’avevo mai capito prima. Quindi sì, vorrei provare a scrivere dei racconti. Sto anche scrivendo un altro romanzo, e non voglio usare la stessa struttura, però mi interessano i romanzi che hanno più storie intrecciate, o che fanno parte di una struttura più ampia, cicli di storie o diversi episodi all’interno dello stesso romanzo. Trovo che sia una forma interessante: non voglio fare niente del genere, ma qualcosa di simile.
Vuoi darci qualche anticipazione sul nuovo romanzo?
Dunque, non è semplice da descrivere. Per un po’ ho lavorato come assistente sociale, come counselor, parlavo con le persone, le ascoltavo. E ho lavorato anche in un ospedale psichiatrico mentre scrivevo il romanzo. Quindi ho passato davvero molto tempo accanto a persone sofferenti, che credo sia una delle ragioni per cui ho scritto questo libro in questo modo. Però mi ha fatto venire un’idea: negli Stati Uniti abbiamo questi enormi superstore, come Walmart, che contengono un supermercato, negozi di arredamento, piante, prodotti per il giardino, una farmacia, una banca… e tutto è nello stesso posto, è come una piccola cittadina. E ho pensato: «Scommetto che prima o poi ci sarà uno psicologo, da Walmart». Credo che questa cosa non sia poi molto lontana dalla realtà, quindi sto scrivendo un romanzo su un analista che lavora in un superstore come quello, perché è un mondo che conosco, ho studiato teoria della psicologia, e credo che potrebbe essere divertente, una specie di critica sociale. È appena agli inizi, ma l’idea è questa.

(Sarah Braunstein, Il dolce sollievo della scomparsa, trad. di Andreina Lombardi Bom, 66thand2nd, 2012, pp. 360, euro 16)