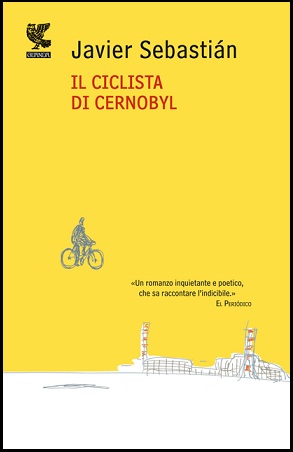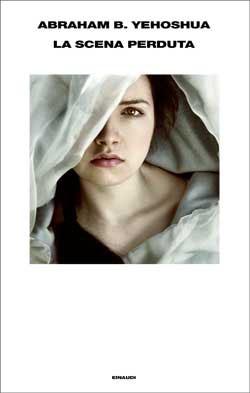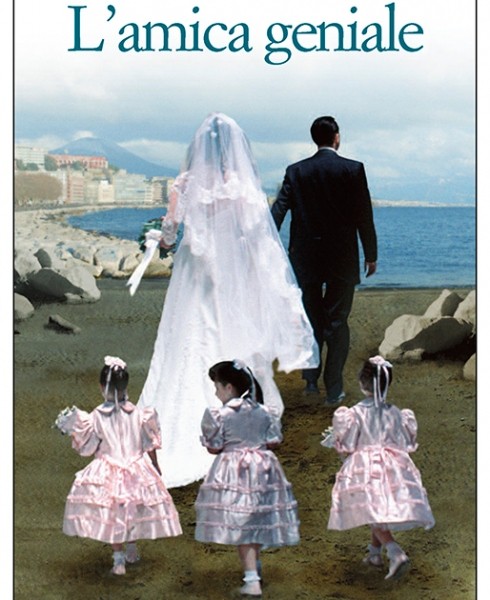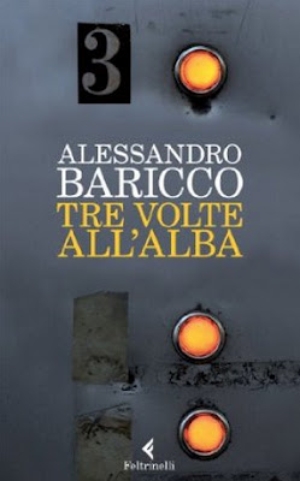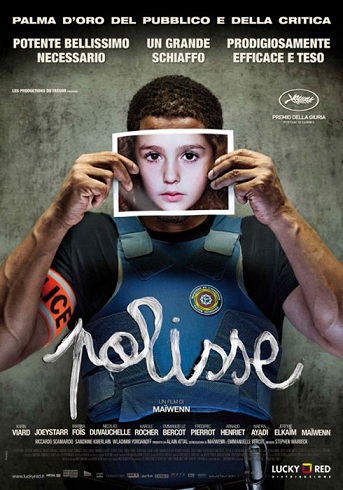È stato salutato come la versione femminista del “cartone monumento” di Walt Disney, assurto al cielo dei simboli al punto che quasi nessuno aveva osato un remake (parodie a parte). Mirror Mirror, questo il titolo originale del film, più che una Biancaneve femminista che duetta con una regina cattiva, impersonata da Julia Roberts, pare una macedonia cinematografica con esiti alterni. È contaminazione, mescolanza di generi, registri e citazioni, tra mitologie ancora perfettamente funzionanti (dalla coppia madre-figlia Demetra Persefone a seguire), archetipi messi in circolo persino in forma involontaria, e crudeli infiltrazioni di realtà. Sarà perché il regista indiano Tarsem Singh tiene insieme, fin dalla sua biografia, sacre origini indù e profane produzioni tra Bollywood e Hollywood, ha lavorato e lavora molto in set pubblicitari e alla realizzazione di video musicali (quello dei R.E.M., “Losing My Religion” si aggiudicò un Grammy e altri premi sparsi) ed è dunque un professionista del mix come del remix. Certo è che il film spicca per il gusto di “profanare” il tempio Disney, rimescolare le carte, giocare sull’effetto sorpresa disattendendo una a una le aspettative sedimentate sull’asse Grimm-Disney.
Il copione della favola che si ha in mente è smentito, si esalta la narrazione visiva, tutto merito di scenografia (interni tra stile giapponese ed espressionista) e costumi, trionfo barocco senza i quali non si avrebbe l’effetto ridondante che fa sembrare il film un cartone. La rivisitazione, insomma, a cominciare dal fatto che non è animata ma con attori in carne e ossa, si concede parecchie libertà e senza timidezze: la voce narrante che apre il racconto è quella di Grimilde (Julia Roberts), la malvagia regina e matrigna che sa essere sarcastica, cattiva a colpi di umorismo quanto involontariamente comica e convincente molto più della Biancaneve (Lilly Collins, figlia del musicista Philip Collins), piuttosto scialba e insignificante malgrado le folte sopracciglia che parrebbero quasi caricaturali e non lo sono; il principe sembra un cacciatore, invece il maggiordomo è il cacciatore. Proprio l’esordio, grazie al lavoro della computer grafica, rende lo specchio uno strabiliante occhio meta-cinematografico, pertugio da cui si accede a un mondo dove il narcisismo scatena la rivalità femminile.
Il re, tanto benevolo verso i sudditi, è scomparso nella foresta nera (reclutata da altre fiabe) dove imperversa una bestia (riesumata da bestiari medievali e sacri testi). Intanto la matrigna ha preso il comando del regno: è una pessima governante perché dilapida i soldi pubblici in frivolezze, costringe i sudditi a una pressione fiscale iniqua e oppressiva. Biancaneve è reclusa nel castello non perché abbia fatto chissà che, solo è tanto irritante (in effetti come non dare ragione alla regina e parteggiare per lei!). Fino a diciotto anni quando, come una sorta di “Siddharta in gonnella” – anzi in veste e mantello spettacolari, realizzati come tutti i costumi dalla geniale stilista giapponese Eiko Ishioka che ha eseguito il suo ultimo lavoro proprio per Singh (scomparsa da poco, le sue opere sono esposte al Moma di New York, vinse l’Oscar per i costumi di Dracula nel film di Coppola) –, decide di uscire dal castello e di scoprire la realtà. S’imbatte in sette nani dai nomi diversi rispetto a Disney, in verità sette giganti (usano trampoli) briganti che vivono di rapine facendo acrobazie, in un principe fessacchiotto e credulone (Armie Hammer) con il suo servitore, entrambi ridotti in mutande. Avendone viste abbastanza decide di tornare a palazzo per avviare la sua personale battaglia contro la regina. E allora si trasforma in una sorta di “Robin Hood al femminile”, spadaccina con tratti da Giovanna d’Arco, rimanendo comunque acerba e slavata rispetto alla Roberts che per l’intero film è dedita a cercare di farsi sposare dal principe, anche per ripianare i debiti e le finanze del reame, tra incantesimi parzialmente riusciti, estenuanti e persino repellenti cure di bellezze a cui si sottopone nel culto dell’eterna giovinezza. Resta comunque la più bella del reame, la regina: ciò che invidia a Biancaneve pare essere, più che il fascino che manca alla sbarbina, l’età, il vantaggio della giovinezza. Presa coscienza di sé, la giustiziera Biancaneve si batterà persino con la bestia (come san Giorgio e il drago), affronterà le prove senza morire, sconfiggerà burattini di legno giganti azionati dalla magia nera che sono una felice trovata; compirà tutte quelle azioni che erano state di “competenza” del principe, bacio compreso. Ma qui è meglio non dire altro.
Certo è che la Biancaneve “emancipata” non fa che invertire i ruoli attribuendo ai personaggi maschili quella passività interposta a permanente stato letargico e/o confusionale tradizionalmente spettante, nelle fiabe, al femminile. Troppa acqua è passata sotto i ponti da quando nel 1812 i fratelli Grimm, per omaggiare lo spirito germanico, raccolsero favole popolari tra cui questa che pure ha versioni differenti e riesuma un antico mito nordico. Poi ci mise lo zampino Walt Disney realizzando, nel 1937, il primo lungometraggio animato che gli valse l’Oscar. Fiaba animata che, per l’adesione alla massoneria del suo ideatore, è stata tra l’altro anche interpretata in chiave esoterica: i sette nani, personaggi centrali sono la rappresentazione cosmica dei sette nani come pianeti e Biancaneve l’ottavo elemento, simbolo di completezza; la matrigna come matrix, energia apparente che perpetua l’illusione e si contrappone all’energia cosiddetta debole dell’universo, prevalente ma invisibile. Le fiabe, secondo l’accezione psicoanalitica racchiudono sempre processi psichici, tentativi di ricomporre un equilibrio interiore rotto o non ancora realizzato, come nel delicato passaggio dall’adolescenza alla maturità. Lo psicoanalista Bruno Bettelheim ne Il mondo incantato considerò la favola di Biancaneve come un esempio delle dinamiche edipiche nella relazione madre-figlia. La mela avvelenata, poi, ha una carriera antica e di tutto rispetto da Eva in poi, fino alle teorie di incorporazione di Melanie Klein nella lotta narcisistica tra madre e figlia. Fromm avrebbe parlato di “narcisismo maligno”. Dove voglia andare a parare il film oltre ad attualizzare la trama e dare una fotografia del rapporto tra i sessi nella società attuale (americana, in verità) a favore delle donne, non è dato sapere. La psicologia analitica junghiana insegna che solo integrando i due poli (e non già sopprimendone alternativamente uno o l’altro) si giunge a un dinamico equilibrio psichico, individuale e collettivo.
Si può constatare che il revival fiabesco attira: Biancaneve tornerà ancora sugli schermi in una versione più gotica epica e dark con una Charlize Theron matrigna. Forse si sta raschiando il fondo del barile, in assenza di idee e in cerca di sicuri incassi. Però parrebbe quasi che nel post del post moderno aumenti lo stato confusionale e si cerchino riferimenti classici, sia pure solo per strapazzarli. Così potrete assistere alla grande festa di nozze di Biancaneve con il principe in puro stile Bollywood con tanto di musiche orientaleggianti e danza del ventre. Allora forse sì, valgono le parole profetiche del capostipite moderno del narcisismo, Dorian Gray:«Viviamo in un epoca nella quale le cose non necessarie costituiscono le nostre sole necessità».