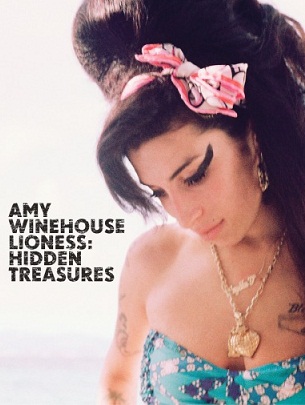L’ombra sua torna che era dipartita
(Dante Alighieri, Inf IV)
Dante e Petrarca, i due grandi occhi della letteratura italiana delle origini spalancati verso il futuro (prendo la metafora da Benvenuto da Imola, che la utilizza a proposito di Dante e del suo «primo amico», Cavalcanti) rappresentano, nel corso della cultura italiana, una diarchia litigiosa, la storia della quale è scandita da lunghi e reciproci spodestamenti. Per molti secoli – quelli del classicismo di antico regime – è Petrarca il princeps indiscusso della civiltà letteraria italiana, autore, con i Rerum vulgarium fragmenta, del libro che, nel Cinquecento, Pietro Bembo innalzerà a «tavola della legge» della poesia volgare. La poesia italiana si orienta così per secoli osservando l’astro petrarchesco, stella luminosa ma fissa. È a partire dalla fine del Settecento, con la poesia di Varano e di Monti – coeva in parte alle riflessioni del Vico intorno alla grandezza di Omero e Dante –, che le azioni della poesia dantesca conoscono il primo rialzo nella borsa dei valori poetici; l’Ottocento romantico – l’era del De Sanctis e del Leopardi – conosce una fervida ripresa e polarizzazione dell’interesse intorno al poeta fiorentino, e si configura, dal nostro punto di vista, come la grande vigilia culturale che annuncia la riscoperta di quell’immenso forziere di lingua e stile – la Commedia – fino ad allora rimasto misteriosamente sigillato.
È con Giovanni Pascoli (1855-1912), traghettatore della poesia italiana tra i due secoli, che la vigna poetica dantesca conosce, alle soglie del moderno, la prima, ricchissima, vendemmia. La rivoluzione inconsapevole del Pascoli (per dirla col De Benedetti) è ascrivibile in una sorta di involontario “auerbachismo” che, rompendo le paratie tra generi e stili (una propagazione sismica di quello che era stato il sommovimento tellurico provocato dal Romanticismo europeo), apre al parlato la lingua di tutti i giorni, rinnovando – dopo secoli di stagnazione classicistica – il linguaggio poetico italiano.
Il poeta romagnolo, già a partire dal debutto myriceo (1891), mostra la più ampia capacità orchestrale che la nostra poesia abbia mai conosciuto dai tempi di Dante. È stato Contini a ragionare sull’ampiezza verbale della poesia pascoliana, che – distribuita sui livelli del linguaggio grammaticale, pre-grammaticale, e post-grammaticale – dà vita a un plurilinguismo moderno, cancellando le ultime ipoteche di tipo classicistico che ancora gravavano sulla tradizione letteraria italiana. L’icasticità del linguaggio pascoliano rappresenta una novità in una poesia che si era piuttosto riconosciuta nella sublime evasività ereditata da Petrarca, e che aveva a lungo avuto, vezzo più volte rimproverato dallo stesso Pascoli, una certa tendenza all’improvvisazione nomenclatoria (si pensi alla censura pascoliana del leopardiano «mazzolin di rose e viole»).
Attraverso la rivoluzione retorica pascoliana, la poesia lirica italiana dimette i paramenti festivi e domenicali tipicamente petrarchistici (il monolinguismo di Petrarca è, se lo osservi da una specola bembiana, una sorta di «domenica linguistica») e riscopre l’immensa sartoria dantesca, dalla quale prende le vesti formali che indosserà lungo il Novecento.
Il dantismo pascoliano si configura su piani diversi; oltre ai dantismi situazionali presenti già in Myricae (si pensi a un madrigale come quello dedicato alla rivisitazione del personaggio purgatoriale di Belacqua), alla ripresa di neologismi danteschi (cfr, nella medesima raccolta, il verso incipitario «nel ciel dove ogni vision si immilla»), storicamente significativo è il dantismo metrico, legato alla ripresa del metro della terza rima, mediato da archetipi montani e varaniani. Già la prima poesia di Myricae, “Giorno dei morti”, lugubre ricognizione dei propri defunti, è scritta in questo metro: «Io vedo (come è questo giorno oscuro) / vedo nel cuore, vedo un camposanto / con un fosco cipresso alto sul muro)».
Al tempo della raccolta esordiale l’utilizzo del metro della Commedia dantesca è un’iniziativa che convive con la volontà di ripercorrere e ripristinare forme e moduli della tradizione, e non ha ancora grande spazio; è al tempo dei Poemetti, quando la poesia pascoliana incontra una sempre più conquistante seduzione poematica, che la maggiore richiesta di narratività, implicita in questa poesia, permetterà a tale metro di raggiungere gli esiti quantitativamente e qualitativamente più alti, conferendogli quel pedigree retorico che è la causa della sua fortuna nella poesia primonovecentesca.
Sempre intorno alla Commedia e alle Rime si svolgono diversi momenti intertestuali della poesia pascoliana successiva ai Poemetti, come quella dei Canti di Castelvecchio o dei Poemi conviviali. Parlando di dantismo pascoliano, non può essere certo trascurata, contestuale all’attività poetica, l’esegesi del testo dantesco, consegnata a saggi come Minerva oscura o Sotto il velame, scritti sul crinale tra i due secoli. È un Pascoli dalle profonde risorse esegetiche, che insegue nella Commedia tesori allegorici mai visti prima di allora; di grande importanza è la ripresa di alcuni spunti che erano già stati del Perez (autore, nel 1865, della Beatrice svelata) legati alla figura di Beatrice e alla sua riapparizione in Purg XXX; oltre a questo, è di grande importanza la riflessione sulla presenza, nella poesia dantesca, dell’allegorismo vittorino, linea critica che avrà grande fortuna nella dantistica successiva.
Insieme a Pascoli l’altro poeta che spalanca le porte della letteratura italiana moderna è Gabriele D’Annunzio (1863-1936). La grande tendenza all’intertestualità del poeta pescarese si annuncia sin dalle prime raccolte, orientandosi in base ai diversi momenti culturali conosciuti dalla sua letteratura. Un forte interesse è rivolto alla Vita Nuova, libro che, alla fine dell’Ottocento, incontra una grande fortuna europea, sull’onda del preraffaelismo inglese che influenza lo stesso D’Annunzio sin dai tempi dell’Isotteo. Nel meriggio della poesia dannunziana, celebrato da Alcyone (1903), il Dante del libello giovanile è un interlocutore discreto e continuo, come testimoniano i versi incipitari della poesia “Beatitudine”: «Color di perla ha quasi in forma, quale / conviene a donna aver, non fuor misura. Non è, Dante, tua donna che in figura / della rorida sera a noi discende?»
L’erede più diretto della tradizione pascoliana e dannunziana è il poeta torinese Guido Gozzano (1883-1916) che, sulla base di questi archetipi, fa dell’intertestualità il motore retorico della sua poesia. Si tratta di una poesia animata, potremmo dire, da un moderno pathos di gusto callimacheo, stemperato da un sottile humor, che sfida il lettore nel riconoscere gli imprestiti ricavati dalla tradizione. Molti sono i versi della Commedia riorchestrati in una diversa chiave tonale: nella poesia “L’onesto rifiuto”, il verso, più volte ripetuto, «Non sono lui!, non quello che t’appaio», riprende le parole rivolte da Niccolo III al poeta agens in Inf XIX. («Non son colui, non son colui che credi»). I versi conclusivi della poesia “Pioggia di Agosto” («O mia musa dolcissima che taci, / allo stridio dei facili seguaci, / con altra voce tornerò poeta») contengono la memoria delle terzine che aprono Pd. XXV (vv. 1-8: «Se mai continga che il poema sacro / al quale han posto mano e cielo e terra, / sì che m’ha fatto per più anni macro, / vinca la crudeltà che fuor mi serra / del bello ovile ov’io dormi agnello, / nimico ai lupi che gli fanno guerra, / con altra voce omai, con altro vello, ritornerò / poeta / e in sulla fonte, del mio battesmo prenderò il cappello»). La poesia gozzaniana rappresenta, con l’esempio pascoliano alle spalle, un momento di felice unione tra istanze tipicamente narrative e istanze squisitamente liriche: un tale matrimonio è permesso ancora una volta dalla forma terzina, che si conferma nuovamente come metro per eccellenza di racconto lirico.
A quanto mi risulta non è mai stato sufficientemente valutato il dantismo presente nell’opera poetica di Camillo Sbarbaro (1888-1967). Al poeta ligure è stato riconosciuto come ascendente più diretto (e il rilievo è indiscutibile) il Leopardi petroso dell’ultima stagione poetica (quello definitivamente congedatosi dalla Vita nova recanatese) dal quale riprende il tema della desertificazione del mondo, del nulla come unico orizzonte emotivo. Questo tema, pienamente novecentesco, viene talora arricchito con spunti che vengono sia dal Baudelaire dei Tableaux parisiensis, sia dall’Inferno di Dante. Basti pensare al componimento “Talor mentre cammino per la strada”, dove il mondo si svela come un luogo di detenzione, popolato da uomini condannati ad esistere: («Ché ciascuno di loro porta seco / la condanna di esistere»). I versi finali («E se poco ciò dura, io veramente / in quell’attimo dentro m’impauro / nel vedere che gli uomini son tanti») ricordano da vicino i versi danteschi di Inf III («ch’io non avrei mai creduto / che morte tanta ne avesse disfatta»); versi celeberrimi, che verranno, pochi anni dopo, citati da T. S. Eliot, uno dei più grandi poeti-dantisti del secolo, in The Waste Land, opera spesso salutata come inaugurale della poesia moderna (1922).
Altra tappa del dantismo primonovecentesco è la poesia di Clemente Rebora. Il poeta milanese si distingue per il grande espressionismo stilistico della sua lirica, caratterizzata da una violenza deformante, dove, come scrive Contini, il linguaggio tende alla «rappresentazione dell’azione invece che alla descrizione».
Un esito come questo è riconducibile alla presenza del magistero dantesco, sia quello delle «petrose», orientato a corteggiare la «verbalità del difficile» (sempre Contini), sia quello della Commedia, dove assistiamo, specie nella terza cantica, a un vero e proprio «vulcanismo glotto-poetico» (Mazzucchi). Come il Dante onomaturgo del Paradiso, impegnato a investire tutte le proprie risorse espressive per comunicare una metarealtà – in quanto tale incomunicabile –, anche Rebora è inventore di neologismi (i verbi parasintetici preceduti da in-, come “inombra”) nonché miscelatore di dialettalismi lombardi con voci della tradizione aulica, realizzando in questo modo le più audaci oltranze espressive.
Già da questi esempi possiamo misurare quella «maggiore solidarietà di noi moderni con il temperamento linguistico di Dante» di cui parlava Contini nel saggio dedicato a un’indagine preliminare del linguaggio volgare di Petrarca. Sempre un Dante petroso è quello che incontriamo nella poesia di Ungaretti e Montale (poeti considerati i campioni del dantismo novecentesco in Italia).
Nella poesia di Ungaretti (1888-1970) già ai tempi de L’allegria, diversi sono i richiami al Dante delle rime per Madonna Petra. È il caso della poesia “Sono una creatura” («Come questa pietra del San Michele / così fredda, / così dura / così prosciugata / [..] / Come questa pietra è il mio pianto che non si vede»), di grande tenore allegorico, in quanto dedicata al tema della mineralizzazione della vita emotiva; tema che rinvia alla canzone “Così nel mio parlar voglio esser aspro”. Diversi sono i dantismi situazionali della prima raccolta ungarettiana: la lirica eponima («E subito riprende il viaggio come dopo il naufragio un superstite lupo di mare») è organizzata intorno alla memoria della prima similitudine dell’Inferno dantesco («E qual è quei che con lena affanata / si volge intorno al pelago alla riva / e volge l’acqua perigliosa e guata»); gli ultimi versi de “La notte bella” («Ora mordo / come un bambino la mammella / lo spazio. / Ora sono ubriaco / d’universo») riconducono alla memoria i versi finali di Pd XXXIII in cui Dante si rappresenta come «un fante che bagni ancor la lingua alla mammella». Accanto a Dante non va trascurato, nel primo tempo della poesia ungarettiana, la presenza di Iacopone da Todi, che emerge nel fremito creaturale che domina questa poesia, un planh dedicato a ogni fibra creata.
Sia Iacopone sia Dante sono stati autori a lungo studiati da Ungaretti, che dedicò loro diversi saggi scritti nel periodo di insegnamento della letteratura italiana in Brasile.
A proposito delle raccolte successive (Sentimento del tempo, 1933 e Il Dolore, 1947) si è più volte parlato di una specie di «petrarchismo di ritorno»: una ripresa cioè di più consueti canoni formali ed espressivi (legati a fenomeni come il ritorno dell’endecasillabo o il ripristino della punteggiatura) che rappresentano un «mutamento di maniera» abbastanza rilevante rispetto alla prima produzione. Segnalo però, in una zona ancora successiva della poesia ungarettiana, quella della Terra promessa, la sestina “Recitativo di palinuro”, inevitabile richiamo a quella dantesca “Al poco giorno e al gran cerchio d’ombra”.
La poesia di Eugenio Montale (1896-1981) rappresenta forse il momento più alto del dantismo novecentesco in Italia. È molto forte la parentela, non solo geografica, ma anche linguistica, con Camillo Sbarbaro. Il paesaggio ligure, vero protagonista della prima raccolta, Ossi di seppia (1925), rappresenta un deposito inesauribile di emozioni liriche, raccontate spesso con parole dantesche. Recenti sondaggi intertestuali hanno svelato nell’idioletto lirico montaliano un forte timbro dantesco, che si denuncia in particolari scelte retoriche, nell’uso di sequenze rimiche, o attraverso citazioni dirette. Per offrire qualche riscontro testuale si pensi a una delle poesie più famose della raccolta, “Meriggiare pallido e assorto”, dove nella seconda strofa leggiamo: «Nelle crepe del suolo o sulla veccia / spiar le file di rosse formiche, / che ora si rompono e ora si intrecciano / a sommo di minuscole biche», versi che riprendono una famosa similitudine di Inf XXIX, contenuta in una terzina che presenta la medesima rima «formiche-biche». La stessa poesia esordiale, “In limine”, si apre su una memoria dantesca («Godi se il vento ch’entra nel pomario / ti rimena l’ondata della vita.») che rinvia a Inf XXVI (vv. 1-3: «Godi Fiorenza, poi ch se’ sì grande / che per mare e per terra batti l’ale / e per lo Inferno tuo nome si spande»). Nel secondo libro di versi, Le occasioni (1939), particolarmente interessante è la sezione costituita dai “Mottetti”, definita magistralmente un piccolo «Canzoniere d’amore risparmiato dal desiderio» (Garboli). Troviamo uno stilnovismo moderno, quasi d’en bas, caratterizzato da angeli femminili con le penne lacerate dai cicloni, causa voli transoceanici (cfr “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”). Diversi sono i dantismi lessicali, come nel mottetto “Non recidere, forbice, quel volto”, (una preghiera al tempo, di sapore petrarchesco, affinché – nella memoria che si spopola – protegga il volto della persona amata) dove l’explicit («nella prima belletta di novembre») contiene un lemma, «belletta», che rinvia a Inf VII («nella belletta dicon: tristi fummo»), passando attraverso la mediazione di un madrigale dannunziano di Alcyone («Nella belletta i giunchi hanno l’odore / delle persiche mézze e delle rose / passe, del miele guasto e della morte»). Ancora nel terzo tempo della poesia montaliana, quello della Bufera (1956) vari sono i dantismi situazionali, disseminati in poesie come “Primavera hitleriana” (la quale reca tra l’altro in exergo un verso di Dante da Maiano: «Né quella che a veder lo sol si gira») o “Piccolo testamento” (si pensi all’immagine dell’«angelo dalle ali di bitume» che scende sulla terra) che rappresentano la continuazione di un dialogo ininterrotto.
Chiudo questa ricognizione con alcune considerazioni intorno al dantismo di Mario Luzi, (1914-2004), alfiere della cosiddetta poesia ermetica. Egli esordisce nel 1935 con la raccolta La Barca, incunabolo tematico e linguistico della nuova poetica di orientamento simbolistico, dove qualcuno ha notato spunti che vengono dallo Stilnovo (come nel componimento “Alla vita”, dove l’immagine dei poeti-amici riuniti in una medesima barca rinvia senza troppa difficoltà a quella del sonetto “Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io”). È alla fine degli anni ’40, con Quaderno gotico, che emerge, sin dal titolo, il desiderio dell’autore di restaurare archetipi medioevali. Si tratta di una raccolta di 14 poesie che racconta, in forma lirica, un susseguirsi di emozioni amorose, accadute in un tempo che è «un barbaglio / di là dal gelo eterno». Il tema, squisitamente stilnovistico, della epifania della bellezza femminile, torna in questi versi coniugato con ricordi più recenti provenienti da Mallarmé e dalla tradizione del simbolismo. Nella poesia luziana molto forte è l’interesse verso la seconda cantica dantesca, la riscoperta della quale è un fenomeno in parte novecentesco; diversi sono i momenti della sua poesia caratterizzati da atmosfere purgatoriali, come nella lirica “La Notte lava la mente”, dove troviamo tracce di topografia purgatoriale: «La notte lava la mente. / poco dopo si è qui come sai bene, / fila d’anime lungo la cornice. / Chi pronto al balzo, chi quasi in catene». Non vada trascurato inoltre il lavoro teatrale di Luzi proprio intorno al Purgatorio, insieme a quello fatto, per la prima cantica, da E. Sanguineti, e, per la terza, da G. Giudici. La fortuna novecentesca del testo dantesco, già così profonda nella prima parte del secolo, conosce, successivamente, importanti stazioni nell’opera in versi di Giorgio Caproni (specialmente nel Seme del piangere), nelle Ceneri di Gramsci di Pier Paolo Pasolini, fino alle più recenti esperienze dell’avanguardia. Invito a ripensare a questa vicenda tenendo a mente le parole del poeta russo Osip Mandel’štam, il quale parla dei canti della Commedia come di «proiettili scagliati verso il futuro, che esigono un commento ad futurum».