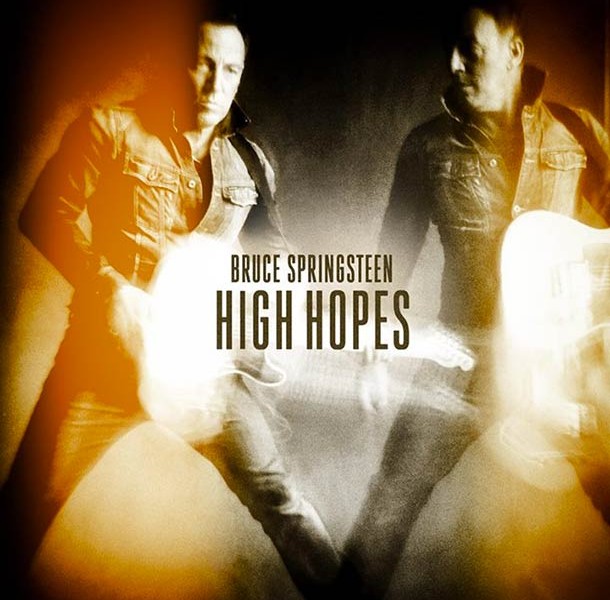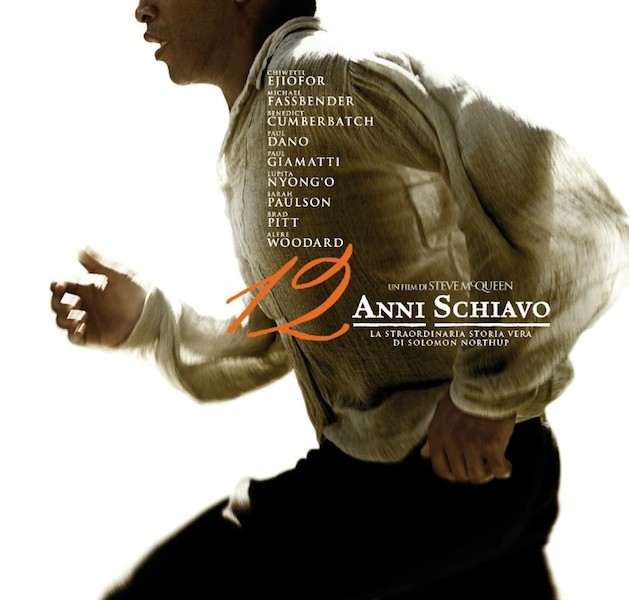Amore come modo di esprimersi, di raccontarsi; amore come istante che dura un’eternità o forse un secondo solo. Amore bastardo, cattivo, tenero, affettuoso, curioso, malsano; amore malato. No, questo no.
L’amore non si cura con la citrosodina di Alessandra Racca (Neo, 2013) mette in disordine composto i pezzi di cuore sparsi nelle nostre vite, dà loro una logica comprensibile per chi nell’amore ci crede, per chi d’amore ha sofferto, per chi ancora ne soffre e per chi ne dovrà soffrire. Non una cura ma una piccola magia. Come quella della citrosodina che solleva dallo stomaco i pesanti effetti di una cena sostanziosa.
D’altronde, si dirà, chi non ha sofferto per amore? Eppure la realtà dimostra che nella moltitudine di esseri viventi colti da questo irrefrenabile impulso, l’impulso ad amare, quelli che somatizzano o che costruiscono mondi interi attorno a un gesto o a una persona, quelli che cercano di farli scivolare via come fossero scartoffie ma non ci riescono, be’, non sono poi così tanti.
Perché l’amore porta conseguenze a lungo, lunghissimo termine, che non si possono controllare. Le persone che ami, o quelle che hai amato, o quelle che amerai, spuntano e rispuntano fra una metro e l’altra, da una città all’altra, fra una camicia e un caffè, un ricordo e un libro. E tu non puoi farci niente. Sei destinato a ritrovartele lì, come le bomboniere inutili dei matrimoni spolverate da tua madre, quando ha tempo:
Non è gentile nemmeno di domenica
appena sveglia mi salta addosso
e domanda: Allora sei felice?
Lo ami?
Sei quello che volevi essere?
Sai chi sei?
Non ho un animo gentile mai
mentre scrivo, attaccato all’ultimo verso
soffia come un gatto.
Smettila di fare trucchetti
hai ancora qualcosa da dire,
un briciolo di onestà?
La poesia di Alessandra Racca nasconde una persona, un ricordo, un dolore, quindi un amore, che non si trova, che non si cura, che non si spiega. Nel farlo, però, ci svela i segreti delle nostre vite. Che sia davanti a uno specchio o davanti a una pagina di questo libro, non importa. Il continuo misurarsi dell’uomo con gli altri, col suo passato, col suo presente e col suo futuro, avviene sempre, o quasi, attraverso il sentimento dell’esperienza d’amore. Ed è inutile cercare rifugio nel fluire quotidiano degli eventi. Si ama quando non si è, si ama quando si è stanchi, quando si è fermi. Si ama nei minuti che passano quando tu non te ne accorgi, magari davanti a
un paio di scarpe vecchie – e ci si innamora –
del loro modo di assecondare il mio particolare
camminare
Con carattere deciso e leggero, i testi di L’amore non si cura con la citrosodina saltellano fra le emozioni singolari di chi scrive, attraversano suoni teneri, briosi, scottanti, amari eppure mai volgari o eccessivi; semplicemente veri.
Le pagine cambiano colore, su di esse vivono le stagioni, le città, i paesaggi; le coccole di un padre, i frammenti di vita di una madre, le serate degli amici e dei sorrisi, gli incontri, la musica; i riti del paese e le abitudini di un nonno.
Ogni cosa è al posto giusto e ogni parola resta all’interno di una bolla che non scoppia; l’amore non si cura con la citrosodina, non è un mal di stomaco, non è un fastidio. L’amore, quando si sposta da una parte all’altra del tuo corpo, spesso ti ferisce e non ti fa dormire. Meno spesso come un analgesico ti addolcisce la pena. Ma l’amore è sempre lì, per chi lo sa e non sa nasconderlo:
“L’amore è come la poesia (certe volte non si capisce)”
L’amore amore mio non si può fare in prosa l’amore
è come la poesia e noi amore mio ad un certo punto
anche se non c’era il punto
siamo andati a capo.
(Alessandra Racca, L’amore non si cura con la citrosodina, Neo, 2013, Euro 10)