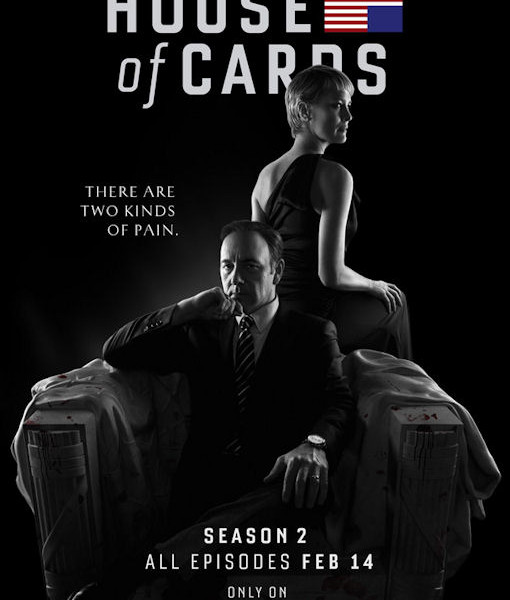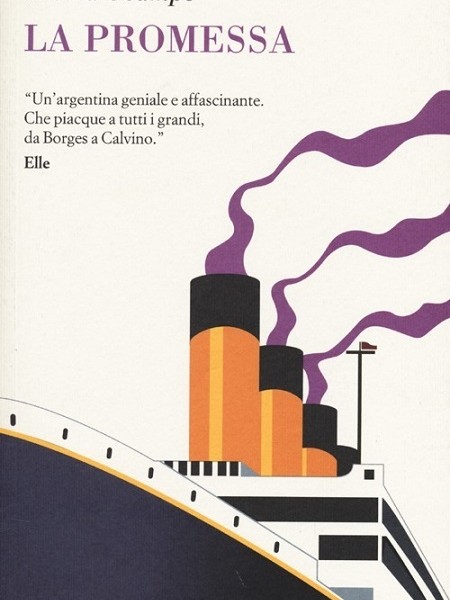Roma chiama a raccolta una composita schiera di alchimisti sonori, cavalieri erranti, mistici e apprendisti stregoni che, armati di manipolatori sonori, occupano la chiesa evangelica metodista di via XX settembre per cinque piovose serate all’insegna della sperimentazione musicale.
Tra indagini sul linguaggio e musica pittorica, slanci prometeici e specchietti per le allodole, quest’anno Chorde, festival organizzato dal Lanificio 159, si presenta come una nebulosa magmatica a suo modo coesa e coerente: non più serate sparse ma un intero blocco interamente dedicato alla musica sperimentale e d’avanguardia. Quello proposto al pubblico è un viaggio inteso come rifiuto metodologico dello status quo, costellato diazioni artistiche il cui esito è sconosciuto e che giustificano sé stesse unicamente attraverso la non accettazione di un obiettivo condiviso.
Ma come Itaca per l’Ulisse di Kavafis, la meta, in fin dei conti, non è poi così importante. La novità forte della proposta è quella di creare un ambiente condiviso da artisti e pubblico per la fruizione di espressività musicali insolite: Chorde diventa così uno spazio musicale che si pone al di là del conosciuto, oltre le colonne d’Ercole dell’abitudine, del consueto e del quotidiano, alla ricerca di tutte quelle musiche che ancora non ci piacciono ma che sono pronte per farsi amare.
I. Unicum: gli abissi del non-linguaggio
Assemblati per una serata unica, Roy Paci (tromba), Thurston Moore (chitarra), Andy Moor (elettronica) e Yannis Kyriakides (chitarra baritona) si ritrovano ad essere Unicum, progetto di musica improvvisata che nasce e muore in una sola serata appositamente per l’inaugurazione di Chorde.
Quel che viene dato in pasto al numeroso pubblico è un banchetto pantagruelico di suoni e rumori che presto si dimostrano, come l’idea stessa, senza capo né coda. Il problema di questo sciabordio di suoni non sarebbe neanche l’assenza totale di un linguaggio, che costituirebbe già di per sé un’unità discorsiva chiara e, a suo modo, coerente. Il problema sorge in quanto i percorsi sonori proposti dai quattro musicisti non si intrecciano mai tra di loro. Sono storie che non dialogano, insiemi complessi ma a sé stanti, che non intessono relazioni né tra loro né, tanto meno, con il pubblico. Gli ostinati monologhi proposti inscenano un continuo e disarticolato cambio di registro linguistico, si sovrappongono senza integrarsi, finendo per assomigliare a un convivio di ubriachi che, all’ennesima bottiglia di buon vino rosso d’annata, s’intestardiscono ognuno nel suo discorso senza curarsi di quel che dice il compagno seduto a fianco.
Non che gli spunti non siano presenti, sia chiaro: questi, però, sembra rimangano come sospesi in aria, simili a sincere promesse non mantenute. Roy Paci si lancia in fraseggi di sapore nordico, lunghe note effettate che ricordano le sonorità oceaniche del trombettista norvegese Nills Petter Molvaer, mentre Kyriakides esibisce un rumorismo abbastanza educato, notevole nei voli solisti ma poco orientato all’inter-play. Quel che maggiormente manca all’appello è soprattutto l’elettronica di Andy Moor, che dovrebbe, in un contesto di questo tipo, operare da fattore coagulante e risulta una semplice eco lontana e senza mordente. Thurston Moore spicca tra tutti per inventiva ed originalità, proponendo il suo stile ormai solidificato basato su un’improprietà di linguaggio unica e inimitabile. Si sente, però, la mancanza del supporto della gioventù sonica alle sue spalle: Moore appare così impacciato, quasi un pesce fuor d’acqua.
Una serata nata con l’intento di essere unica finisce per difettare proprio nella sua idea originale, producendo una performance senza spessore, senza passato né futuro. Alla fine si esce con l’amaro in bocca dell’insoddisfazione, coscienti che si sia semplicemente timbrato un cartellino, applaudendo per la storia dei protagonisti, non per l’esibizione ascoltata.
II. Cloud Boat: elettro-soul di un discorso amoroso

La seconda serata di Chorde presenta il duo britannico Cloud Boat, formato da Sam Ricketts e Tom Clarke. L’esordio dello scorso anno, Book of Hours (Apollo, 2013), è uno di quei classici esempi di una musica in cui non c’è nulla di nuovo tranne la musica in questione. I Cloud Boat non inventano assolutamente nulla, ma tutto quello che fanno lo fanno incredibilmente bene, con uno stile dolce e raffinato.
La musica proposta, infatti, vive di un raro equilibrio raggiunto tra le diverse forme musicali che contribuiscono alla costruzione del discorso nella sua interezza: lo stile chitarristico è tanto semplice quanto efficace, con soluzioni sonore dilatate nello spazio e nel tempo, per certi versi vicine al post-rock dei Tortoise di Millions Now Living Will Never Die (Thrill Jockey, 1996) e TNT (Thrill Jockey, 1998) . Sono trame e tessuti pregiati, intrecciati su un’elettronica soffice e soffusa, che dipinge grandi tele di colori tenui, inframezzati da incursioni dubstep. Su tutto svettano le melodie delle voci: timbriche tipiche di un soul bianco che rimanda direttamente al canto di Mark Hollis nei primi dischi dei Talk Talk, in particolare The Colour of Spring (EMI, 1986) e Spirit of Eden (EMI, 1998).
È un cantautorato moderno da cieli grigi e mari agitati: una musica a tratti filmica, che vive di un accompagnamento umbratile, foschie elettroniche e melodie vocali che schiariscono il tutto, come un raggio di sole che filtra tra le basse nuvole inglesi. La proposta musicale, come dicevamo, non è certo rivoluzionaria né sconvolgente: ma risulta pienamente, nonché piacevolmente, compiuta in sé stessa e comunica una bellezza che colpisce l’ascoltatore per la sua immediatezza fisica. Una musica fatta di ornamenti, che accompagna, consola e concilia, che evolve rimanendo immobile: un discorso d’amore in salsa elettro-soul.
III. Hauschka: l’immaginazione al potere
Hauschka, al secolo Volker Bertlemann, porta in scena nella terza serata di Chorde la sua performance per pianoforte preparato. Con il suo volto gioviale e sereno, Hauschka interagisce volentieri con il pubblico, spiegando e soffermandosi spesso sul funzionamento delle sue molteplici diavolerie musicali.
La tecnica è semplice quanto geniale, sia negli intenti che nei risultati. Nelle mani di Hauschka, che riprende una tradizione colta che risale a Erik Satie e a John Cage, il pianoforte, strumento perfetto per antonomasia, viene perfezionato ancor di più mediante l’introduzione al suo interno di un imprecisato e variegato numero di oggetti, che modificano strutturalmente la sonorità tipica dello strumento in questione: lastre metalliche, chincaglierie assortite, collanine di legno e gusci di conchiglie, carabattole e ninnoli vari, persino palline da ping-pong che, quando sollecitate, saltano ovunque regalando sorrisi divertiti in platea. Il principe degli strumenti si fa così re, acquisendo una dimensione ritmico-percussiva tanto insolita quanto affascinante.
Il pianoforte diventa una piccola orchestrina ritmica impazzita, che svicola abile tra scherzi, giochi e dotti rimandi accademici. Come avrete capito non è certo un tradizionale concerto per pianoforte quello a cui si è assistito, bensì, come afferma lo stesso Hauschka, il tentativo di suonare la disco-music con il pianoforte. Diciamo che il risultato non sembra propriamente musica da discoteca, ma forse è molto meglio così: si assiste infatti a ottime composizioni per lo più di natura percussiva, all’interno delle quali la tipologia, la quantità e la qualità dei suoni emessi sorprendono a ogni battuta.
Una musica che lascia quindi stupiti e divertiti. Hauschka porta avanti la tradizione colta della provocazione nei riguardi dell’inviolabilità degli strumenti classici, portando al potere l’immaginazione estrosa di artisti-artigiani che inventano suoni là dove nessuno li andrebbe a cercare.
IV. Emptyset: astrattismo pittorico-musicale
Allievi virtuali del maestro Alva Noto, gli Emptyset allietano la quarta serata di Chorde, suonando tecnologie assortite davanti ad uno schermo che proietta astrattismi visuali in continua evoluzione. A dominare la scena è un’atmosfera algebrico-musicale: anche se dovrebbe essere teoricamente privo di elementi, questo insieme vuoto è invece il frutto dell’incontro di giovani talenti inglesi di stanza a Bristol con l’elettronica di marca tipicamente tedesca, densa di rumori cibernetici e inserti glitch.
Siamo chiaramente nel campo degli imitatori, senza nessuna accezione negativa ovviamente. Imitatori nel senso che si registra un approdo leggermente in ritardo a forme musicali già sperimentate e perfezionate negli anni passati dallo stesso Alva Noto, da Mark Fell e da William Basinski.
L’obiettivo è quello di rivitalizzare questa micro-elettronica con ingombrante cassa in tempi dispari, ma aggiungere qualcosa al genere è decisamente compito arduo. Gli elementi del discorso sono sempre i medesimi, assemblati con diligenza e proprietà di linguaggio. La lezione è stata bene imparata, su questo non c’è nulla da ridire: la techno è minimale, certosina, condita da rumori bianchi posizionati su loop ciclici elevati a forma d’arte.
La rivoluzione stavolta non è stata neanche tentata, né tanto meno immaginata. Ma il risultato è una convincente sonorità per ambienti cibernetici, astrattismo pittorico-musicale di una forse già passata post-modernità tecnologica.
V. Teho Teardo e Blixa Bargeld: l’ala oltranzista della tradizione

Ribellarsi è giusto: ma bisogna saperlo fare bene. Imparare a farlo è il compito di una vita. Una vita come quella di Blixa Bargeld, vecchio ribelle del terrorismo sonoro europeo che interpreta per la serata un non meno rivoluzionario personaggio di filosofo gentiluomo, teatrante d’altri tempo nel suo immancabile completo nero. Compagno di viaggio è Teho Teardo, compositore maestro degli incroci e degli incastri, che si muove con abilità tra quartetti d’archi, chitarra baritona, spunti classicheggianti e inserti elettronici.
Sembra che la stessa struttura fisica e morfologica dei due protagonisti prepari e suggerisca la perfetta simbiosi musicale raggiunta. I due si compensano e completano a vicenda. Blixa è statuario, carismatico, affascinante. Il suo è un linguaggio che risiede nella corporalità, nei gesti e nell’espressività del volto e che solo in un secondo momento si concretizza in suoni, siano essi una lingua – inglese, tedesco o italiano – , un urlo acuto o un verso gutturale. La sua è un’espressività composita e variegata come un vestito d’Arlecchino. Teardo, da parte sua, somiglia a un figurante della commedia d’arte, che muove il suo corpo senza freni né inibizioni, oscillando al tempo delle sue composizioni e quasi dirigendo le medesime con il suo stesso esserci.
Infine – si fa per dire, è ovvio – la musica. Quello presentato ufficialmente stasera in anteprima è il nuovo EP, Spring!, la cui uscita è prevista in primavera, e che conterrà due brani inediti, oltre a una cover di Caetano Veloso – una “The Empty Boat” che viene splendidamente stravolta in una bossa nova europea e stralunata – e “Soli si muore”, versione italiana del 1969 di “Crimson and Clover”.
La gran parte della serata, però, scorre sulle note dei brani dell’acclamato album dello scorso anno, Still Smiling (Specula Records, 2013). Supportati da un intero quartetto d’archi e dal violoncello di Martina Bertoni, Teardo e Bargeld mettono in scena uno spettacolo intenso, dove le emozioni si fanno tridimensionali. Le corpose pennellate d’archi trascinano e incantano, mentre il sostrato elettronico interagisce con naturalezza con gli spunti classicheggianti: tutto è in perfetto equilibrio e ruota intorno al centro gravitazionale permanente rappresentato dalla profonda voce baritona di Blixa Bargeld che riempie fisicamente la distanza con il pubblico, creando una comunanza d’intenti tra ascoltati e ascoltatori.
Quella proposta è autentica musica d’avanguardia: è l’ala oltranzista della tradizione, che si appoggia sul passato per slanciarsi nel futuro, rendendo magica l’atmosfera della chiesa e chiudendo Chorde 2014 con quel particolare senso di malinconica ma al tempo stesso ironica dolcezza che viaggia da un paio d’anni tra i cieli di Roma e Berlino.