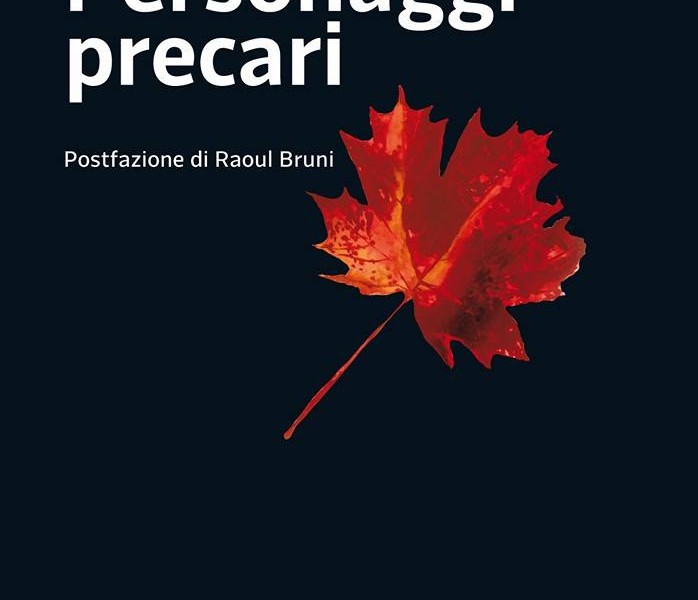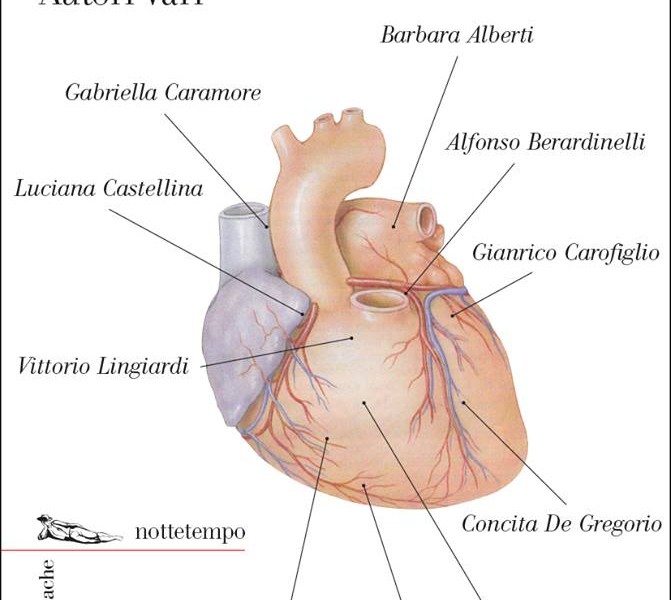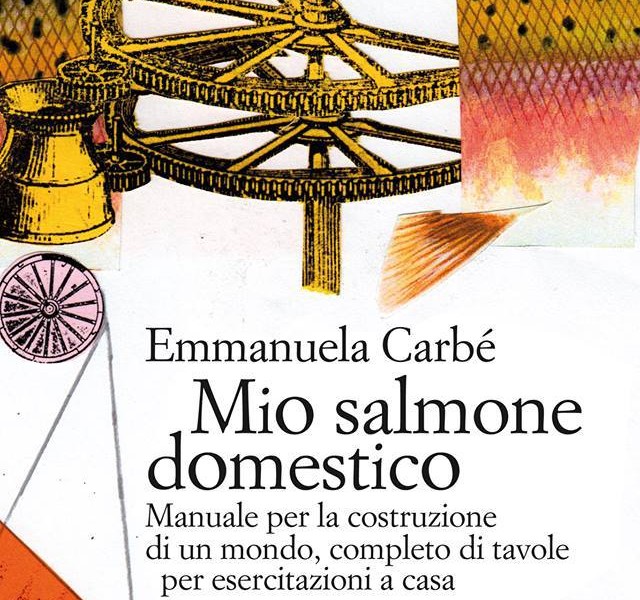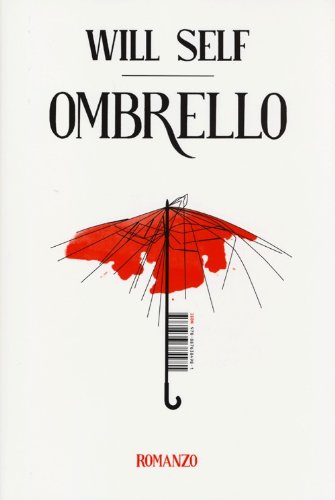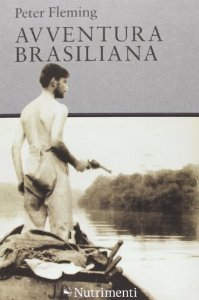Dopo film, libri, spettacoli, canzoni, saggi, disquisizioni dotte e lezioni di economia sul precariato, il tratto dominante di questo nuovo millennio ecco che si chiude il cerchio: non solo storie di precariato, ma Personaggi precari, l’ultima pubblicazione di Vanni Santoni (Voland, 2013).
Ad aprire questo libro la prima impressione è di confusione. Quasi non c’è testo, sembra un copione teatrale, sembrano citazioni, sembrano commenti estratti da un blog. La lettura della prefazione è fondamentale e da lì si scopre che quello di Personaggi precari è un esperimento che Vanni Santoni porta avanti, con grande fortuna, dal 2004 e che le prime impressioni non potevano essere più sbagliate.
«I personaggi offerti da Personaggi precari», leggiamo, «sono disposti ad apparire indifferentemente in commedie, racconti, cortometraggi e lungometraggi, giochi di ruolo, serial tv, atti teatrali tradizionali e sperimentali, cartoni animati, romanzi, fumetti, trasmissioni radio e telefilm. […] I personaggi offerti da Personaggi precari sono pienamente consapevoli della propria condizione di soggetti flessibili, atipici, interinali, sostanzialmente precari, e perciò non opporranno alcuna obiezione di utilizzo pur di lavorare».
Poche righe ed ecco quindi che emerge il senso che, sulle prime, era impossibile cogliere. Aprire questo libretto diventa l’equivalente dell’essere dei supereroi in grado di entrare in una stanza piena di gente e cogliere, in un istante, un fatto, un aneddoto, un tratto caratteriale, un dettaglio in grado di inquadrare la persona, di situarla e descriverla nella sua essenza.
L’effetto di questo esperimento è un gradevole straniamento. Il lettore, che si aspettava una lettura leggera e scorrevole, si scopre a dover impegnare attenzione e concentrazione per poter cogliere tutti i dettagli, detti e non detti, che l’autore concentra in poche righe con la forza di un raggio laser.
Eppure, dopo aver voltato l’ultima pagine, oltre al ricordo affilato di alcuni personaggi resta un interrogativo: sentivamo davvero il bisogno anche di “personaggi” precari?
Come alla fine di un contratto a tempo determinato ci sentiamo, infatti, un po’ orfani: di noi il personaggio non ha avuto niente, non si è fatto in tempo a “formarlo” con la nostra passione di lettori, di investirlo di significati, e anche noi non ne abbiamo tratto niente perché, per quanto essenziale, il carattere che cogliamo rimane, necessariamente, monco e parziale. In un mondo instabile forse abbiamo bisogno ancora che la narrativa ci dia qualche sicurezza.
(Vanni Santoni, Personaggi precari, Voland, 2013, pp. 157, euro 13)