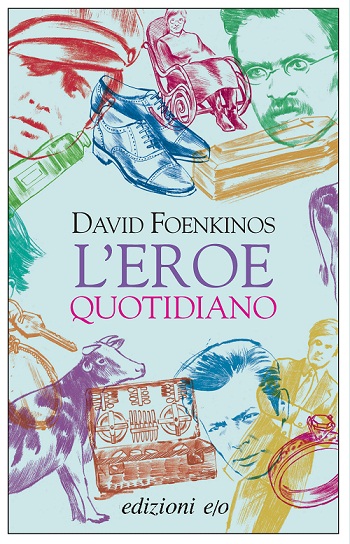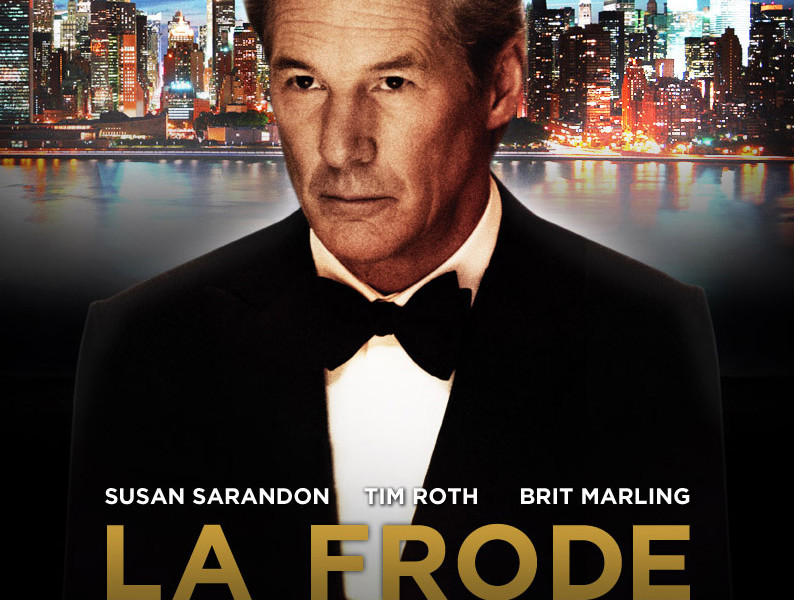Oltre Porta Pia, passeggiando tra piazza Fiume e la Nomentana, accanto al Macro, il museo d’arte contemporanea e punto d’attrazione di uno dei quartieri più eleganti di Roma, capita di “incontrare” una libreria e di rimanerne incantati. Capita perché solo se la conosci ti accorgi di quella vetrina sempre curata, che riflette (e nasconde) le installazioni degli artisti del nuovo millennio che spesso spuntano dall’altro lato della strada.
Se è vero che via Reggio Emilia è l’avamposto della mostra, è ancora più vero che per chi vuole perdersi tra quegli odori e quei sapori antichi che solo i libri sanno offrire è qui, in questo luogo dalla luce garbata e pacata, che bisogna fermarsi.
C’è un’insegna in alto, nobilitata dal tempo, che ti dice dove sei: L’argonauta, libri per viaggiare.
Luogo indiscusso di viaggi, reali e virtuali (quelli del lettore), se apri quella porta sei costretto a partire per mete ancora da decidere.
Ti accolgono il sorriso delle due proprietarie (Cristina e Valentina, ormai storiche “padrone di casa”), l’arredamento coloniale, una musica di sottofondo, cartine e stampe geografiche, un pianoforte al lato della sala più grande e grosse librerie in legno (di quando Ikea non aveva ancora disinnescato la nostra idea di bello) che contengono centinaia di libri.

Come se non bastassero mappe e mappamondi si potrebbero osservare i dorsi o le copertine dei volumi per capire che l’Argonauta nasce e si sviluppa come libreria specializzata in viaggi.
Ma è limitativo. Perché, come spiegano benissimo le animatrici di questo luogo di rara bellezza, «l’idea di rilevare una libreria nacque un po’ per caso, accomunando la passione per i libri e per i viaggi di due amiche allora nemmeno trentenni; passioni che continuano a essere il motore di questo spazio, che si è pian piano trasformato in un vivo centro culturale, grazie alla costante organizzazione di eventi, presentazioni, concerti e manifestazioni».
Più che il viaggio, è l’indipendenza il leitmotiv che racchiude il senso della libreria.
Indipendenza su tutto e da tutto: dalla sedentarietà, dall’immobilismo, dal gusto omologato dei “book store”, dalle violenti leggi di mercato, dall’editoria di “regime”, dal lamento continuo di chi crede che a trent’anni non si possa creare un’attività al tempo stesso funzionale e di qualità.
Largo spazio è dato agli editori indipendenti che, come le ragazze della libreria, non vogliono sottostare ai ricatti delle grandi catene librarie e distributive.
Il lavoro che hanno portato avanti Cristina e Valentina dal 2009 (la fondazione della libreria risale invece al 2002) e che continuerà, è stato quello di modificarsi costantemente, specchiandosi in altri settori e andando ad ampliare il concetto di “viaggio”, conducendolo ad un’idea di “percorso” esistenziale.
La divisione per continenti ci inserisce in una dimensione “universale” ma, man mano che guardiamo bene, capiamo che si tratta soltanto di contenitori di qualcosa di più grande.

In un continuo salto tra globale e locale l’occhio non può non cadere sui libri dedicati, per esempio, alla nostra città, una Roma che si traduce in volumi d’architettura, in raccolte di poeti dialettali, in stradari, in guide dei locali alla moda, in romanzi più o meno conosciuti.
Si viaggia con le gambe e col pensiero. Si viaggia pure con la gola, con il gusto: ampio spazio è dato, infatti, anche al settore gastronomico, regionale e internazionale. E con i sogni: quelli dei bambini, potenziali lettori di domani, a cui sono dedicati spazi ed iniziative.
Quando si va all’Argonauta si trovano spesso molti amici, legati dal comune amore e dalla comune passione per la carta stampata. Amici che sono qui a presentare i loro libri, a suonare, a ballare, a discutere e, troppo spesso, a mangiare. Amici che si ha la fortuna di conoscere, amici che si sono soltanto “letti” o “ascoltati”, amici persino che si ha la fortuna di incontrare in quel determinato momento. Amici che si chiamano Dacia Maraini, Luciano Violante, Folco Quilici, Edoardo Bennato, Gianrico Carofiglio, Emanuele Trevi, Giuseppe Aloe e portano il nome di tutte le persone che in questi anni sono passati per qui. Amici che si chiamano Cavallo di Ferro, Nova Delphi, Giulio Perrone, Ensemble, Lozzi, Il lupo e che portano il nome di tutte quelle case editrici emergenti di cui troviamo qui i libri.
Per un evento che passa, altri ne arrivano. E allora, se capiterà di passare di qui nei prossimi giorni, non potremmo perderci, giovedì 14 Marzo alle 18.30, la presentazione del libro Addio a Roma, di Sandra Petrignani, che, insieme a Barbara Alberti ci porterà a spasso tra gli anni Cinquanta e Settanta in una città intellettualmente ricca, tra Pier Paolo Pasolini, Palma Bucarelli, Elsa Morante, Giorgio De Chirico e Natalia Ginzburg.
Non prendete impegni, infine, per il fine settimana del 22 e 23 Marzo prossimi. Si terrà infatti la seconda edizione di Libri in Onda, una manifestazione dedicata all’editoria indipendente, dove importanti case editrici quali minimum fax, Voland e Giulio Perrone Editore si affiancheranno a case editrici più piccole ma altrettanto valide, proponendo al pubblico l’intero catalogo con uno sconto del 10%, incontri con gli autori, firma copie e molto altro. Un modo per passare delle giornate e delle serate diverse, tutti insieme come se libreria e editori, autori e lettori, fossero dei soggetti unici, coraggiosi, intraprendenti. O, probabilmente, dei veri e propri argonauti del nuovo millennio.