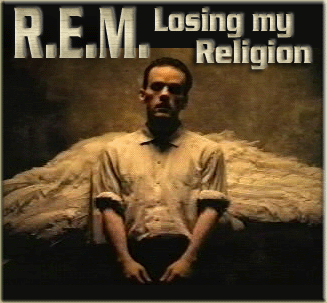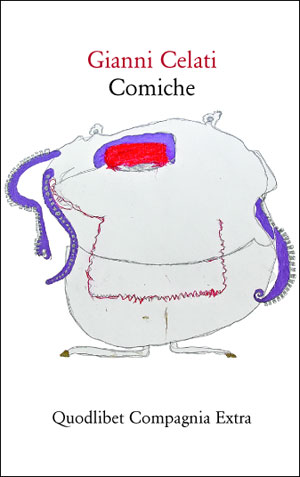«Lui non aveva nessun canone. Era questa la sua forza». Questa la semplice ma efficace definizione di Dario Fo, in un’intervista sul Maestro del cinema: Vittorio De Sica. È stato il militare gentiluomo, il giocatore d’azzardo, il giudice o l’avvocato e questa mostra ha l’intento di ripercorrere tutti i suoi personaggi. «Mio padre era un uomo molto semplice», ma anche «un insoddisfatto totale», le voci dei figli a riguardo, sugli schermi.
Cantante, uomo di teatro, poi attore di cinema e regista. «A wonderful man called… Vittorio!», dice la dedica sulla foto della premiata attrice di Stazione Termini, Jennifer Jones. «La gente lo adorava, anche la troupe e tutti gli altri», afferma Clint Eastwood. Un personaggio più in voga di Totò e di Alberto Sordi, se si contano le visualizzazioni sulla scena: il primo divo italiano comparabile alle stelle del cinema internazionale, al pari di Gary Cooper o Hans Alberts.
Queste sono le mille sfaccettature di Tutti De Sica che ha visto, durante la tanto acclamata inaugurazione del 7 febbraio, oltre alla massiccia partecipazione di tv e giornali, la presenza dei tre figli Manuel, Christian ed Emi. Questa esposizione fa parte di una serie che ha già visto in mostra altri grandi del cinema italiano come Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini e Sergio Leone, ideata da Equa di Camilla Morabito. Il risultato è assolutamente interessante, arricchito dalla collaborazione della Cineteca di Bologna. I materiali, diversi e numerosi, provengono dalle collezioni private e dagli archivi, tra cui, per la prima volta reso pubblico, quello personale di Giuditta Rissone-Emi De Sica, che comprende album di famiglia e oggetti personali.

Il percorso, lungo e vario, accoglie i visitatori in un corridoio dalle pareti rosse, che ricorda il red carpet, in cui sono incorniciate diverse stampe originali di Vittorio De Sica bambino e i suoi primi esordi sul palcoscenico, durante gli anni Trenta. Tra le foto di famiglia e i filmati dell’inizio della sua carriera, ecco esposte quattro parrucche del periodo teatrale, quando collaborò con Pirandello in Liolà.
«Io», diceva, «sono nato e rinato alla vita artistica almeno cinque volte».
Cantante e attore di rivista, è negli anni Trenta, che matura l’idea di rinunciare a esprimersi in una sola arte e decide di diventare anche un regista. Così, con il debutto e il primo film da teatrante, nel ’31, Gli uomini… che mascalzoni!, Mario Camerini ne adocchia l’innato talento. Prima di esordire nella regia, nel 1940, De Sica interpreta trenta film, in un tour de force di personaggi e di cambi d’identità. Da subito si spaccia per bravo ragazzo ma in realtà è spesso un simpatico mascalzone: l’emblema è naturalmente Il signor Max, firmato da Mario Camerini nel 1937, del quale è esposto un corredo fotografico che ricostruisce l’intero film, così come i documenti d’epoca di un lancio promozionale in pieno stile hollywoodiano.Quando diventa regista, lavora su i suoi attori plasmandoli, si identifica con tutti, trova e ne condivide le ragioni, i sentimenti e ne assimila i punti di vista. Un indiscusso padre del Neorealismo, in Sciuscià, in cui guarda il mondo con gli occhi dei bambini e in Ladri di Biciclette, di cui è esposta la bicicletta Bianchi più famosa del cinema, utilizzata per il film da Lamberto Maggiorani.

Viene evidenziata anche la collaborazione con le più grandi bellezze degli anni Cinquanta, come Sofia Loren e Gina Lollobrigida, e il sodalizio con Zavattini, di cui è filmata e offerta una passeggiata sugli Champs-Elysées.
Amante delle camminate, delle riprese per strada, della vita quotidiana e della risata spontanea, De Sica ha affascinato il mondo, con il suo garbato ed elegante stile, con il suo profilo e il suo cappotto pied de poule grigio, di cui tutti noi ne assimiliamo ancora il ricordo.
Una Roma che non lo ha mai celebrato abbastanza, come avrebbe dovuto, dona al grande artista un importante tributo, con una galleria espositiva ricca ed elegantemente offerta al pubblico, romano e internazionale.
Tutti De Sica
Museo dell’Ara Pacis, Lungotevere in Augusta, Roma
8 febbraio-28 aprile 2013
Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.arapacis.it