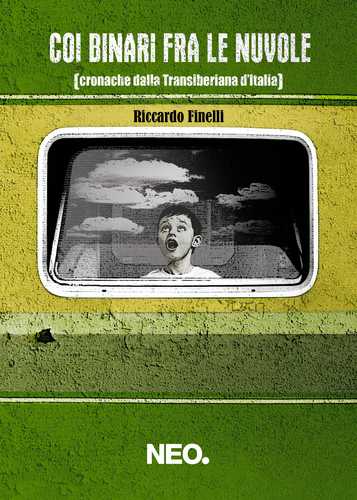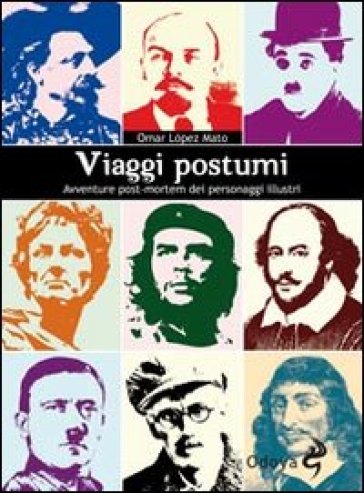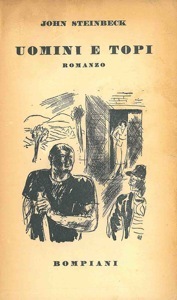Fenomenologia di YouPorn (Miraggi edizioni, 2012) porta a galla una domanda che, solo superficialmente, può risultare banale: com’è cambiato il nostro rapporto con la pornografia?
«Perché la trasgressione abbia successo occorre che si disegni su uno sfondo di normalità. […] Pertanto se Gilberto deve prendere l’autobus e andare da A a B, si vedrà Gilberto che prende l’autobus che va da A a B. Questo irrita sovente gli spettatori, perché essi vorrebbero che ci fossero sempre scene innominabili. Ma si tratta di una illusione. Essi non sosterrebbero un’ora e mezzo di scene innominabili, Quindi i tempi morti sono essenziali». Queste parole di Umberto Eco tratte dal Secondo diario minimo descrivono, sostanzialmente, cosa avviene in un film porno. L’attesa snervante, l’irritazione, la noia, che separa lo spettatore dalle «scene innominabili».
Tutto ciò, nel mondo di YouPorn, e delle centinaia di siti nati in seguito, non esiste più. Il punto di partenza è il video privo di questo aspetto. Dai film porno ai filmati porno. Nella maggior parte dei casi (qui le categorie e, di seguito, le sottocategorie e, ancora, di riflesso, la terminologia che ne è derivata e che è andata diffondendosi, giocano un ruolo fondamentale: la sezione «Vintage», per esempio, dà la possibilità allo spettatore di vivere quest’esperienza come-una-volta: attese, chiacchiere superflue, excursus su storie parallele sostanzialmente prive di senso, azioni completamente inutili da parte di uno o più attori), è tutto già pronto. Istantaneamente. I protagonisti non aspettano più, non trainano più lo spettatore verso l’atto – magari ci si può imbattere in una chiacchierata piena di doppi sensi tra la dottoressa e il paziente, o nella presentazione di una giovane finta ingenua americana durante il suo casting –, non c’è più un pre all’arrivo nel fienile, verso il momento in cui lei comincerà a togliersi la salopette o a sbottonarsi la camicia lasciando intravedere una micro sezione dell’alone del capezzolo – si parte da un presupposto: la pornografia ha, da sempre, una visione di sé prettamente maschilista, il fatto che l’oggetto della sua materia sia la donna – tramite un climax ai limiti dello sfinimento.
Di fondo, è il rapporto tra lo sviluppo delle tecnologie e l’uomo da un punto di vista pratico, meccanico. Da una parte, il singolo Vhs, la collezione di Vhs, magari, e il videoregistratore o, nel peggiore dei casi, la televisione; dall’altra il computer, internet e il suo essere (quasi) infinito. In passato, infatti, la possibilità di eliminare le parti non interessanti poteva avvenire unicamente attraverso un’opzione del registratore: Forward (l’opzione Rewind era sfruttata solo se si andava troppo avanti rispetto alla scena in questione oppure se la scena in questione era particolarmente apprezzata). Al di fuori di questo, partendo, ad esempio, dai film e dalle réclame sulle reti private che andavano in onda la notte, il nulla. Questa opzione, sfruttando il cursore in basso al video, è rimasta. Dal particolare che ci viene proposto, possiamo inoltrarci ancora più nello specifico, sezionando sempre più a fondo il filmato che abbiamo di fronte, in un gioco di matrioske potenzialmente infinito.
Un esempio di questa distanza tra la volontà dell’individuo e l’assenza di supporti tecnologici, per quanto possa sembrare decontestualizzato, può essere estrapolato dalla graphic novel di Joe Matt, Al capolinea, dove il protagonista, Joe Matt stesso, forse involontario lungimirante, passa intere giornate tagliando da Vhs porno le parti in cui compaiono volti maschili, e copiando ciò che resta su un altro Vhs; costruendo, dunque, scegliendo. Scegliere cosa guardare, quando guardare, quanto a lungo guardare.
L’attesa è stata bandita, i concetti di plot e fabula, per quanto vuoti, superati; ci troviamo immersi direttamente nel cuore della situazione – l’atto sessuale pratico e praticato.
Sgambati porta a queste riflessioni soprattutto attraverso tre macro sezioni in cui il libro è diviso: Da “Forza Chiara” a Belén Rodriguez; Dai film porno ai filmati porno e Siamo tutti malati?. La prima tratta due fenomeni diametralmente opposti: Chiara da Perugia, ragazza poco più che adolescente, ripresa dal fidanzato ventenne, entrambi «non particolarmente belli, neanche fatti tanto bene», episodio che secondo l’autore ci iniziò al video porno amatoriale e che ci preparò involontariamente a quello di Belén Rodriguez non ancora maggiorenne, e al rapporto complesso di immedesimazione nei confronti del modello argentino che è con lei e che in quel momento sta «operando una sintesi tra tutto quello che desidereremmo e tutto quello che non avremo mai».
Della seconda, la più breve, e probabilmente il cuore del libro, si è parlato, in parte, in precedenza trattando del rapporto film porno-filmato porno, arricchita un elenco di termini che si sono diffusi (basti pensare alla parola blowjob) o che sono nati, veri e propri “neologismi”, in seguito a YouPorn (l’acronimo POV, che sta per Point Of View) con accanto spiegazioni che non entrano nello specifico, ma che possono essere d’aiuto per i neofiti.
La terza parte è l’incontro dell’autore con Emilio Lambiase, psicoterapeuta che si occupa di problematiche sessuali in genere e di disturbi ossessivi gravi. La domanda che si pone Sgambati è: a quali conseguenze può portare un uso eccessivo di YouPorn? Lambiase risponde che «i canoni estetici si modificano, si modifica il percorso di corteggiamento che rischia di risultare timoroso e timido oppure, al contrario, eccessivamente sfacciato, perché l’obiettivo sessuale diventa troppo precoce, nel desiderio o nel timore di fallire».
A completare il tutto, la prefazione di Enrico Remmert e tre brevi contributi di Gaja Cenciarelli, Roberto Moroni e Carolina Cutolo.
Fenomenologia di YouPorn è originale, divertente, ma soprattutto coraggioso: per trattare di un surrogato del sesso, di un’attività che nell’immaginario collettivo ha dei connotati di immoralità, di meschinità, di sudiciume, ma soprattutto di profonda e incolmabile solitudine, bisogna essere ben allenati, e Sgambati lo è. In qualche modo, un’opera d’avanguardia.
(Stefano Sgambati, Fenomenologia di YouPorn, Miraggi edizioni, 2012, pp. 144, euro 14,90)